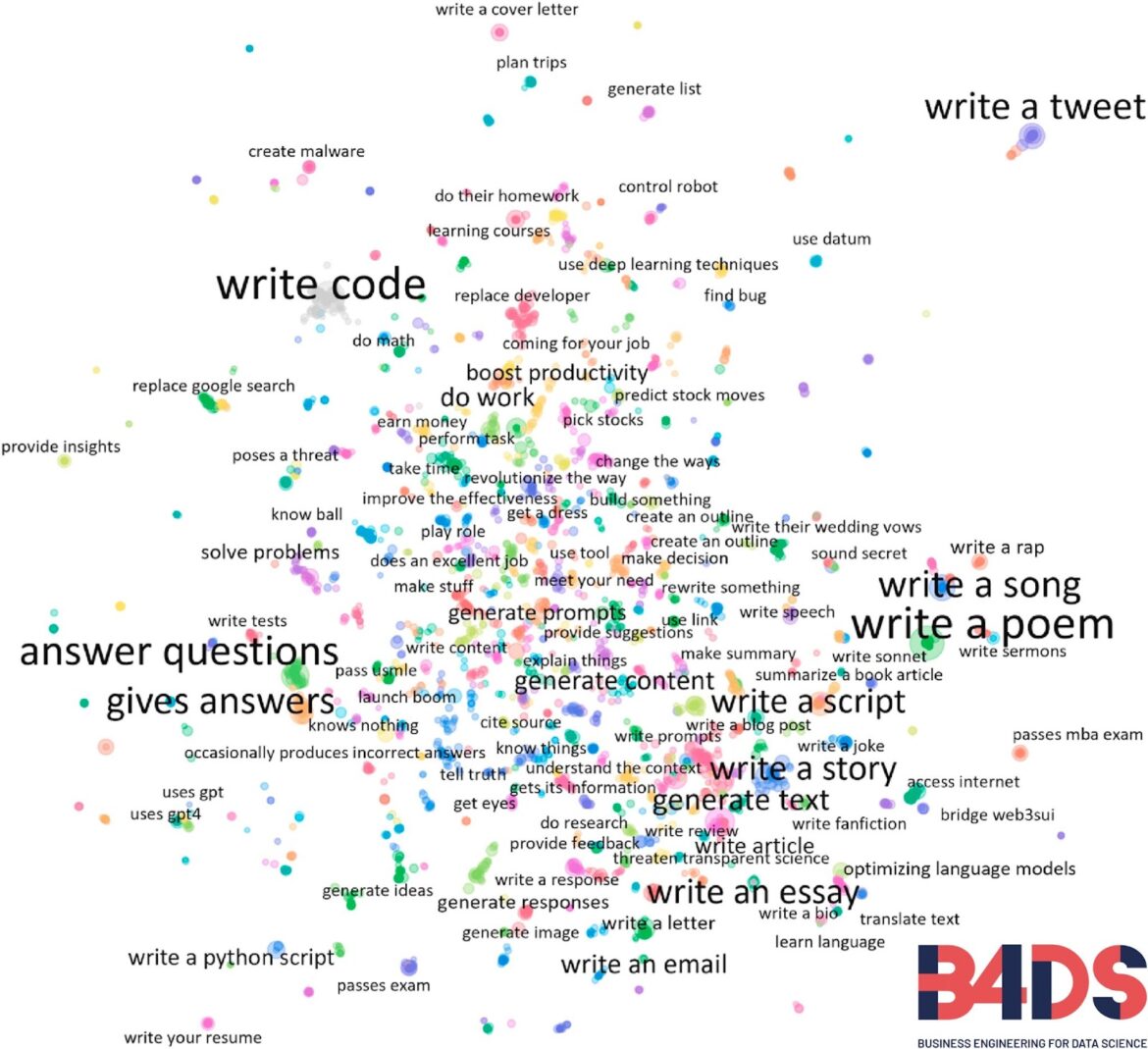Arriva la prima membrana bio-ispirata che rende potabili le acque contaminate da arsenico
Lo studio dell’Università di Pisa in collaborazione con l’Università della Calabria e l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane del CNR pubblicato sulla rivista Nature Water
Per la prima volta sarà possibile rendere potabile l’acqua contaminata da arsenico grazie ad una innovativa membrana. La notizia arriva da una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Water (della collana Nature Portfolio) e realizzata dall’ateneo pisano in collaborazione con l’Università della Calabria e l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane del CNR.
La chiave di tutto è in un “monomero”, cioè una molecola che può essere incorporata in un polimero, che è stato sintetizzato nel gruppo “Liquidi Ionici” del Dipartimento di Farmacia dell’Ateneo pisano formato dai professori Christian Silvio Pomelli e Lorenzo Guazzelli. In particolare, la struttura del monomero è stata ispirata dal modo in cui l’arsenico interagisce con le proteine negli esseri viventi.
“Abbiamo incorporato il monomero all’interno di una membrana polimerica con cui sono stati realizzati i filtri che, a livello di laboratorio, si presentano come dei dischetti porosi attraverso i quali viene filtrata l’acqua – dice Lorenzo Guazzelli – Rispetto ad ogni altro sistema esistente, questa particolare membrana è in grado di rimuovere selettivamente l’arsenico senza privare l’acqua di altri sali fondamentali. L’acqua così filtrata non viene demineralizzata e diventa quindi potabile e direttamente adatta per il consumo umano”.

L’arsenico è uno degli elementi più tossici presenti in natura ed è stato classificato cancerogeno di classe 1 dall’OMS, che ne ha anche stabilito il limite massimo accettabile nelle acque potabili in 10 microgrammi per litro (μg/L).
La contaminazione di fiumi e laghi può dipendere dall’inquinamento o avere cause naturali, specie nelle aree vulcaniche dove le acque passano su rocce che rilasciano questo elemento chimico. I bacini del Gange e del Brahmaputra in India sono fra le regioni più vaste del pianeta interessate da questo problema. Ma l’acqua contaminata da arsenico è un problema anche in Italia e, per esempio, riguarda quasi un milione di persone fra Toscana e Lazio.
“Dal punto di vista chimico l’arsenico si presenta in diverse forme – dice Christian Silvio Pomelli – la membrana sviluppata nell’ambito del nostro studio si è dimostrata particolarmente efficace anche nei confronti dell’arsenico III o arsenito, che in generale è anche la forma più difficile da rimuovere e la più tossica”.

L’arsenico è uno dei dieci contaminanti con il maggior impatto ambientale secondo la World Health Organization. La disponibilità di acqua potabile di buona qualità è sempre di più un tema all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale. La ricerca che ha portato alla realizzazione della membrana è iniziata nel 2017 ed è andata estendendosi negli anni anche per la necessità di coordinare i tanti ricercatori sparsi in diversi continenti. Per affrontare la questione a livello globale, la collaborazione è stata infatti estesa in campo internazionale arrivando ad assemblare un gruppo di lavoro di dimensione planetaria. Per l’Italia, oltre all’Università di Pisa, hanno collaborato il professore Bartolo Gabriele e la professoressa Raffaella Mancuso del Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche dell’Università della Calabria, e il gruppo di ricerca di Alberto Figoli e Francesco Galiano dell’Istituto per la Tecnologia delle Membrane del CNR di Rende (CS).
L’articolo sulla prima membrana bio-ispirata che rende potabili le acque contaminate da arsenico, pubblicato su Nature Water, è dedicato alla memoria della professoressa Cinzia Chiappe (1960-2019), fondatrice del gruppo “Liquidi Ionici” e figura importante nel campo della Green Chemistry in campo italiano ed internazionale.
Testo e foto dall’Unità Comunicazione Istituzionale dell’Università di Pisa.