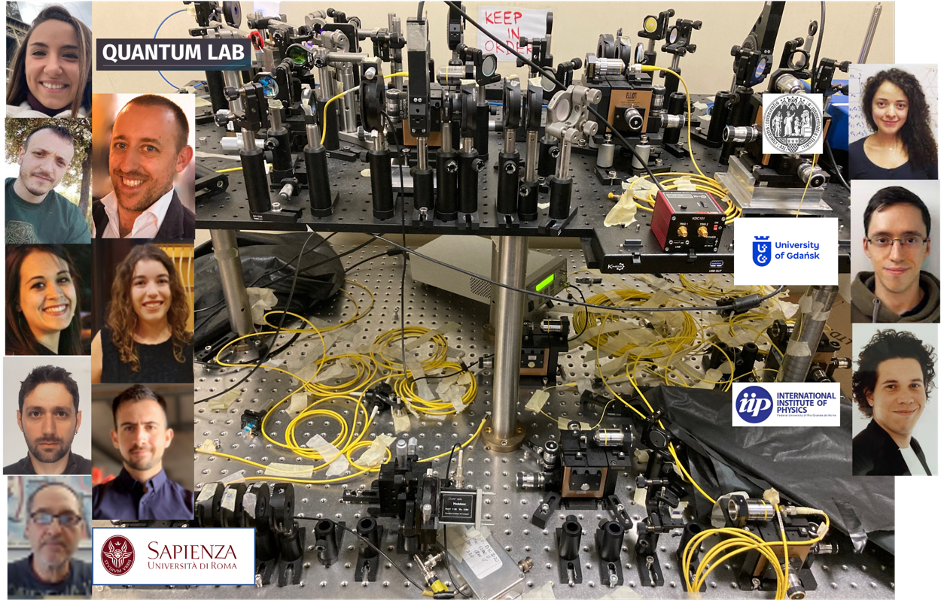Prebunking: il debunking preventivo sulle elezioni può contribuire a ricostruire la fiducia nel processo elettorale
Comunque la si pensi, viviamo tempi interessanti ma certo non facili: i conflitti sembrano aumentare sanguinosi non solo tra Stati, ma anche all’interno degli stessi. Comunque la si veda, si diceva, perché poi sulle macerie della fiducia, dei principi condivisi e della coesistenza sociale qualcuno in ogni caso dovrà governare.
A rischio è pure l’integrità del processo elettorale, uno degli elementi alla base dell’alternanza, dei principi democratici e della convivenza nella società civile. È successo con le elezioni negli Stati Uniti del 2020 e quelle del 2022 in Brasile: in entrambi i casi, a seguito della sconfitta, è stato messo in discussione il processo elettorale stesso, con la diffusione di accuse di frode elettorale contro i vincitori. Un problema che appare più attuale che mai, con la prospettiva delle elezioni prossime venture.
Un nuovo articolo, pubblicato sulla rivista Science Advances, parte proprio dai due suddetti eventi paralleli, mostrando meccanismi efficaci nel combattere la disinformazione e nel ripristinare la fiducia nel processo elettorale stesso.
In tal senso, la ricerca ha preso in esame due approcci diversi, entrambi accomunati dal fornire comunque informazioni corrette:
- prebunking, ovvero la condivisione di informazioni fattuali prima del verificarsi dei fenomeni di disinformazione;
- le correzioni da fonti credibili, sulla base della situazione di riferimento, ovvero quando vengono da chi appartiene al proprio punto di vista e parla contro i propri interessi particolari.
Entrambi gli approcci, pur partendo da meccanismi psicologici differenti, si sono dimostrati efficaci nel contrastare le affermazioni false.
Differentemente dal debunking, che avviene dopo la campagna di disinformazione e che ha dimostrato avere un’efficacia limitata, il prebunking agisce prima e informa brevemente delle cospirazioni circolanti. Una sorta di vaccino contro le stesse. Una particolare forma di prebunking, denominata inoculazione (incidentalmente, un termine abusato da chi sparge disinformazione, con tutt’altro valore) mette ad esempio in guardia preventivamente, rispetto a determinati problemi o tecniche retoriche.
Nel caso delle correzioni da fonti credibili, la campagna di disinformazione è già avvenuta: in casi del genere, chi magari è della stessa fazione politica e parla contro i propri interessi, può più facilmente convincere a non seguire il leader del proprio gruppo, in difesa dell’integrità del processo elettorale.
Lo studio non è andato ad esaminare questi approcci in relazione ad altri fattori demografici. A parere di chi scrive, sarebbe stato interessante vedere i risultati, ad esempio, rispetto a chi ha alle spalle studi di diritto o altre materie correlate, quando la disinformazione in ambito elettorale tocca temi sui quali c’è una competenza acquisita. D’altra parte – come spiegato da Brendan J. Nyhan alla stampa – in letteratura ci sono studi che ci mostrano come in questi casi ci possano essere sorprese.
Gli autori della ricerca su Science Advances hanno quindi effettuato tre studi per mettere alla prova i risultati di prebunking e correzioni da fonti credibili da un punto di vista quantitativo.
Il primo studio ha riguardato 2.643 persone in prospettiva delle elezioni Midterm del 2022 e ha impiegato i due approcci. Il secondo studio si è similmente svolto in Brasile, coinvolgendo 2.949 persone dopo le elezioni del 2022.
In questi due contesti, nei quali la fiducia nel processo elettorale è stata messa in discussione anche con campagne di disinformazione, entrambi gli approcci hanno mostrato di funzionare, ma in particolare il prebunking, che ha prodotto risultati apparentemente duraturi.
Un terzo studio ha coinvolto 2.030 persone e ha voluto verificare – negli Stati Uniti – come funzionasse un messaggio di avviso che condivideva le cospirazioni. Messi a confronto, il prebunking senza esposizione alle cospirazioni ha dimostrato di funzionare meglio, probabilmente perché l’esposizione alle cospirazioni potrebbe aver introdotto dello scetticismo rispetto agli elementi fattuali mostrati in seguito. Il prebunking con esposizione alle cospirazioni ha però migliorato il discernimento tra affermazioni vere e false. Fondamentale sembra invece essere il contenuto fattuale fornito contro la disinformazione, piuttosto che il messaggio di avviso. Entrambe le tattiche hanno funzionato meglio con chi era maggiormente disinformato.
Una delle autrici della ricerca, Natalia Bueno, ha commentato che entrambi gli approcci si sono rivelati promettenti, essendo pratici, efficienti e scalabili, oltre che poco costosi.
In tutta onestà, per quanto siano passati solo pochissimi anni dagli eventi oggetto della ricerca, sembrano essere passate ere geologiche nell’attuale politica statunitense e si potrebbe far fatica ad essere così ottimisti. Questo anche in considerazione del fatto che il secondo degli strumenti in oggetto, quello delle correzioni da fonti credibili, è stato ampiamente utilizzato negli anni successivi al 2020 e pure durante le ultime presidenziali. Vero è che tra i due strumenti sarebbe stato quello dai risultati meno duraturi.
Oppure si tratta semplicemente di una questione meramente quantitativa, di forze in campo e di peso di questi elementi nelle decisioni.

Riferimenti bibliografici:
John M. Carey, Brian Fogarty, Marília Gehrke, Brendan Nyhan, Jason Reifler, Prebunking and credible source corrections increase election credibility: Evidence from the US and Brazil, Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.adv3758