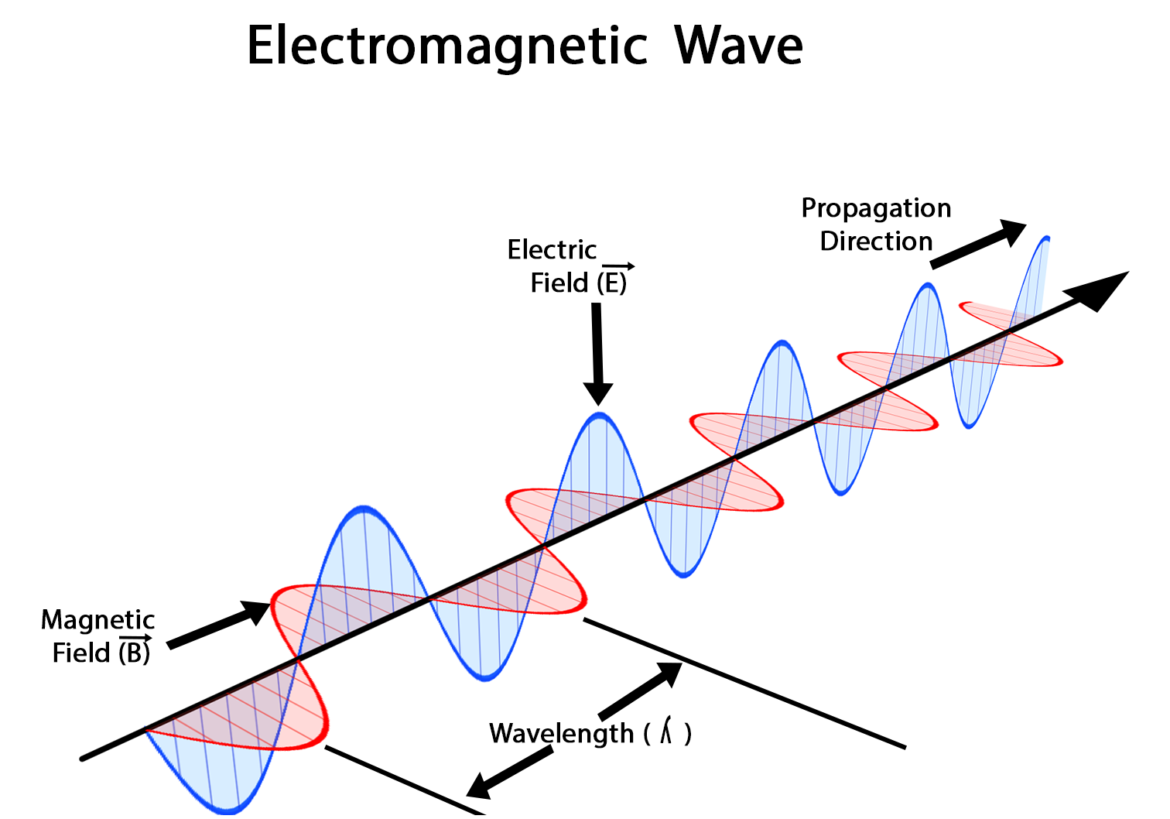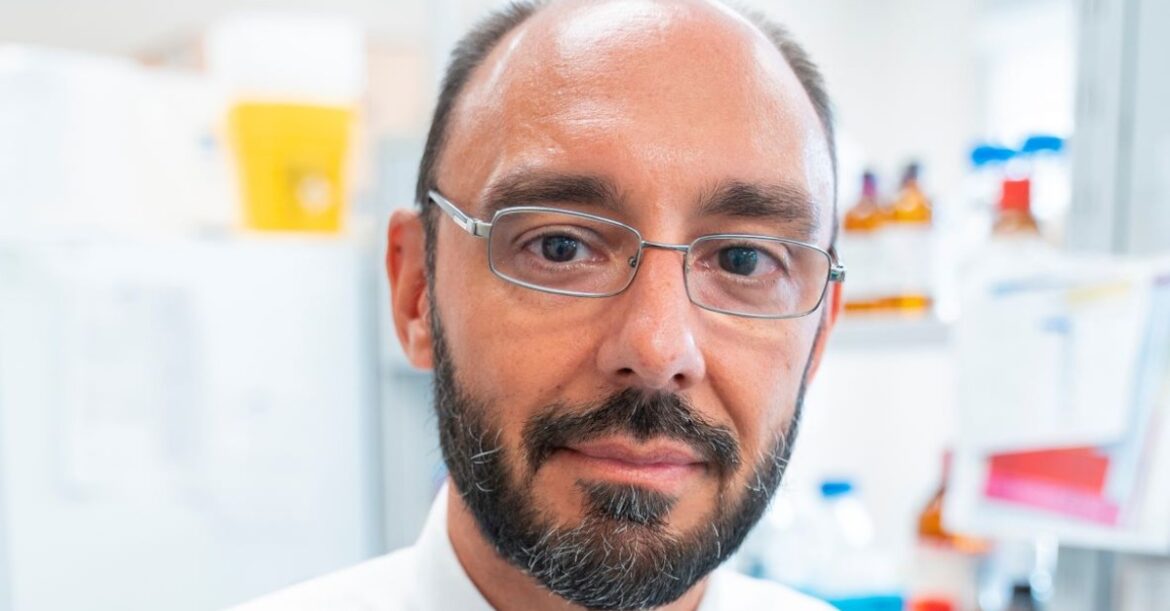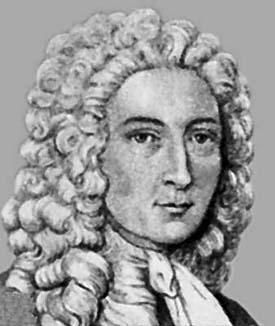Ciclo sonno-veglia: a regolarlo anche le cellule immunitarie
Un team internazionale di ricercatori coordinati dal Dipartimento di Fisiologia e farmacologia della Sapienza, ha identificato in alcune cellule coinvolte nel sistema immunitario del cervello un ruolo centrale anche nella regolazione del ciclo sonno-veglia. I risultati dello studio, pubblicato sulla rivista Glia, aprono a nuove prospettive di studio sul funzionamento del cervello.

Il sonno è un fenomeno universale nel regno animale che da un lato ha una funzione ristorativa, permettendo il recupero delle energie spese durante la veglia e la rimozione dei prodotti di rifiuto, e dall’altro ha un ruolo fondamentale nei processi cognitivi e nell’elaborazione delle informazioni. Durante il sonno, infatti, si verificano processi computazionali come la formazione e il consolidamento della memoria relativa a eventi avvenuti durante la veglia, così come le alterazioni o la deprivazione di sonno possono comportare disturbi cognitivi.
Sebbene sia stato dimostrato che l’alternanza del ciclo sonno-veglia è regolata sia da stimoli interni (orologio biologico principale, localizzato nel nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo) e da stimoli esterni (come il ciclo buio-luce, l’attività lavorativa o i pasti), i meccanismi cellulari alla base del ciclo sonno-veglia sono in parte ancora sconosciuti.
In questa cornice di ricerca si inserisce un nuovo studio coordinato da ricercatori del Dipartimento di Fisiologia e farmacologia della Sapienza, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina molecolare dell’Ateneo, il Consiglio nazionale delle ricerche e altre università e centri di ricerca internazionali, nel quale viene dimostrato per la per la prima volta il ruolo delle cellule della microglia nella regolazione del ciclo sonno-veglia.
Queste cellule si occupano della difesa immunitaria attiva nel sistema nervoso centrale e, secondo il lavoro pubblicato sulla rivista Glia, contribuiscono anche a regolare la durata del sonno, grazie alla loro interazione con le cellule nervose.
“La microglia – spiega Cristina Limatola di Sapienza, coordinatrice dello studio – regola la durata della fase di sonno nei topi anche attraverso il recettore per chemochine CX3CR1, altamente espresso in queste cellule dove svolge importanti ruoli durante sviluppo e maturazione del sistema nervoso centrale”.
“I modelli animali in cui la microglia è stata eliminata attraverso il trattamento con un antagonista del recettore CSF1R, oppure che manchino del recettore CX3CR1 sulla microglia – aggiunge Limatola – mostrano un aumento della fase non-rapid eye movement (NREM) del sonno, durante le ore di veglia associata ad alterazioni della trasmissione sinaptica a livello dell’ippocampo, regione fondamentale per la formazione della memoria a lungo termine”.
Questo lavoro aiuta a svelare i meccanismi alla base della regolazione del ciclo sonno-veglia e apre a nuove prospettive sul ruolo delle cellule della glia nel funzionamento del cervello.
Riferimenti:
Microglia modulate hippocampal synaptic transmission and sleep duration along the light/dark cycle – Giorgio Corsi, Katherine Picard, Maria Amalia di Castro, Stefano Garofalo, Federico Tucci, Giuseppina Chece, Claudio del Percio, Maria Teresa Golia, Marcello Raspa, Ferdinando Scavizzi, Fanny Decoeur, Clotilde Lauro, Mara Rigamonti, Fabio Iannello, Davide Antonio Ragozzino, Eleonora Russo, Giovanni Bernardini, Agnès Nadjar, Maria Eve Tremblay, Claudio Babiloni, Laura Maggi, Cristina Limatola – Glia 2021 Sep 6 DOI: 10.1002/glia.24090
Testo dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma