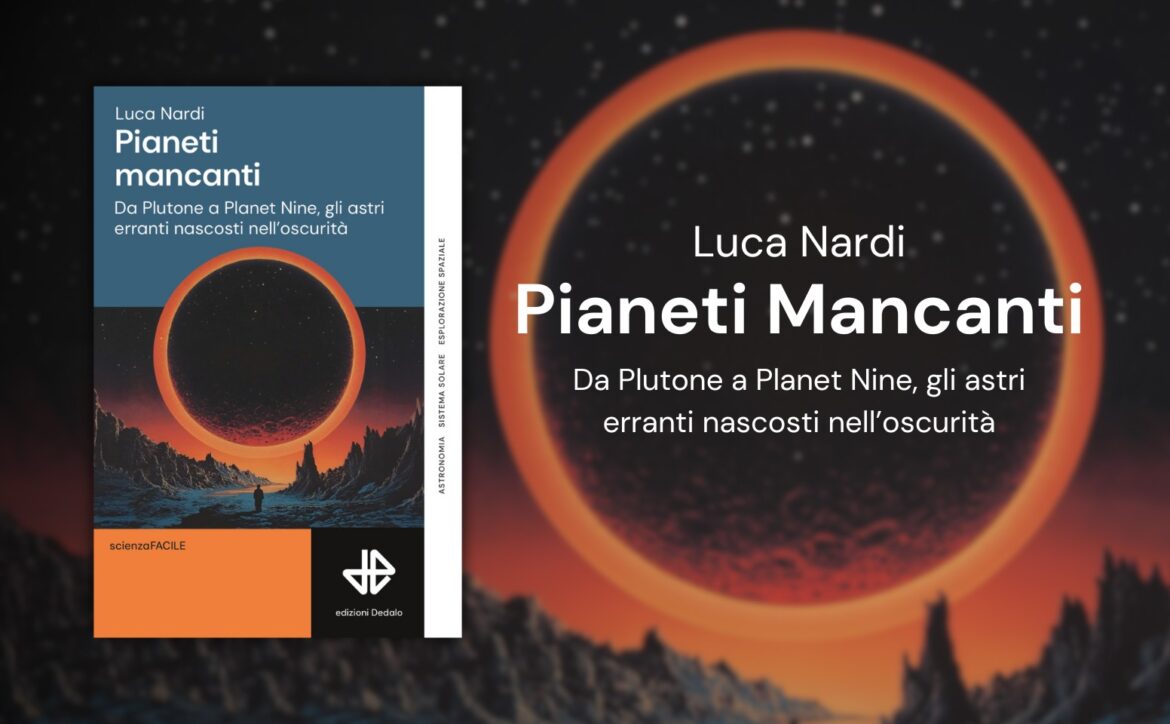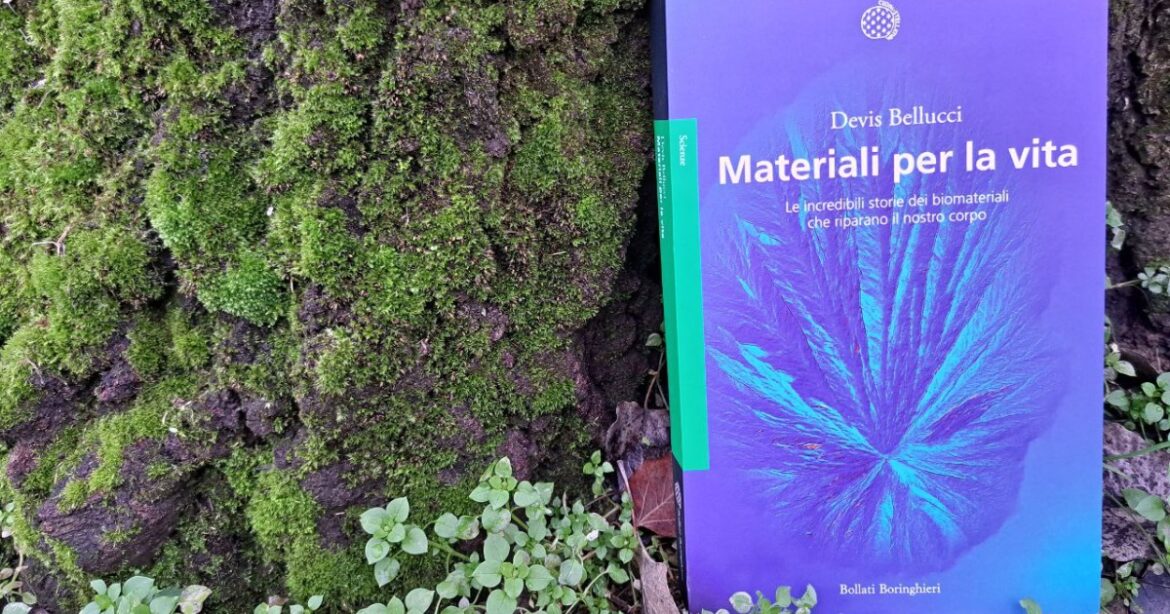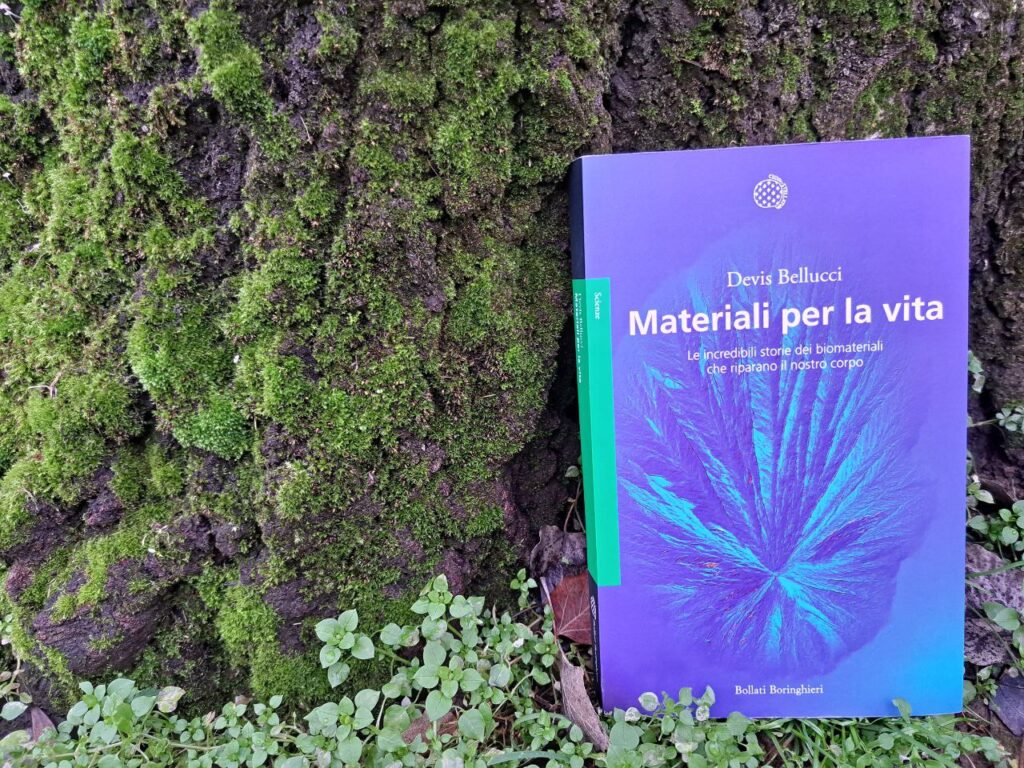Del coraggio e della passione – L’avventurosa storia di Adelasia Cocco, la prima donna medico condotto nell’Italia contemporanea (1914-1954), saggio di Eugenia Tognotti – Intervista
Clicca qui per il commento a cura di Carmen Troiano
Clicca qui per l’intervista a Eugenia Tognotti, a cura di Carmen Troiano

–
Commento al libro, a cura di Carmen Troiano
Il saggio “Del coraggio e della passione” di Eugenia Tognotti accompagna il lettore nella Sardegna di inizio Novecento per presentargli Adelasia Cocco, la prima donna medico condotto nell’Italia contemporanea.
“Ho dovuto lottare contro tutti, in un ambiente talvolta ostile che voleva il sesso debole relegato tra i fornelli di casa (pag.9).”
Si dice medica o medichessa?
Secondo l’Accademia della Crusca, possono essere utilizzate entrambe le forme, attestate nella letteratura fin dai primi secoli. Per esempio, le Mulieres Salernitanae, le dame della Scuola Medica di Salerno dell’XI secolo, di cui è famosa la medica Trotula de Ruggiero, che esercitavano l’arte medica. Tuttavia, la forma medichessa rimanda alla medicatrice, cioè una persona che svolgeva attività e pratiche dell’arte medica del passato ma che oggi sono assenti dalla professione (per esempio, sacerdotessa guaritrice, persona dotata di poteri magici). Anche dal punto di vista fonetico, si suggerisce l’uso della forma medica rispetto a medichessa.

Il testo “Del coraggio e della passione”, edito da FrancoAngeli, chiarisce il dubbio su chi sia stata la prima medica condotta dell’Italia unita. Oltre alla vicenda biografica, il volume rende merito al lavoro della dottoressa Adelasia Cocco e fornisce al lettore un quadro d’insieme della vita sociale e politica, nonché del sistema sanitario da fine Ottocento agli anni Cinquanta del XX secolo, passando per due guerre, la Spagnola e la dittatura fascista. La prof.ssa Tognotti cita studiose e studiosi italiani che si sono distinti in diversi campi della medicina: luminari, sconosciuti ai più, ma che mettono in luce la vivacità scientifico-culturale del tempo. A volte, in campi in cui l’Italia è stata pioniera. La storia che viene narrata nel libro ci aiuta a comprendere il difficile cammino delle donne nel rivendicare i loro diritti e il loro spazio nella scienza.
“Adelasia era un medico condotto e i suoi meriti riguardano l’ambito dell’assistenza e della cura: la sua battaglia ha riguardato il retaggio storico e un’organizzazione discriminatoria che stabiliva l’identità sociale di un uomo e di una donna, legittimando le disuguaglianze che ne costituivano il substrato (p. 9).”
Il libro è ricco di note bibliografiche e ha un lessico curato, specifico e settoriale. Gli argomenti sono divisi in sette sezioni, ciascuna delle quali inerente una fase della vita di Adelasia Cocco.
Dopo la prefazione di Rosy Bindi, ci si immerge nella Sardegna di oltre un secolo fa, dove si manifesta il conflitto con la società patriarcale. Il volume non rende merito solo alla “medichessa” Cocco, ma anche a tutte quelle giovani donne che, tra fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, perseguirono la scelta di andare all’università. L’autrice, quindi, soprattutto nelle prime due sezioni, nomina tante mediche i cui nomi non ci dicono niente. Il merito del libro è proprio questo: dare voce a chi ha superato brillantemente un percorso a ostacoli per sentirsi pari dei colleghi.
“Adelasia sapeva da dove veniva e dove voleva arrivare.”

Adelasia a 22 anni è sposata e si trasferisce a Pisa per studiare medicina. Immergetevi nell’epoca e pensate al sentire comune: una donna che si accosta ad un corpo maschile nudo da sezionare e/o visitare. Non rinuncia al suo obiettivo. Ciò è reso possibile anche al gruppo eccezionale di docenti che l’accompagnarono negli anni della sua formazione: Rina Monti (zoologia e anatomia comparata), Guglielmo Romiti (anatomia), Giovanni Arcangeli (botanica).
“Le prime laureate in medicina avevano un bagaglio di formazione pari o superiore a quello dei loro colleghi maschi.”
Adelasia Cocco era assetata di conoscenza e questo l’ha spinta a formarsi e aggiornarsi continuamente, a padroneggiare tecniche di laboratorio a cui non si era inizialmente dedicata. E continuò a farlo anche quando i pregiudizi di genere, le concezioni legate all’ideologia fascista della donna e le rivalità professionali ostacolarono i suoi progetti.
Il libro è, attraverso le vicissitudini personali e professionali di Adelasia, una lezione di resilienza. Sì, perché nella vita di Adelasia Cocco, soprattutto sotto il regime fascista, si è tentato di privarla dei suoi ruoli. E lei ha sempre risposto con la ferma volontà di mettersi alla prova, anche in campi nuovi, perché era spinta dal desiderio di conoscere e sperimentare. Oltre alla resilienza, è messa in luce anche una resistenza al partito, non ostentata, ma tenace e fermissima.
“I rapporti tra scienza e fascismo richiederebbero un lunghissimo discorso, articolato per ambiti scientifici e con un focus sul mondo accademico, col quale il fascismo ebbe un rapporto a volte difficile.”

Intervista a Eugenia Tognotti, a cura di Carmen Troiano
Nel 1914 c’erano 11554 medici condotti in Italia e una medica, Adelasia Cocco. Secondo gli ultimi dati di Almalaurea il numero di laureati in medicina e chirurgia nel 2023 è di 9403, di cui il 58,8% sono donne. Come gioire pienamente di questi dati se, spesso, non si fa memoria delle pioniere che oggi rendono possibile tutto ciò?
Non c’è dubbio sul fatto che vada riconosciuto alla prima coraggiosa pattuglia di pioniere il merito di aver aperto una strada alla femminilizzazione della professione. Tuttavia, questa, nonostante l’evoluzione culturale e gli interventi legislativi degli ultimi anni – non ha comportato una parità di genere completa, soprattutto sul piano della retribuzione e degli avanzamenti di carriera.
Per secoli il sistema patriarcale ha segnato in modo decisivo il percorso storico delle donne: in poche potevano avere accesso all’istruzione e, in aggiunta, era spesso loro precluso l’accesso alla formazione scientifica. Oltre al mancato accesso agli studi, i contributi delle donne alla ricerca scientifica sono stati tradizionalmente sottovalutati. Secondo lei, come rendere merito, in maniera adeguata, e non semplicemente celebrare, la partecipazione delle donne alla ricerca scientifica, senza cadere nella storiografia dilettantesca che sembra dilagare?
La scelta del modello biografico, prevalente in Italia, non è funzionale ad una riflessione sull’immenso contributo che, in tempi e contesti diversi, le donne hanno dato alla scienza, alla ricerca, alla destinazione pratica del loro lavoro scientifico. Anche se non mancano le iniziative, resta da approfondire il rapporto fra donne e scienza e i motivi per cui, nonostante il gap di genere si stia attenuando, siamo ancora lontani da un reale allineamento fra uomini e donne nell’approccio alle discipline scientifiche e ai percorsi professionali e di carriera ad esse collegati. Sicuramente, la presenza delle donne nella comunità scientifica è meno rada che nel passato e vissuta con minore ruvidezza e ombrosità da parte dei colleghi uomini. E, di certo, le brillanti ricercatrici di oggi, impegnate nelle Università e in centri di ricerca in importanti campi di studio, sono meno disposte a restare nell’ombra. Come avvenne per Rosalynd Franklin, la scienziata di famiglia anglo-ebraica, che contribuì, con le fotografie della diffrazione ai raggi X del DNA, alla più grande scoperta scientifica del ventesimo secolo. La giovane scienziata morì a soli 38 anni, nel 1958, quattro anni prima che i colleghi Wilkins, Crick e Watson fossero insigniti del premio Nobel. Il suo ruolo, rimasto a lungo nell’ombra, si è imposto solo di recente, dopo l’uscita in America della sua biografia che ha rivelato quanto fosse e sia difficile per una donna farsi accettare nel mondo scientifico.

“Grazia Deledda, la donna che non mise limiti alle donne” (dal titolo del Convegno svoltosi a Roma il 29 ottobre 2021, all’interno delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita della scrittrice premio Nobel per la Letteratura). Grazia Deledda nel suo libro è citata più volte. Una storia di emancipazione e di libertà. Una figura centrale nella definizione di personalità femminili dal destino diverso, ma accomunate dalla ferma volontà di essere indipendenti, autonome, artefici del proprio destino, libere. Può parlarci del legame tra Grazia Deledda e Adelasia Cocco?
L’adolescente Adelasia, il cui padre, folklorista e cultore di storia locale – era legato a Grazia Deledda da un’amicizia basata sulla scrittura e sulla condivisione di interessi culturali, fu sicuramente l’influenzata dalla scrittrice che tra Otto e Novecento viveva ancora a Nuoro, dove la famiglia si era trasferita da Sassari. La strategia di emancipazione di Grazia rappresentò per la giovanissima studentessa “un modello” a cui ispirarsi nel suo personale cammino di emancipazione. Attraverso la scrittura, infatti, Grazia era riuscita a sottrarsi all’apparato normativo sanzionatorio della comunità paesana, a lasciarsi alle spalle gli stereotipi di genere e ad affrancarsi in una società patriarcale che, alle donne – di qualunque condizione- assegnava il ruolo fisso di moglie-madre.
Qual è il messaggio principale che Adelasia dona alle ragazze di oggi?
Direi il suo affrancarsi da modelli imposti e la sua tenacia e determinazione nel lottare – anche in tempo difficili come quelli della dittatura fascista – per l’auto-affermazione e contro una condizione di disparità di genere che dopo avere attraversato, con piccoli progressi e arretramenti, diverse fasi storiche, resta ancora un obiettivo da raggiungere.
Scienza e fascismo. Il fascismo godette di una notevole popolarità in ambiente accademico. Con ciò non si vuole lasciare il lettore con l’impressione che tutti gli scienziati italiani fossero fascisti, ma bisogna ammettere che (l’Italia sembra non abbia ancora fatto i conti con il passato) la scienza italiana non abbia revisionato il suo ruolo nel periodo fascista. È tuttavia innegabile che diversi scienziati italiani aderirono effettivamente al fascismo. Secondo lei, il mondo della scienza italiano fatica a fare i conti con il passato e a far emergere verità scomode?
Il rapporto della comunità scientifica col fascismo è stato oggetto di un lungo dibattito fra gli storici della scienza, e senza dubbio meriterebbe nuovi e più approfonditi studi . Dopo la caduta del fascismo, nel triennio 1943-46 si provò a mettere in campo – con scarsi risultati – tentativi di epurare gli elementi più legati al ‘passato regime’. La comunità scientifica ne fu naturalmente investita, dal momento che le università, le accademie e gli enti di ricerca ricadevano nel dominio delle istituzioni pubbliche, salvo poche eccezioni. Tuttavia, i risultati furono quantitativamente modesti benché alcune delle personalità coinvolte fossero esponenti di prima fila del mondo accademico. A colpire, in verità, è la rapidità con cui, caduto il regime, alcune personalità tornarono a ricoprire le posizioni prestigiose occupate durante il ventennio, o perché reintegrati in fasi successive delle procedure, o perché (nel caso delle accademie e delle posizioni di governo degli atenei) rieletti dai loro colleghi. Studi mirati dalla prospettiva degli avvenimenti successivi all’epurazione, potrebbero mettere in luce aspetti e verità rimaste a lungo in un cono d’ombra.
La prof.ssa Tognotti evidenzia anche due questioni: in primo luogo, le pesanti costrizioni ideologiche (es. tema della razza) che obbligarono gli scienziati ad indirizzare le loro ricerche in modo da compiacere i desideri del regime. Basta accennare al caso dei dieci promotori del “Manifesto della razza”, documento che diede un’ignobile giustificazione pseudoscientifica alle successive leggi razziali fasciste; in secondo luogo, la riforma universitaria del settembre 1923 che introduceva anche per i professori universitari l’obbligo del giuramento di fedeltà allo Stato, già previsto per tutti i pubblici funzionari.
Eugenia Tognotti è professoressa ordinaria di Storia della Medicina e Scienze umane, saggista ed editorialista. È responsabile del Centro Studi CSAPS del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari. I suoi interessi di ricerca sono volti alla storia della medicina e della sanità, temi che sono anche al centro di un’intensa attività pubblicistica e saggistica. Tra le sue monografie Il mostro asiatico. Storia del colera in Italia (Ed. Laterza, 2000). La Spagnola in Italia, Storia dell’influenza che fece temere la fine del mondo (2ªed. FrancoAngeli 2015). Vaccinare i bambini tra obbligo e persuasione. 3 secoli di controversie(FrancoAngeli 2020).
Il libro recensito è stato cortesemente fornito dalla casa editrice.