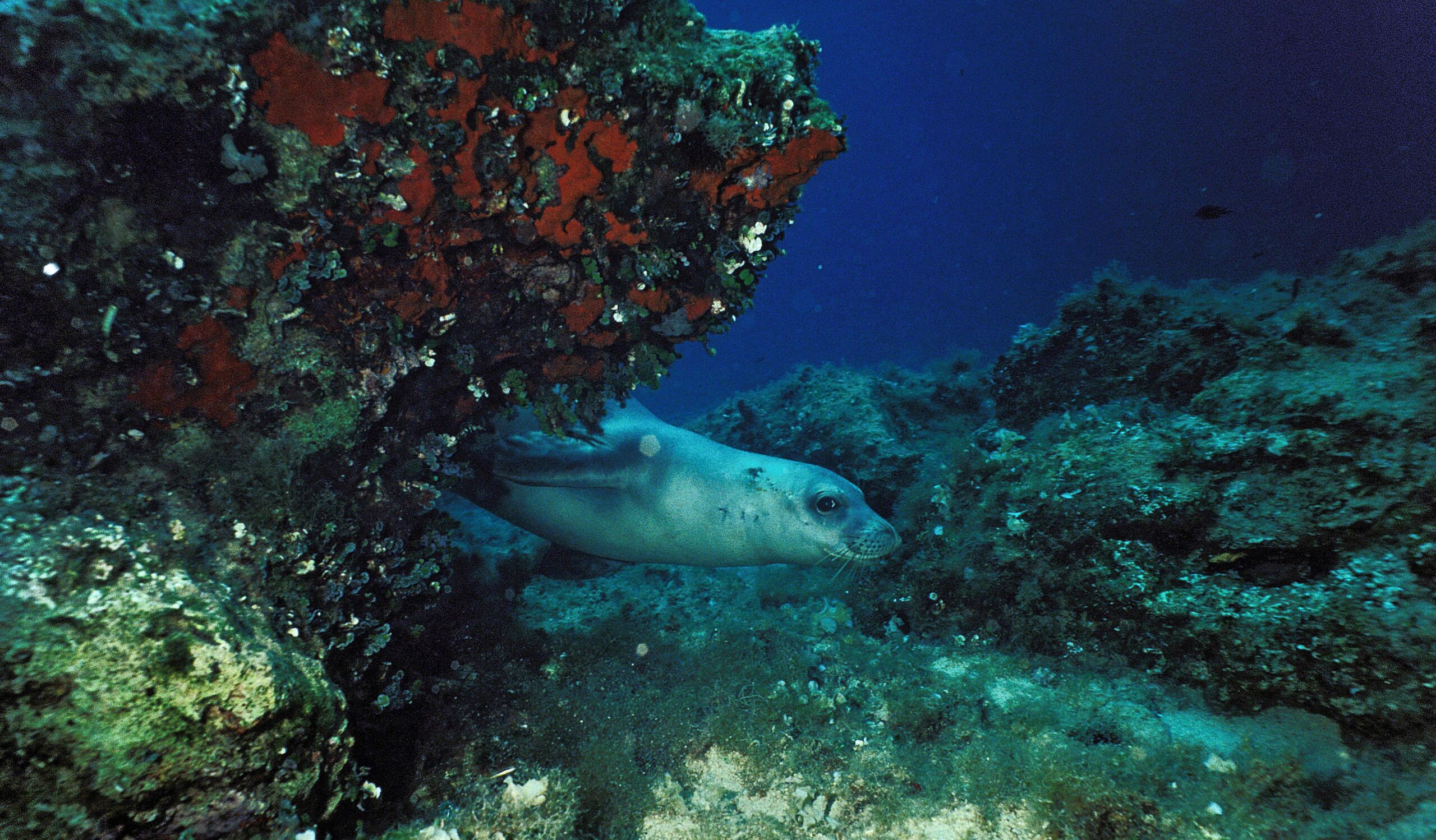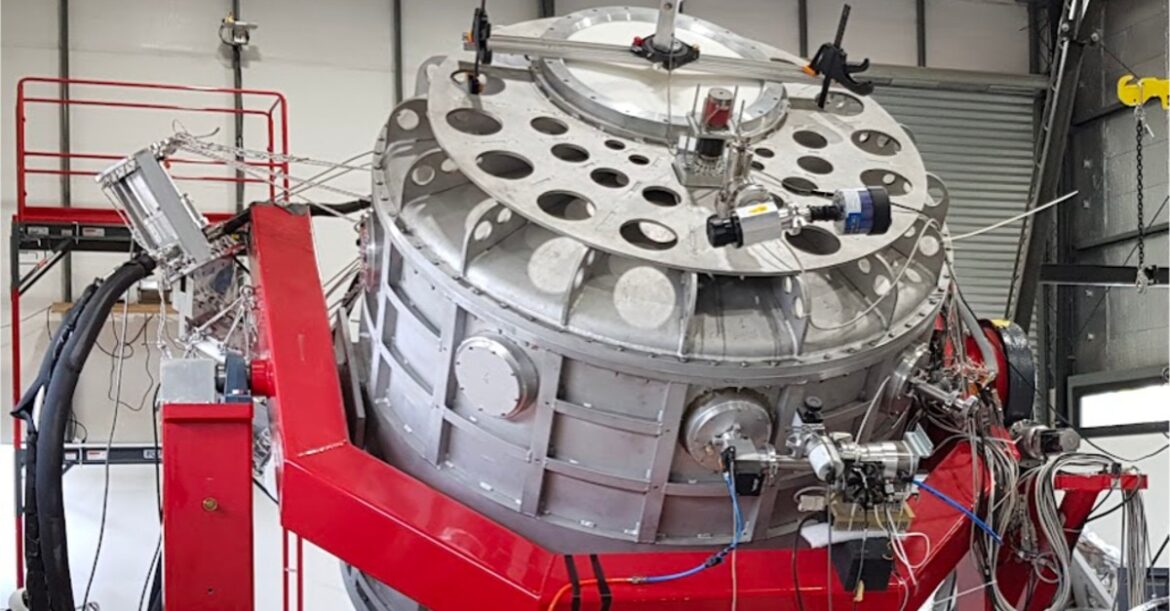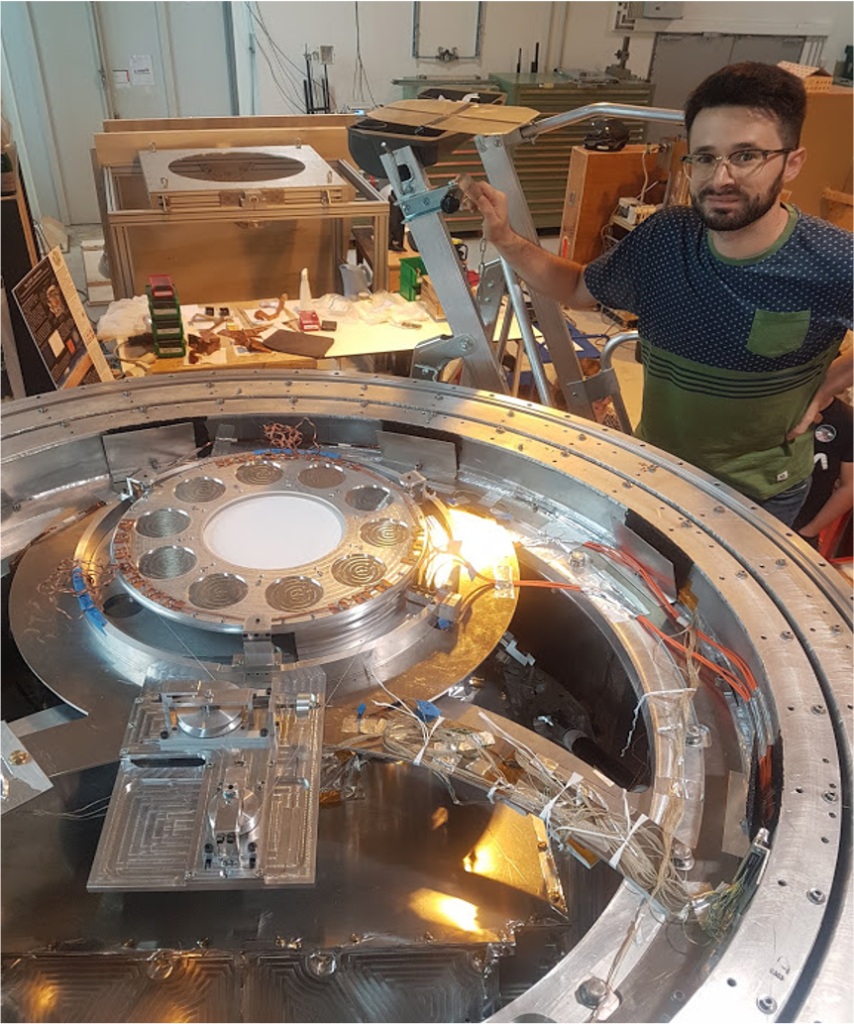Tanti ospiti e personalità all’evento SKY INCLUSION DAYS con FIGLI ≠ GENITORI per parlare di inclusione e diversità

INTERVENTI E DIBATTITI
con rappresentanti delle Istituzioni tra cui il Ministro per le Disabilità ALESSANDRA LOCATELLI
Molti i volti del mondo della cultura, dell’arte, della scienza, dell’intrattenimento e dello sport. Tra gli altri:
NICCOLÒ AGLIARDI, SALVATORE ARANZULLA, FRANCESCA BARRA, ELISABETTA DAMI, AMALIA ERCOLI FINZI, SARA GAMA, VERA GHENO, GIORGIO MINISINI, ALESSANDRO OSSOLA, AZZURRA RINALDI
Con le performance e gli interventi di artisti quali:
VINICIO MARCHIONI, OMAR HASSAN, MACIA DEL PRETE, DOMENICO CUOMO, PAOLA GIOIA KAZE FORMISANO, TOMMY KUTI
IL 14 E 15 MAGGIO 2023 A MILANO MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI

Dalle performance artistiche e i contributi di Vinicio Marchioni, Omar Hassan, Macia del Prete, Domenico Cuomo, Paola Gioia Kaze Formisano e Tommy Kuti agli interventi del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e della scrittrice Elisabetta Dami; dalle testimonianze degli sportivi Sara Gama e Giorgio Minisini, ai contributi della scienziata Amalia Ercoli Finzi e dell’economista Azzurra Rinaldi, all’atleta paralimpico Alessandro Ossola: sono solo alcuni degli ospiti del programma di “SKY INCLUSION DAYS con FIGLI ≠ GENITORI”, il primo grande evento di Sky sui temi dell’inclusione e della diversità, organizzato in collaborazione con l’associazione non profit Lidia Dice…
Due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti che si svolgeranno domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 a Milano, presso Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.
Sky, da sempre impegnata sui temi dell’inclusione e della diversità, ha scelto di supportare Lidia Dice… e il progetto Figli ≠ Genitori per realizzare insieme questa importante nuova iniziativa, un momento di confronto per sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche così importanti.
Il via ai lavori è previsto domenica 14 maggio alle 11.00 con le performances della coreografa Macia del Prete e dell’attore Domenico Cuomo. A seguire, spazio alla Festa della Mamma, all’arte con l’intervista a Omar Hassan e al racconto di storie di sport con campioni come Sara Gama e Giorgio Minisini con Daniele Cassioli, oltre a un dibattito che approfondirà il tema della parità di genere, e che vedrà coinvolte la giornalista e scrittrice Francesca Barra e l’economista Azzurra Rinaldi. La giornata prosegue con un confronto sulla libertà nell’era digitale con Padre Paolo Benanti e uno sulla paternità biologica, affidataria e adottiva con il cantautore Niccolò Agliardi e il comico Antonio Ornano. Non mancheranno un momento musicale affidato all’esibizione di Tommy Kuti e una performance dell’attore Vinicio Marchioni.
Lunedì 15 maggio, Giornata Internazionale delle Famiglie, si riparte alle 10.00 con Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi, un confronto mamma-figlia tra due generazioni di donne scienziate. Seguiranno altre storie di sport raccontate da giovani campioni e un approfondimento sul tema del razzismo e dell’antisemitismo con Michele Sarfatti. Focus sull’inclusione digitale e il progetto Sky Up che vede tra gli ospiti Salvatore Aranzulla e la tech influencer e imprenditrice digitale Fjona Cackalli. E ancora, un approfondimento sul linguaggio inclusivo con le linguiste Vera Gheno ed Elena Loewenthal e il comico Pierluca Mariti, oltre a un focus sul tema dell’autismo con Nico Acampora, fondatore di PizzAut. Non mancherà un confronto sull’inclusione nel mondo del lavoro con il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e l’atleta paralimpico e Presidente di Bionic People Alessandro Ossola. Spazio anche alla musica con una performance di Paola Gioia Kaze Formisano.
Maggiori informazioni e il programma della due giorni sono disponibili sulla pagina: https://tg24.sky.it/stories/cronaca/sky-inclusion-days-programma-ospiti-e-iscrizioni/index.html
INFORMAZIONI E PROGRAMMA SKY INCLUSION DAYS: https://inclusiondays.sky.it
L’evento sarà disponibile in diretta sul canale 501 di Sky e in streaming su skytg24.it. Collegamenti e aggiornamenti anche su Sky TG24 e su Sky Sport 24.
RTL 102.5 – radio ufficiale dell’evento – seguirà la due giorni con interviste e approfondimenti.
Per partecipare e seguire i dibattiti live è sufficiente registrarsi al seguente link https://www.eventbrite.it/e/616345354547
L’evento “SKY INCLUSION DAYS con FIGLI ≠ GENITORI” si avvale del patrocinio di Camera di Commercio Americana, Camera di Commercio Britannica, Consolato Generale Americano.
——————————————————————————————————————————–
Fra inclusione e rappresentazione, l’artista afro-italiana KAZE agli Sky Inclusion Days:
“Grata a Lisa Nur Sultan per come ha scritto la mia Sofia in Call My Agent, per la prima volta non sono una checkbox”
SONIA ROVAI: “Iniziano a breve le riprese della seconda stagione di Call My Agent – Italia”
FRANCESCA VECCHIONI di Diversity: “Tutte le produzioni devono essere inclusive, on-screen e off-screen”
Milano, 15 maggio 2023 – “Sono estremamente grata a Lisa Nur Sultan per come ha scritto il mio personaggio – Sofia, la receptionist dell’agenzia al centro del racconto della serie Sky Original – in Call My Agent – Italia, per la prima volta non ero solo una checkbox”, ha dichiarato Kaze, poliedrica artista afro-italiana, ospite insieme alla fondatrice di Diversity Francesca Vecchioni e a Sonia Rovai, Senior Director Scripted Productions Sky Italia dell’incontro «Rappresento ergo sum? Essere inclusivi sullo schermo», moderato dal giornalista di Sky TG24 Luigi Casillo nel corso dell’evento “SKY INCLUSION DAYS con FIGLI ≠ GENITORI”, organizzato da Sky in collaborazione con l’associazione non profit Lidia Dice. “La diversità del suo personaggio – spiega Sonia Rovai – è diventata portatrice di un racconto, non era solo un pretesto per spuntare una casella in fase di casting”.
Prima di Call My Agent – di cui, come annunciato da Sonia Rovai, iniziano fra poche settimane le riprese della seconda stagione – Kaze ha sostenuto decine di provini:
“Spesso andavano male e altre volte andavano bene, ma se mi prendevano è perché magari ero la spunta che andava bene, perché scartavano le ragazze con la pelle più scura della mia. Io magari avevo caratteristiche più simili all’eurocentrismo di altre, ero «diversa ma non troppo»”.
SKY INCLUSION DAYS con FIGLI ≠ GENITORI è una due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti che è iniziata ieri 14 maggio e proseguirà anche oggi 15 maggio a Milano, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, per riflettere sul tema del rapporto con la diversità in tutte le sue declinazioni: dalla parità di genere ai diritti delle persone LGBTQ+, dalla disabilità alla body positivity, dal background etnico all’inclusione digitale e a quella del linguaggio, con uno sguardo sempre attento al confronto tra generazioni e al rapporto tra genitori e figli.
Fra rappresentazione sullo schermo, il rischio della stereotipizzazione e toni pietistici da evitare, nella industry
“la situazione è ancora in evoluzione”, ha spiegato Sonia Rovai, “ma si è iniziata a fare molta formazione e comunicazione”. “Noi e Diversity – ha raccontato – ci siamo sentiti molto in questi ultimi mesi, stiamo lavorando a un workshop per tutto il team di Sky Studios, per accedere in maniera chiara ai giusti metodi per evitare di incorrere in una rappresentazione stereotipata”.
Di produzioni che devono essere quanto più inclusive possibile anche dietro le quinte, e non solo davanti alla macchina da presa, ha parlato Francesca Vecchioni:
“Abbattiamo i pregiudizi a partire non solo da chi appare sullo schermo, guardando quindi all’on-screen, ma soprattutto considerando tutta la parte di off-screen, chi lavora dietro le quinte, da chi scrive a chi comunica a chi decide, a chi lavora in produzione. Se non si riesce ad aprire tutto il mondo del lavoro alla diversità, nella costruzione del prodotto non si potrà che cadere nello stereotipo”.
Testo, video e immagini dall’Ufficio Stampa Sky. Aggiornato l’11 Maggio 2023.