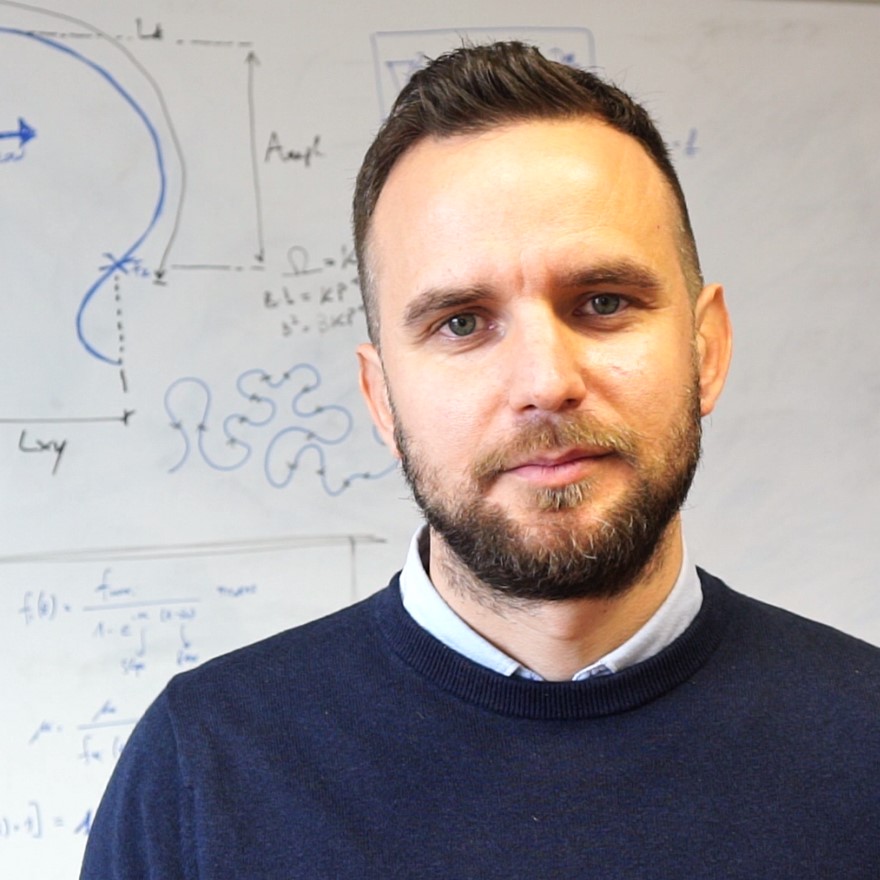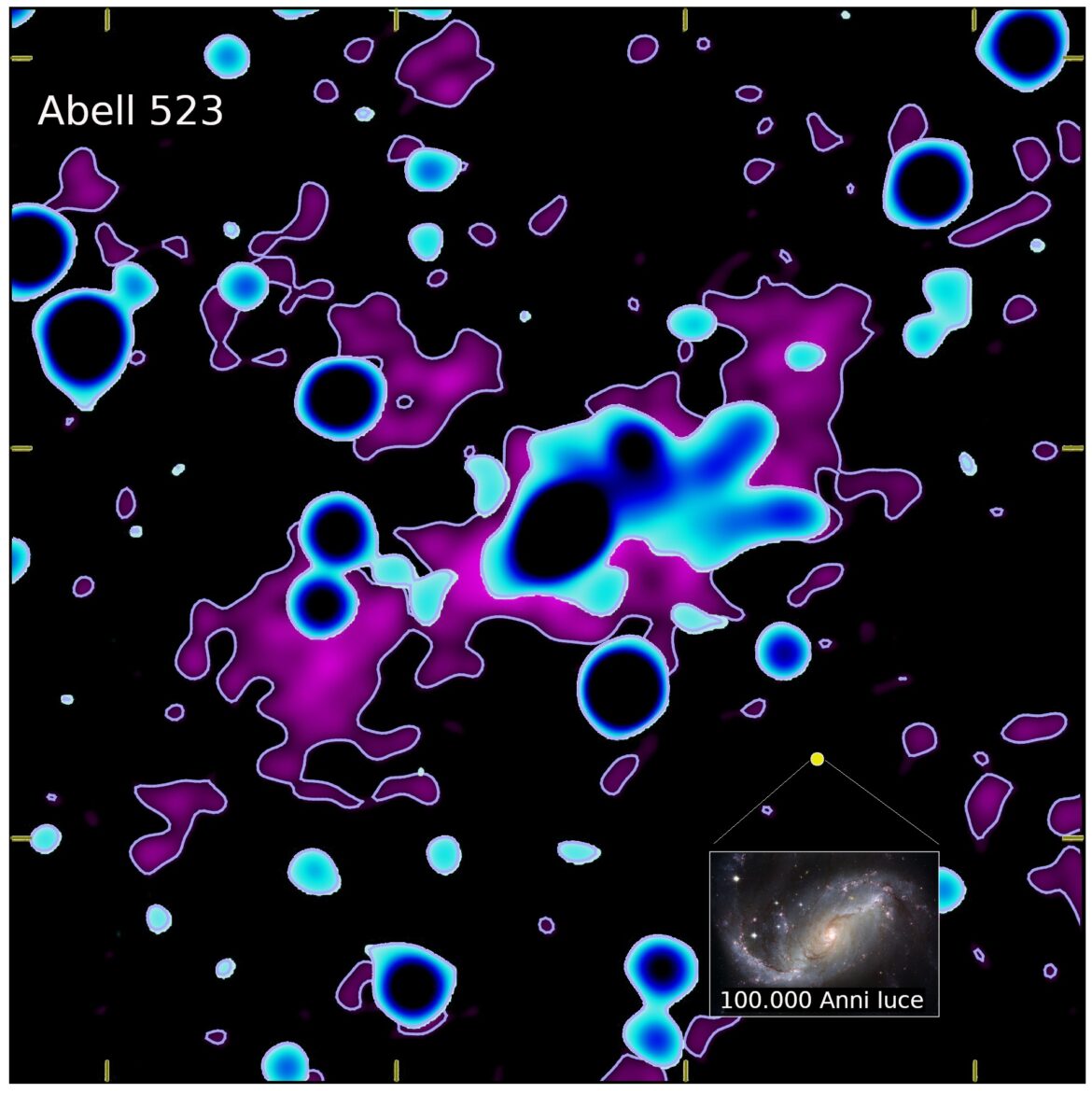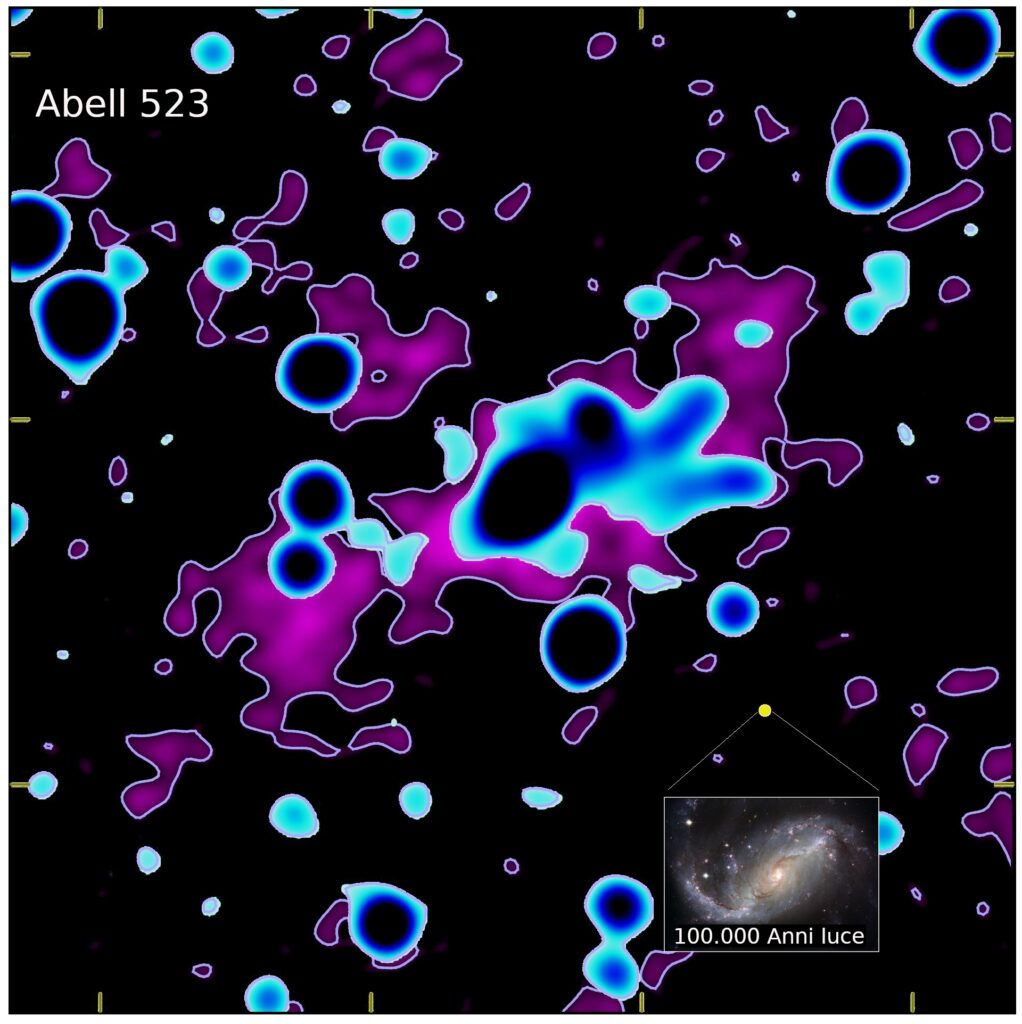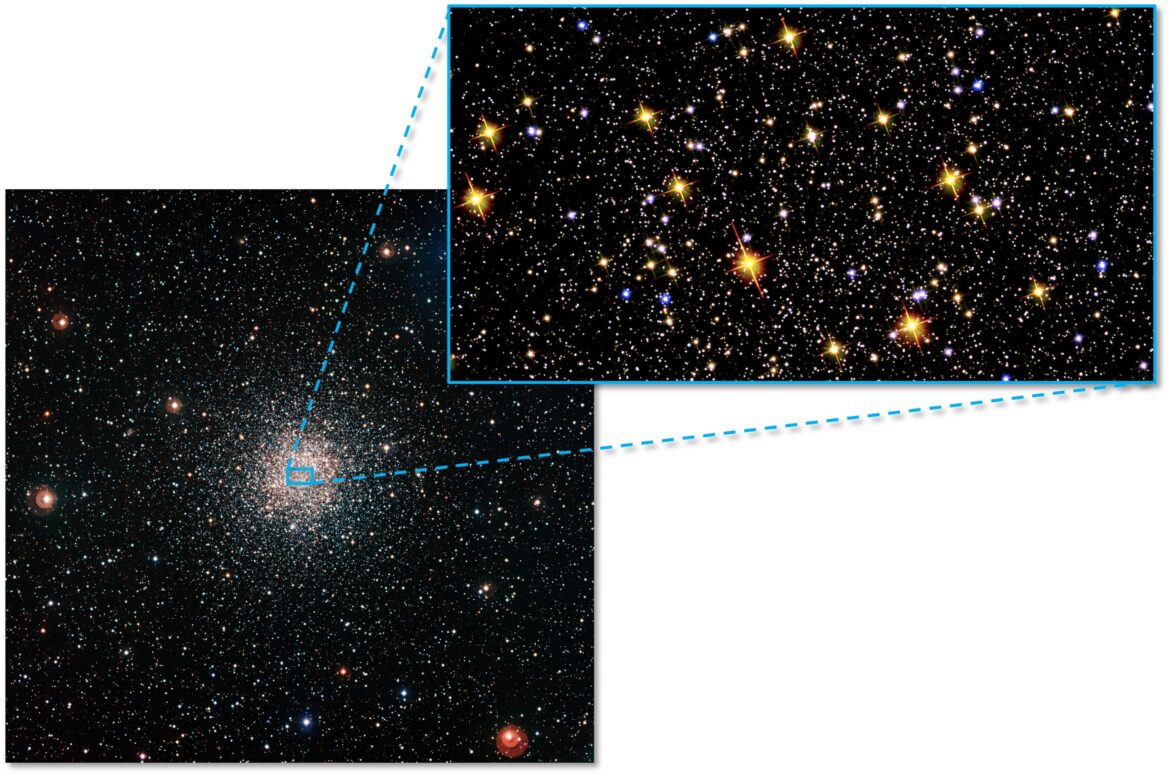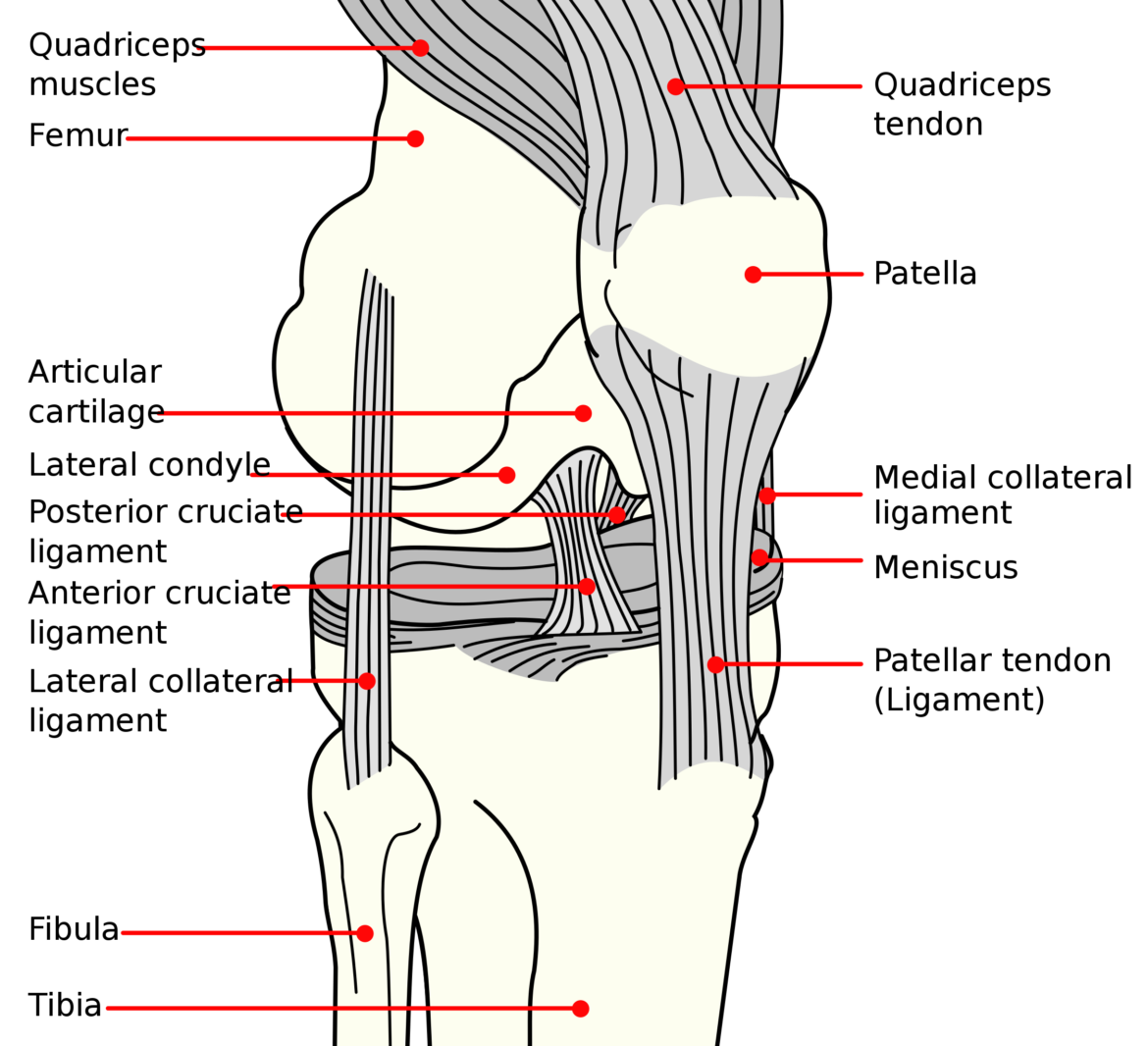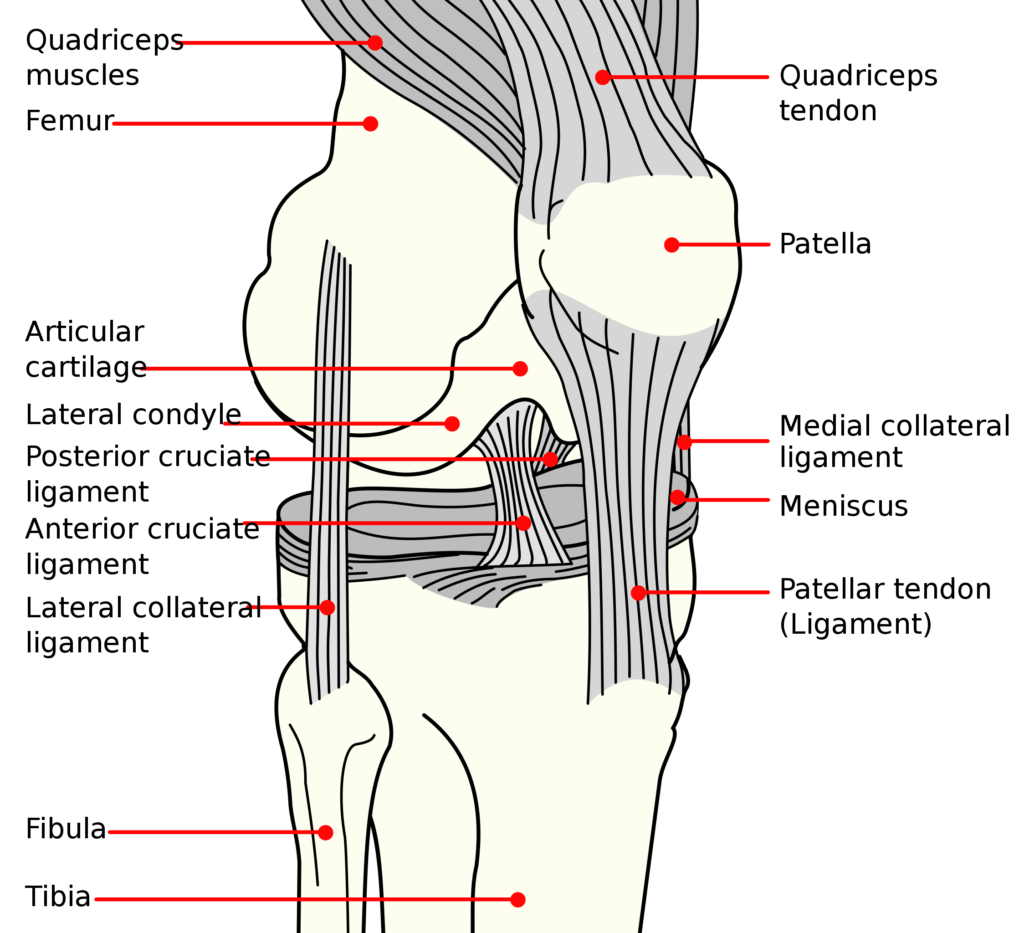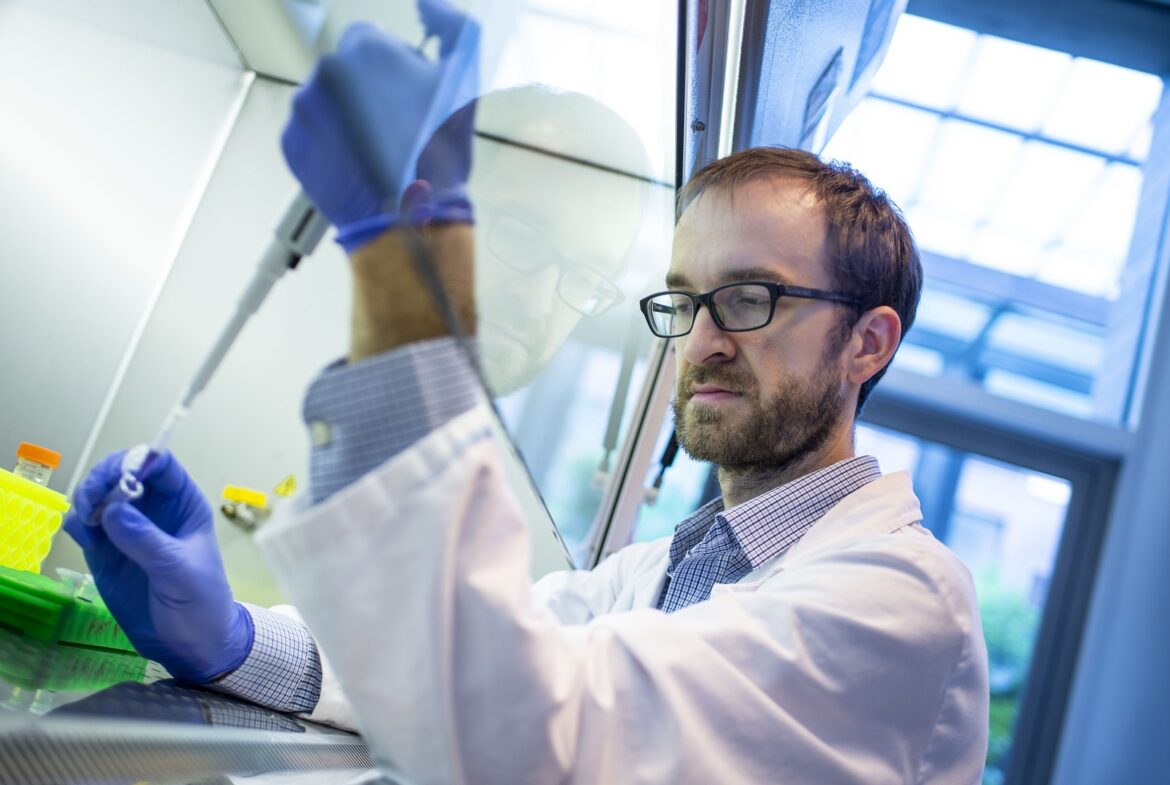AFTER WORK
un documentario per la regia di ERIK GANDINI

liberamente ispirato dagli scritti sull’ideologia del lavoro di Roland Paulsen
Durata 77’
DAL 15 GIUGNO AL CINEMA CON FANDANGO DISTRIBUZIONE
After Work – Opzioni per lo streaming
SINOSSI LUNGA
Nel 2013, due ricercatori di Oxford hanno pubblicato “The Future of Employment” (Il futuro dell’occupazione), in cui hanno analizzato la possibilità che diverse professioni vengano sostituite da algoritmi informatici nei prossimi 20 anni. Questo studio, molto citato, è giunto alla conclusione che il 47% dei lavori statunitensi è ad alto rischio. Ad esempio, c’è una probabilità del 99% che gli addetti al telemarketing e i sottoscrittori di assicurazioni perdano il loro lavoro a favore degli algoritmi. Il 97% di probabilità che entro il 2033 i cassieri saranno sostituiti da macchine. Per gli autisti di autobus le probabilità sono l’89%.
La maggior parte dei lavori esistenti oggi potrebbe scomparire nel giro di qualche anno. Man mano che l’intelligenza artificiale supera l’uomo in un numero sempre maggiore di compiti, sostituirà l’uomo in un numero sempre maggiore di lavori. Si profila un’era di disoccupazione tecnologica, in cui gli scienziati informatici e gli ingegneri del software ci toglieranno essenzialmente il lavoro, e il numero totale di posti di lavoro diminuirà in modo costante e permanente.
La nostra società è una società basata sul lavoro. Fin dall’infanzia ci viene insegnato ad essere orientati al risultato e ad essere competitivi. Mentre impariamo a lavorare, tendiamo a mettere da parte tutti gli altri aspetti dell’essere umano. Possiamo pensare a un futuro diverso?
Uno sguardo al futuro prossimo ci dice che nel XXI secolo potremmo assistere alla creazione della classe dei non lavoratori, caratterizzata da persone che si sentono irrilevanti, senza valore economico perché non possono fare nulla di meglio dell’IA o di un robot e, diventando sostituibili, potrebbero finire per essere privi di una forza politica collettiva.
Il dibattito sulle conseguenze di questa situazione è dominato da esperti di tecnologia ed economisti e spesso dipinto come una distopia fantascientifica. Ciò che manca è la prospettiva umana, nel senso di uno sguardo a ciò che questo significherà per noi come esseri umani. L’approccio di questo documentario è quindi puramente esistenziale e mira a esplorare come saremo e cosa faremo quando non dovremo più lavorare.
Il paradosso del lavoro è che molte persone odiano il proprio lavoro, ma sono molto più infelici se non fanno nulla. Oppure, sono infelici perché non guadagnano abbastanza? O perché c’è una pressione culturale intorno a loro?
Attraverso storie contemporanee, in quattro diversi angoli del mondo, After Work porta allo spettatore utili elementi per disegnare scenari futuri, raccontando aspetti iperbolici e paradigmatici dell’ideologia, dell’etica del lavoro, del rapporto tra esistenza e lavoro, in – Kuwait, Corea del Sud, Stati Uniti e Italia – società con modelli di sviluppo molto distanti tra loro.
una produzione FASAD PRODUCTION AB
PROPAGANDA ITALIA con RAI CINEMA
e INDIE FILM
CAST
Insegnante – YOO GA YEON
Fabbricante – YOO DEUG YOUNG
Proprietario del giardino di Valsanzibio – ARMANDO PIZZONI
Direttore generale del Centro sviluppo etica del lavoro – JOSH DAVIS
Filosofo – ELIZABETH S. ANDERSON
Socio dirigente di Gallup – PA SINYAN
Filosofo – NOAM CHOMSKY
Autista Amazon – ASTRID MOSS
Sceneggiatore – MEQDAD AL KOUT
Autore e professore universitario – MAI AL NAKIB
Impiegata pubblica – FATIMA
Allevatrice di cavalli – RORY MARZOTTO
Uomo d’affari – FERDINANDO BUSINARO
Sociologo – LUCA RICOLFI
Ex dipendente – JEONG BOSEONG
CREW
Regia di ERIK GANDINI
Direttore della fotografia FREDRIK WENZEL, FSF
Montaggio e Musiche JOHAN SÖDERBERG
Produttore musicale e arrangiamenti CHRISTOFFER BERG
Sound Design JØRGEN BERGSUND, RIKARD STRØMSODD
Sound recordist CHIARA ANDRICH
CREDITI
Prodotto da Fasad Production AB
In coproduzione con Propaganda Italia / Marina Marzotto a.g.i.c.i & Mattia Oddone con Rai Cinema
Indie film / Carsten Aanonsen
SVT / Axel Arnö & Asta Dalman
Film i Väst / Jenny Luukkonen
VPRO / Commissioning Editor Barbara Truyen
GEO Television / Arno Becker & Simone Theilmann
In associazione con YLE / Jenny Westergård
Con la partecipazione di RTS Radio Télévision Suisse Department of Documentaries Steven Artels & Bettina Hofmann
Con il contributo di MiC- Ministero Italiano della Cultura
Svenska Filminstitutet / Klara Grunning
Nordisk Film & Tv Fond / Karolina Lidin
Norsk Filminstitutt / Eirin Gjørv
Fritt Ord Foundation / Bente Roalsvig NRK / Fredrik Færden
Consulenti di produzione NFI Ravn Wikhaug & Benedikte Danielsen
Produttore associato Costanza Julia Bani
Produttore delegato
per Propaganda Italia Cristina Rajola
Durata 77’
Distributore Fandango
I DIVERSI STATI IN AFTER WORK
USA
‘No Vacation Nation’ – Secondo uno studio condotto dal Project Time Off della US Travel Association, nel 2018 i lavoratori americani hanno lasciato sul tavolo 768 milioni di giorni di vacanza non utilizzati. Ciò si traduce in una stima di 65,5 miliardi di dollari di mancati benefici, ovvero una media di 571 dollari per dipendente. Inoltre, lo studio ha rilevato che più della metà dei lavoratori americani (55%) non ha utilizzato tutti i giorni di ferie nel 2018 e il 24% ha dichiarato di non averne usufruito affatto. Ciò suggerisce che molti lavoratori americani non sono in grado o non sono disposti a prendere le ferie a cui hanno diritto, perpetuando la cultura del superlavoro e la reputazione di “No Vacation Nation”.
Gli americani hanno un rapporto unico con il lavoro. Il concetto di “sogno americano” è stato a lungo associato all’idea di lavorare sodo e raggiungere il successo. Questa mentalità ha creato una cultura in cui il lavoro è spesso visto come l’obiettivo finale, con poca enfasi sul tempo libero. Di conseguenza, gli Stati Uniti sono noti come la “nazione senza vacanze”. Mentre molti altri Paesi sviluppati garantiscono ai loro lavoratori ferie retribuite, negli Stati Uniti non esiste una legge federale che imponga ai datori di lavoro di fornire ferie retribuite.
KUWAIT
L’impiego pubblico in questo paese comporta privilegi unici: il rischio di essere licenziati è praticamente inesistente e le promozioni si basano sull’età anziché sul rendimento. La vita quotidiana nel settore pubblico è caratterizzata da un notevole esubero di personale e dalla mancanza di compiti. Questo modello si ripercuote sull’etica del lavoro e sulla produttività e, secondo l’OMS, il Kuwait è il Paese più fisicamente inattivo del mondo, anche se tutti hanno un impiego e sono ben retribuiti. Il sistema di distribuzione delle ricchezze petrolifere del Paese è stato paragonato a un reddito di base (UBI), ma con un impegno lavorativo ’’simulato’’ come contropartita. La scarsa intensità di lavoro in edifici all’avanguardia, il clima caldo disagevole e i vasti centri commerciali rendono il Kuwait un luogo congeniale per analizzare una probabile idea di lavoro del futuro.
COREA DEL SUD
Un’etica del lavoro unica, che affonda le sue radici nel confucianesimo, è alla base della miracolosa crescita della Corea del Sud, dalla povertà estrema al successo informatico. Tuttavia, la cultura del lavoro si è rivelata un rischio per la salute e un problema sociale che è considerato la causa del calo delle nascite, delle alte statistiche sui suicidi e del fenomeno della Gwarosa, la “morte per eccesso di lavoro”. Il ministro del Lavoro coreano Kim Joung Joo (forse l’unico ministro del Lavoro al mondo con la missione di far lavorare meno le persone) ha lanciato diverse campagne per cambiare le abitudini lavorative tossiche. A lei si deve l’iniziativa “Diritto al riposo”, che ha ridotto la settimana lavorativa da 68 ore a un massimo di 52. L’ultima direttiva del governo garantisce che i computer in tutti i principali luoghi di lavoro vengano spenti automaticamente alle 18.00. Parallelamente, vengono realizzate campagne pubblicitarie che invitano i lavoratori a non rimanere in ufficio fino a tardi. In una di queste appaiono lavoratori esausti che ricevono consigli su occupazioni alternative: cucinare, fare formazione, dipingere un quadro, passare del tempo con i bambini e la famiglia. L’immaginazione collettiva di una società sovraccarica di lavoro è esaurita al punto che sono necessarie immagini prodotte dall’esterno per ispirare idee su ciò che potrebbe essere la vita al di là del lavoro?
ITALIA
Con l’obiettivo di raggiungere un altro livello di riflessione sull’esistenza senza lavoro, l’attenzione iniziale si concentra sul piccolo gruppo di persone iper-ricche appartenenti a dinastie imprenditoriali industriali che hanno vissuto per diverse generazioni senza dover lavorare. Come si presenta la vita quotidiana di queste persone? Che cosa hanno imparato dovendo scegliere la propria vita, esplorando creativamente ciò che ha senso per loro? Quali sono le intuizioni e i consigli di cui possono beneficiare i futuri disoccupati? Un aspetto che rende l’Italia ancora più interessante è che offre un ulteriore livello di complessità. Qui non sono solo i super-ricchi a non lavorare. All’interno della classe media italiana si trova il più grande gruppo di “NEET” (Neither in Employment, Education or Training) in Europa. Questo gruppo rappresenta il 28,9% degli italiani tra i 20 e i 34 anni, rispetto a una media del 16,5% in Europa e dell’8% in Svezia.
NOTE DI REGIA
Ho un incubo personale ricorrente: arrivare alla fine della mia vita e con rimpianto, rendermi conto di aver lavorato troppo. Essere colpito, troppo tardi, dalla consapevolezza di aver sbagliato a stabilire le priorità per tutta la mia esistenza a causa di un’idea, radicata in me, che fa parte della cultura di cui sono il prodotto. Il lavoro è un’idea normale come l’aria che respiriamo, quindi difficile da mettere in discussione. La nostra società è una società basata sul lavoro. Fin dall’infanzia ci viene insegnato a seguire l’etica del lavoro, a istruirci per prepararci a trovare un lavoro.
Ho sempre visto il documentario come un modo per catturare, esporre e dare un senso al mio tempo (La teoria svedese dell’amore, The Rebel Surgeon, Videocracy, Surplus). Con After Work ho voluto fare un passo avanti, cercando di documentare una realtà che non è ancora completamente accaduta. Attraverso il metodo del What-if? Cosa faremo quando non dovremo più lavorare?
Questo film non è fatto con l’intenzione di ritrarre le cose come sono. Piuttosto come potrebbero essere.
È girato nel presente, con l’obiettivo di creare una proiezione nel futuro. Il futuro attraverso il presente.

CATTURARE CIÒ CHE POTREBBE ESSERE
Un importante punto di partenza per questo progetto è la distinzione del filosofo tedesco Herbert Marcuse tra pensiero unidimensionale – attenersi solo a “ciò che è” – e pensiero bidimensionale – abbracciare anche “ciò che potrebbe essere”. Marcuse vedeva nell’arte la chiave per dare vita alla seconda dimensione in un’epoca in cui le razionalizzazioni aprivano la strada al dominio del pensiero unidimensionale. O all’evasione come cura alla sorta di alienazione che la vita moderna, il consumo e il lavoro noioso portavano con sé. Per Marcuse l’arte ha il dovere di invitare a immaginare un mondo migliore. Non solo per criticare o per distrarre.
Quando ho iniziato a girare After Work c’era questa mia chiara intenzione: la maggior parte del dibattito sul futuro del lavoro è dominato da tecnici e teorici, esperti di IA e automazione. A me non interessa la tecnologia, il mio approccio con After Work è esistenziale. Ho cercato di evitare quasi completamente la prospettiva tecnologica, concentrandomi invece sui personaggi, sulla prospettiva umana. Sono incuriosito dalle possibilità di una vita post-lavorativa, di un’esistenza libera dal lavoro. Esplorare questo enigma: riusciremo a liberarci dal workismo, dalla convinzione quasi religiosa che il lavoro debba essere il fulcro della nostra esistenza? O continueremo a lavorare per il gusto di lavorare?
Una delle ispirazioni per After Work mi è venuta leggendo il sociologo svedese Roland Paulsen e i suoi scritti su quella che lui chiama ‘’L’ideologia del lavoro’’, ‘’un insieme di paure, valori e idee che giustificano il fatto che dovremmo continuare a lavorare tanto, o anche di più, indipendentemente da quanto la tecnologia diventi efficace.’’
Perché l’ideologia del lavoro sia così forte, perché queste paure e questi valori siano così presenti è una sorta di enigma, un mistero che mi ha ispirato in questo film. Con questa domanda ho esplorato diverse società che sono interessanti se ci si interroga sul ruolo del lavoro. Siamo in grado di immaginare un futuro diverso, con una nuova idea di lavoro più compatibile con il futuro?
E si può trovare un modello nel presente? Magari proprio tra quelli che non ci aspettiamo che possano insegnarci qualcosa? Come per esempio i super ricchi e i privilegiati.
Mi piace pensare a After Work come a un film guidato dalle idee, più che dai personaggi. Eppure ho trovato persone immensamente affascinanti con intuizioni nate da esperienze reali negli Stati Uniti, la “No Vacation Nation”, l’unico paese del mondo sviluppato senza leggi che garantiscano le ferie.
E in Corea del Sud, dove il governo sta cercando di affrontare il problema del sovraccarico di lavoro attraverso drastici interventi statali, e dove c’è l’unico ministro del Lavoro al mondo con la missione di far lavorare meno le persone.
In Kuwait, dove i cittadini privilegiati potrebbero lavorare meno, ma viene chiesto loro di far finta di lavorare in cambio di un reddito garantito.
E in Italia, il mio Paese d’origine, dove esiste una cultura dell’anti-lavoro e dell’edonismo all’interno della categoria dei giovani definiti NEET – giovani tra i 20 e i 34 anni che non hanno un lavoro, né un’istruzione, né una formazione – che in Italia costituiscono 1/3 della gioventù. Considerata dalla leadership del Paese come preoccupante, ma che potrebbe contenere i semi di una potenziale etica anti-lavoro.
SULL’ESTETICA DI AFTER WORK
La collaborazione con Fredrik Wenzel, pluripremiato direttore della fotografia (due volte vincitore della Palma d’Oro come DOP di The Square e Triangle of Sadness di Ruben Östlund), ha aperto nuove frontiere. Abbiamo iniziato a utilizzare semplici telecamere fisse in ambienti reali come uffici o centri commerciali. Per le interviste, abbiamo utilizzato sfondi come i grandi uffici vuoti di Seoul, e lo strumento ‘Eye direct’, la stessa tecnica usata da Errol Morris Interrotron, che fa sì che gli occhi degli intervistati siano rivolti direttamente verso l’obiettivo. Il 4K e il formato cinemascope hanno rafforzato la qualità cinematografica del materiale filmico che è stato curato dal montatore e compositore delle musiche Johan Söderberg, mio collaboratore di lunga data.
Johan Söderberg ha composto le musiche che sono state arrangiate da Christoffer Berg e registrate dal vivo nello studio di Ennio Morricone a Roma con un’orchestra di musicisti italiani.
Testo, video e immagini dall’Ufficio Stampa Studio Sottocorno.