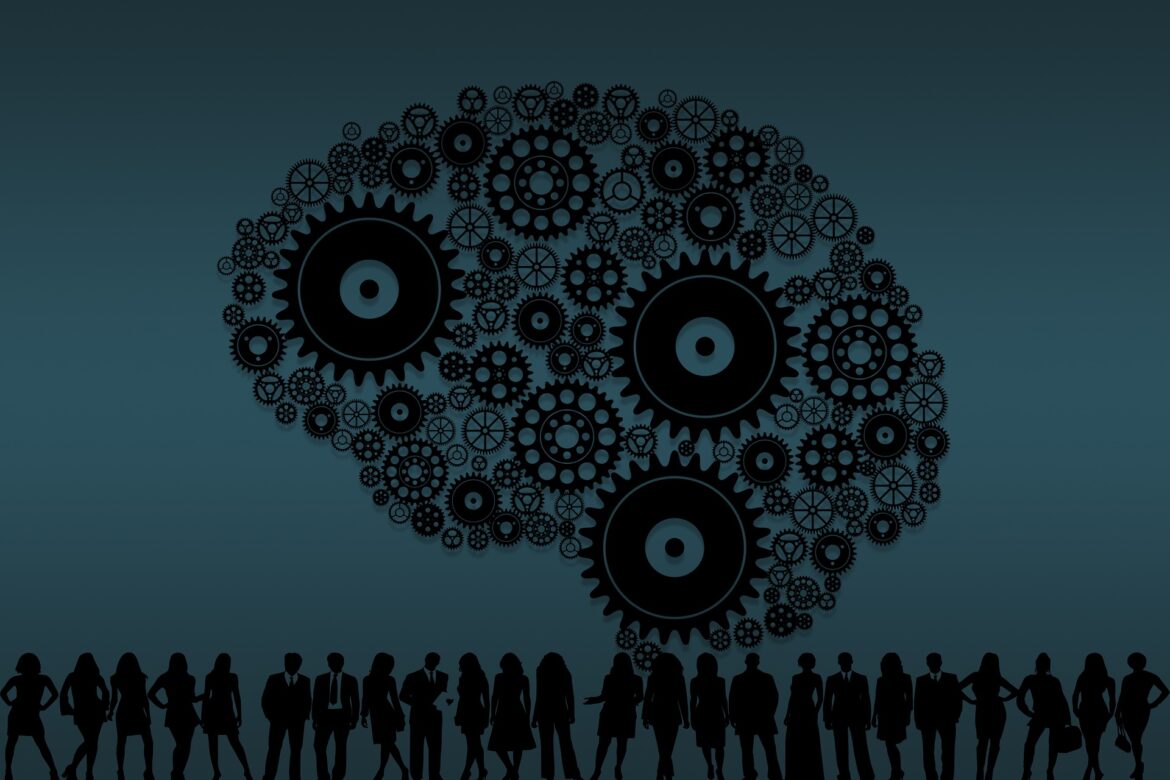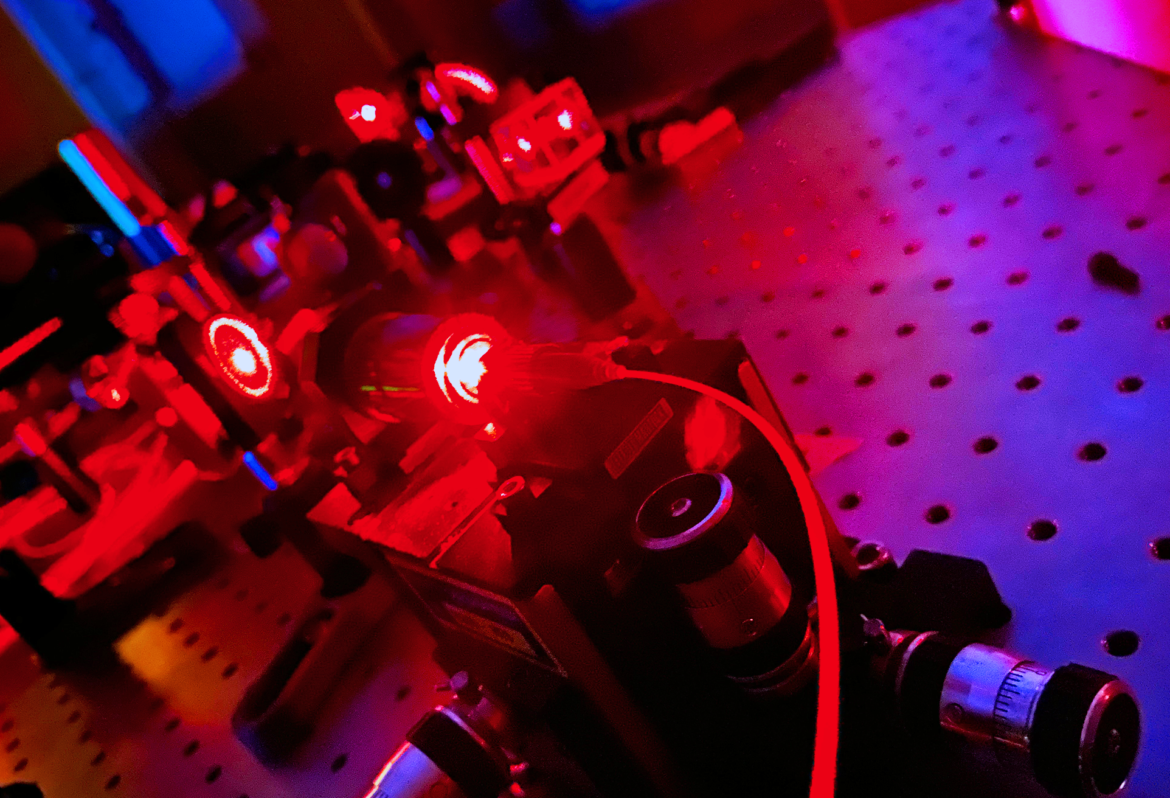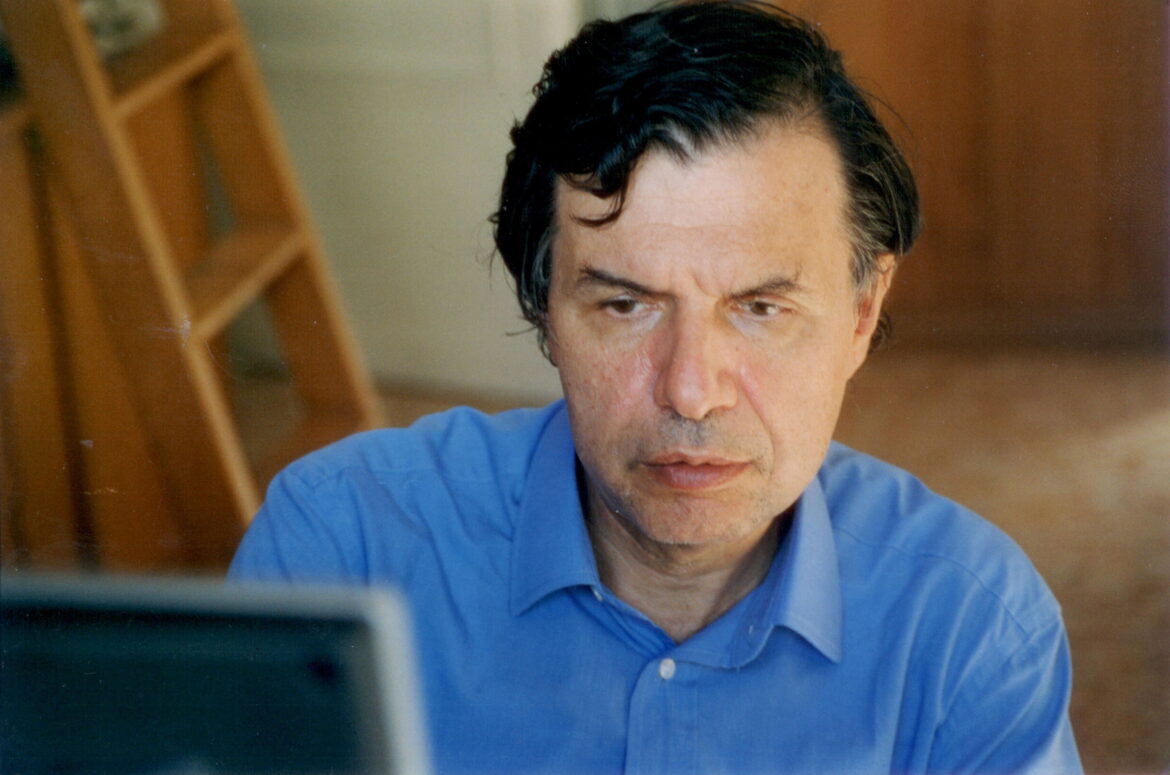Mentire o dire la verità: il ruolo della dopamina nelle scelte di persone colpite da malattia di Parkinson
Un’analisi della rassegna scientifica pubblicata da NPJ Parkinson’s Disease, parte del gruppo Nature, ha valutato il ruolo della dopamina nella modulazione delle scelte morali di pazienti colpiti da malattia di Parkinson, in particolare sul mentire o dire la verità.
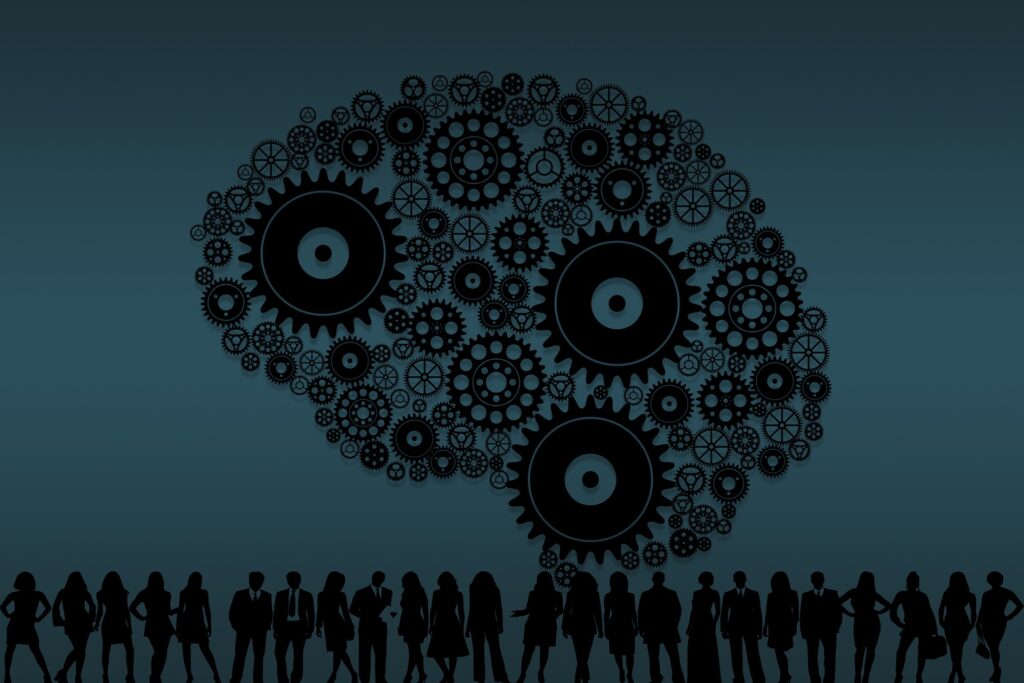
La malattia di Parkinson è un disturbo neurodegenerativo progressivo caratterizzato dalla perdita di neuroni dopaminergici nei gangli della base e nel circuito talamo-corticale, che provocano alterazioni nel controllo motorio. Una mole crescente di evidenze indica inoltre come i gangli della base sottendano anche funzioni di alto livello, come la cognizione, l’emozione e la motivazione.
Un gruppo di ricercatori coordinati da Salvatore Maria Aglioti, e che ha visto il coinvolgimento di Sapienza Università di Roma, Istituto Italiano di Tecnologia, Fondazione Santa Lucia IRCCS, ha pubblicato una rassegna della letteratura volta ad indagare la cognizione morale, e in particolare i processi decisionali di tipo morale, come il mentire o il dire la verità, in pazienti colpiti da malattia di Parkinson.
L’analisi della letteratura scientifica ha evidenziato la presenza di due diverse tendenze comportamentali: l’iper-onestà, ossia la minor propensione a mentire rispetto ai gruppi di controllo, anche quando la menzogna comportava un guadagno economico, e l’ipo-onestà, quindi la maggior propensione a mentire rispetto ai gruppi di controllo. In particolare, la tendenza a mentire si è rivelata essere spesso associata alle ulteriori diagnosi di disturbo del controllo degli impulsi e di sindrome da dis-regolazione dopaminergica.
“I pazienti che oltre alla malattia di Parkinson presentano un disturbo del controllo degli impulsi” spiega la dott.ssa Giorgia Ponsi, psicologa, e prima autrice dello studio, “Mostrano una ridotta quantità di trasportatore della dopamina nello striato dorsale, che è la regione del cervello coinvolta negli aspetti motori e cognitivi delle decisioni. A questo si associa un maggior rilascio presinaptico di dopamina nello striato ventrale, ossia quella regione del cervello che fa parte del circuito della ricompensa ed è coinvolta negli aspetti motivazionali della decisione in risposta a ricompense esterne. Questo implica che, ad esempio, la prospettiva di una vincita economica abbia un valore motivazionale più elevato per una persona con malattia di Parkinson e disturbo del controllo degli impulsi.”
“Lo studio di questi comportamenti in persone con malattia di Parkinson, permette di comprendere attraverso le neuroscienze quella complessa catena di eventi che ci guidano nelle nostre scelte quotidiane” ha commentato Salvatore Maria Aglioti, “L’obiettivo ultimo è quello di riuscire ad individuare strategie terapeutiche che, attraverso l’utilizzo di farmaci o la neuroriabilitazione, possano aiutare a ripristinare l’equilibrio interrotto dalla patologia”.
Secondo gli autori dello studio, la principale ipotesi derivata da questa analisi, è che le disfunzioni a carico del sistema motivazionale, in particolare lo squilibrio dopaminergico tra striato dorsale e striato ventrale, possano aumentare o diminuire la salienza delle ricompense esterne(ad esempio, denaro o cibo) e spiegare, di conseguenza, entrambe le tendenze comportamentali (iper-onestà e ipo-onestà) riportate in letteratura.
Riferimenti:
Ponsi, G., Scattolin, M., Villa, R., Aglioti, S. M. Human moral decision-making through the lens of Parkinson’s disease. npj Parkinsons Dis. 7, 18 (2021). https://doi.org/10.1038/s41531-021-00167-w
Testo dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma.