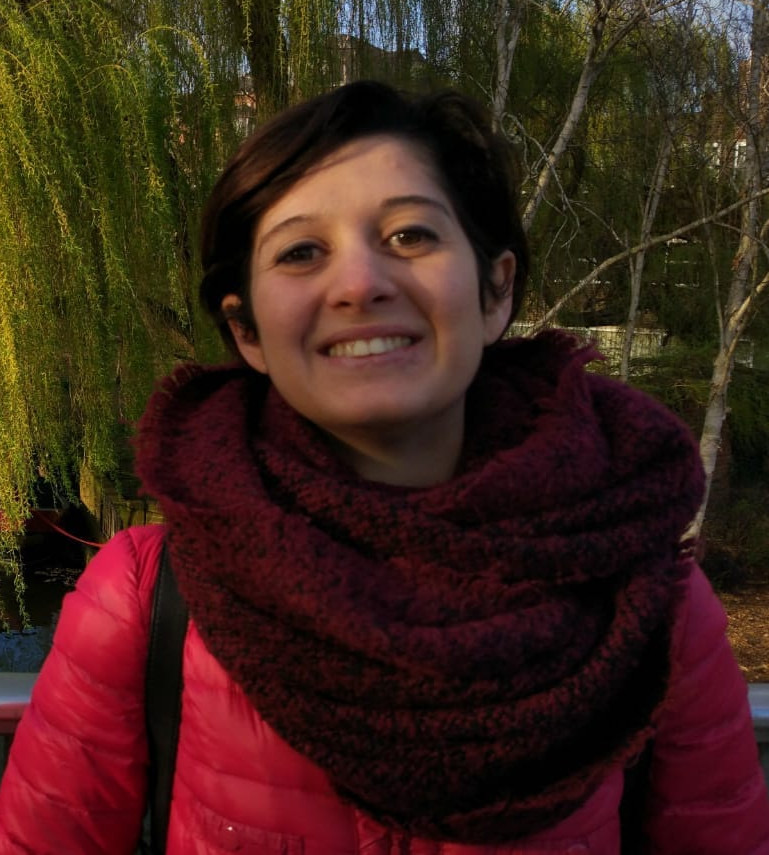LO SPIN OFF DI UNITO DDC FINANZIATO CON 1,5 MLN DI EURO PER LO SVILUPPO DI TERAPIE MOLECOLARMENTE MIRATE RIVOLTE ALLA CURA DI LEUCEMIA E TUMORE AL SENO
Grazie all’investimento di Utopia SIS, la startup Drug Discovery and Clinic – nata all’interno dell’Incubatore 2i3T – fa un passo avanti per portare alla sperimentazione umana il proprio candidato farmaco per la Leucemia Mieloide Acuta.
La Drug Discovery and Clinic srl (DDC) – startup Spin-Off accademico dell’Università di Torino – ha ricevuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro da parte di Utopia SIS (società di investimento specializzata in healthcare e biomedicale) per la messa a punto di terapie oncologiche per la cura di leucemie e di carcinomi della mammella.

La DDC, nata all’interno dell’Incubatore d’imprese dell’Ateneo torinese 2i3T dall’unione di eccellenze di ricerca in ambito chimico farmaceutico (Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di UniTo) e clinico (Ospedale Mauriziano e Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la cura dei Tumori), ha come missione lo sviluppo di una piattaforma per lo sviluppo di terapie molecolarmente mirate basate su inibitori innovativi di un enzima denominato Diidroorotato Deidrogenasi umana (hDHODH).
“Le terapie molecolarmente mirate, volte a colpire direttamente le cellule neoplastiche che determinano l’insorgenza dei tumori, rappresentano i pilastri fondamentali delle più moderne ed efficaci terapie antitumorali, spesso in grado di sostituire completamente la più tradizionale e tossica chemioterapia. L’attività di DDC è focalizzata a sviluppare nuovi farmaci di questo tipo e di valutarne l’efficacia non solo in ambito oncologico, ma anche in altri settori della medicina come malattie immunologiche o causate da virus”, spiega il Prof. Giuseppe Saglio, Presidente del CdA e Clinical Scientific Officer di DDC.
Con il finanziamento di Utopia SIS, società promossa e partecipata dalla Fondazione Golinelli, dalla Fondazione Sardegna e dal Vice Presidente Esecutivo Antonio Falcone, DDC entra in una nuova fase della sua vita iniziando gli studi certificati necessari per portare alla sperimentazione umana per la Leucemia Mieloide Acuta il proprio candidato farmaco, una molecola risultata essere molto efficace nel ridurre l’incidenza della malattia su modelli animali.
“Questo investimento di Utopia è per noi molto strategico ed è di grande soddisfazione perché stiamo contribuendo al sostegno e allo sviluppo di una importante ricerca polifunzionale estremamente interessante e di grandissimo impatto scientifico. Il nostro Paese è ricco di eccellenze cliniche e di poli di ricerca che hanno bisogno di essere finanziati per terminare il percorso di sviluppo e l’importante impegno del Mediocredito Centrale, che rilascerà una garanzia sull’investimento per l’80%, anche in questa occasione rappresenta una testimonianza strategica per il settore”, commenta Antonio Falcone, Vice Presidente Esecutivo di Utopia SIS.
“Abbiamo compiuto un passo fondamentale per DDC, ne siamo molto soddisfatti e orgogliosi. L’ingresso di un partner come Utopia, un investitore di ampia e specifica esperienza in ambito healthcare, non porta solamente l’accesso ai fondi necessari per lo sviluppo strategico dell’azienda ma rappresenta un valore aggiunto di credibilità e una fonte di future opportunità”, conclude il Prof. Marco L. Lolli, CEO di DDC, che insieme al core team Donatella Boschi, Stefano Sainas, Marta Giorgis, Giuseppe Saglio, Paola Circosta e Agnese Chiara Pippione ha raggiunto l’accordo.
DDC è stata assistita in tutte le fasi dell’operazione dallo studio Leading Law e nello specifico da i partner Mario Donadio e Stefano Balzola, coadiuvati dal junior associate Stefano Flammini.
Testo e foto dall’Area Relazioni Esterne e con i Media dell’Università degli Studi di Torino