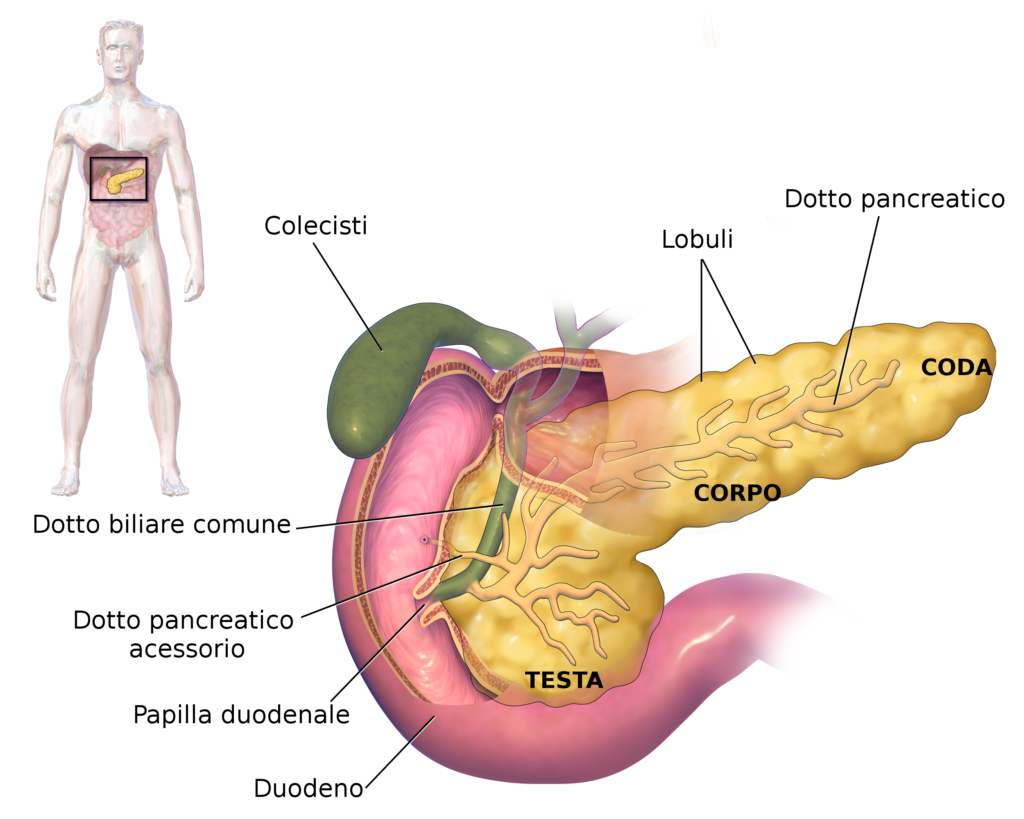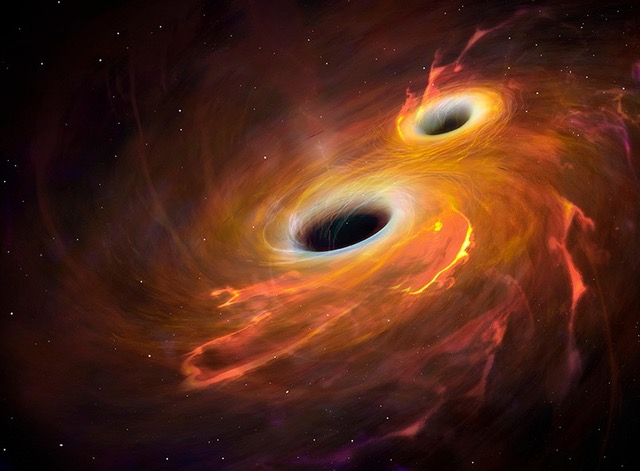COORDINAZIONE E REGOLARITÀ RITMICA TIPICAMENTE UMANE TROVATE IN UN ALTRO PRIMATE
I ricercatori dell’Università di Torino, studiando canti di gibboni in natura e in cattività, hanno riscontrato somiglianze ritmiche con gli esseri umani e con altre specie di primati

Oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, sulla prestigiosa rivista scientifica Proceedings of the Royal Society B è stato pubblicato l’articolo “Isochrony and rhythmic interaction in ape duetting”, coordinato dai ricercatori dell’Università di Torino, della King Mongkut’s University of Technology Thonburi di Bangkok e dell’Istituto Max Planck di Psicolinguistica di Nijmegen. Attraverso questa ricerca gli autori hanno studiato le vocalizzazioni dei gibboni dalle mani bianche, tra i più famosi primati che cantano duettando, registrate sia in alcuni parchi zoologici italiani, sia nelle foreste della Thailandia.
I ricercatori hanno osservato come questi canti posseggano delle regolarità ritmiche in parte simili a quelli della musica umana. Questa scoperta si inserisce in un progetto a lungo termine dell’Università di Torino e dell’Istituto Max Planck di Psicolinguistica sui tratti musicali condivisi da specie diverse. Questo filone di ricerca ha come obiettivo quello di far luce sulla biologia e l’evoluzione di ritmo e musica nella nostra specie.
Il team di ricerca internazionale, guidato dai ricercatori senior Marco Gamba (Università di Torino), Tommaso Savini (King Mongkut’s University) e Andrea Ravignani (Max Planck Institute), si è messo alla ricerca di abilità musicali nei primati.
“Da molto tempo cerchiamo di capire quali tratti della musicalità siano condivisi tra specie diverse – dichiara Andrea Ravignani – ma lo studio degli aspetti ritmici del canto dei primati è davvero agli albori. In questo studio abbiamo indagato il legame tra isocronia, quanto un ritmo individuale è regolare, e sincronia, quanto due individui si coordinano ritmicamente, in un animale non umano”.
Una parte del gruppo di ricerca si era già occupata dei canti di un altro primate cantante, il lemure Indri indri del Madagascar, ma i ricercatori volevano confrontare quei risultati con una specie di primate antropomorfo, come i gibboni. Inoltre, avevano come obiettivo quello di far luce sugli effetti di interazione che si manifestano durante i duetti di questi gibboni.
“La presenza di ritmi categorici, come l’isocronia, – dichiara Teresa Raimondi, dottoranda di Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicatee prima autrice del lavoro – è una caratteristica musicale universale presente in tutte le culture umane che qui osserviamo anche in un primate antropomorfo come il gibbone lar. Abbiamo anche dimostrato che l’aumento della frequenza di emissione delle vocalizzazioni durante il canto è legata complessivamente ad un aumento dell’isocronia, suggerendo che i vincoli fisiologici respiratori svolgono un ruolo nel determinare la struttura ritmica del canto”.

Giovanni Boris Di Panfilo ha registrato i canti dei gibboni dalle mani bianche allo Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary in Thailandia, Matteo Pasquali e Martina Zarantonello, come Di Panfilo, studenti della laurea magistrale Evoluzione del Comportamento Animale e dell’Uomo, hanno invece lavorato su gruppi familiari in cattività presso il Parco Zoo Falconara e il Parco Faunistico Cappeller vicino a Bassano del Grappa.
“L’isocronia appare anche modulata a seconda del contesto di emissione. – dichiara Marco Gamba, docente del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino – Questi animali paiono essere più isocroni quando duettano rispetto a quando cantano da soli. Abbiamo anche osservato una causalità statistica tra le note di un individuo e le note di un altro individuo. Questi studi aprono nuove prospettive di indagine in ottica comparativa e partecipano alla costruzione di un mosaico delle capacità musicali nelle specie animali”.

Articolo:
Raimondi T, Di Panfilo G, Pasquali M, Zarantonello M, Favaro L, Savini T, Gamba M, Ravignani A. 2022 Isochrony and rhythmic interaction in ape duetting. Proc. R. Soc. B 20222244. https://doi.org/10.1098/rspb.2022.2244
Testo e foto dall’Area Relazioni Esterne e con i Media dell’Università degli Studi di Torino