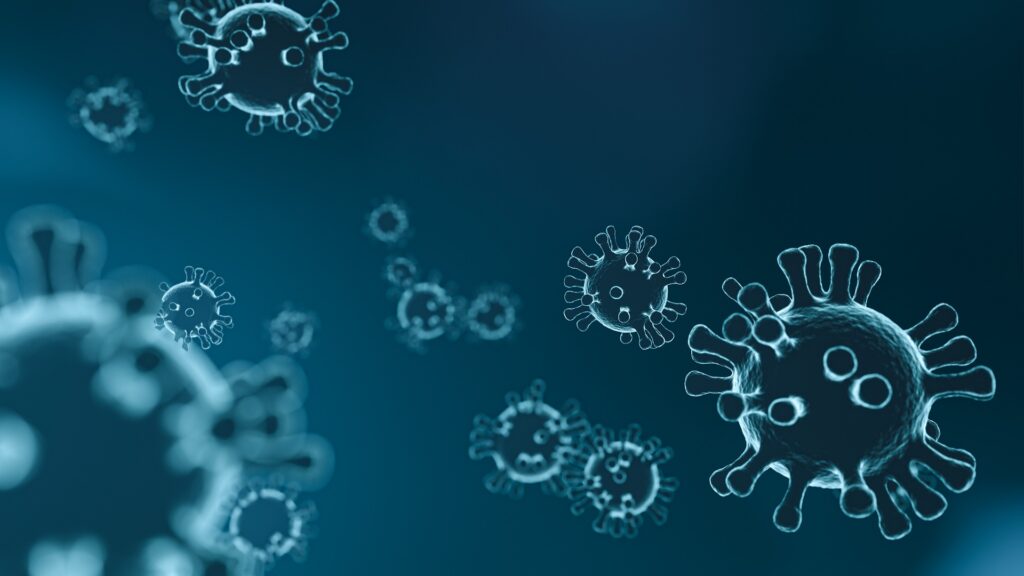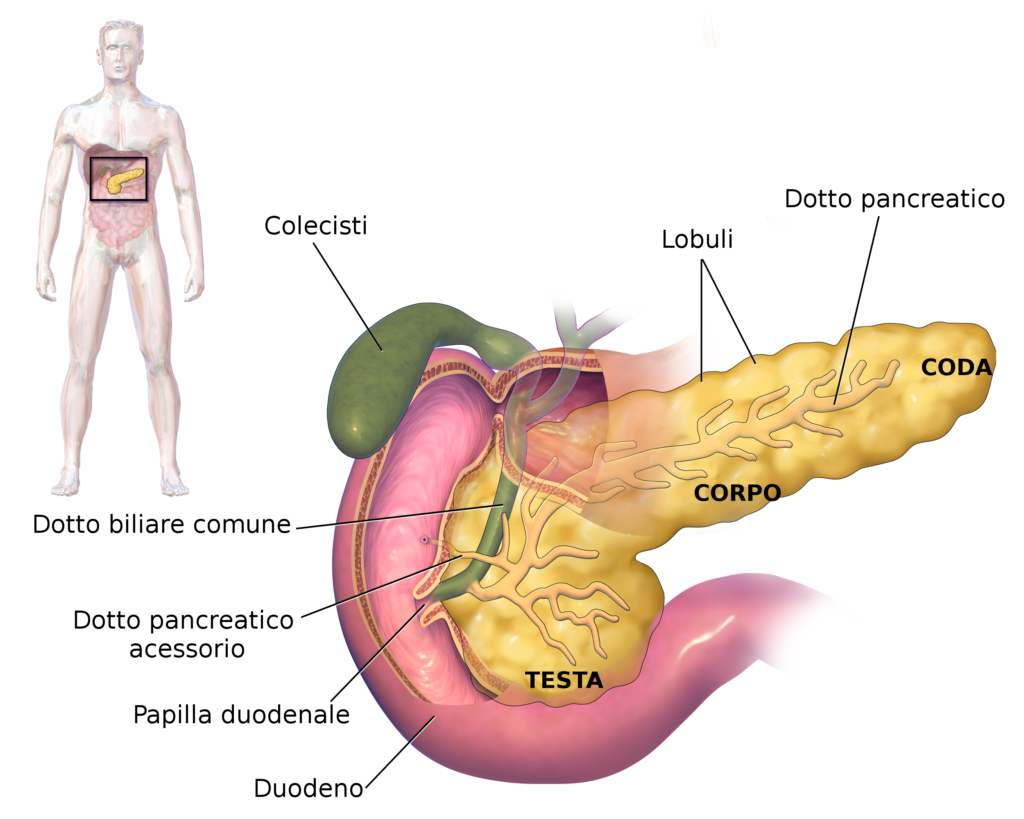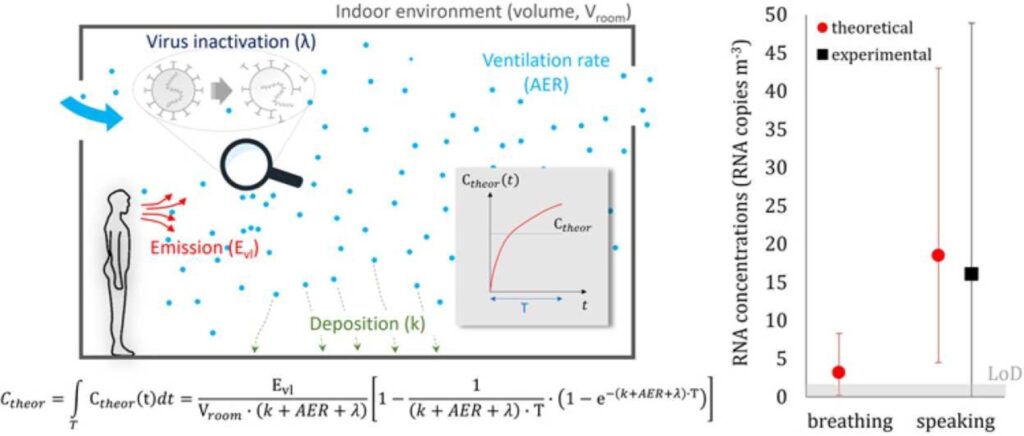UNITO GUIDA UN PROGETTO INTERNAZIONALE
SULLA COMUNICAZIONE TRA PIANTE E IMPOLLINATORI
Come reagiscono le piante ai suoni emessi dagli insetti che ne visitano i fiori? Sono in grado di riconoscere i diversi visitatori in base alla loro firma acustica? Sono solo alcune delle domande a cui la ricerca, sostenuta da Human Frontiers Science Program, vuole dare risposta.

Due ricercatori dell’Università di Torino, Francesca Barbero e Luca P. Casacci – docenti presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi –, guideranno un gruppo di ricerca internazionale impegnato nel progetto Good Vibes: how do plants recognise and respond to pollinator vibroacoustic signals?, finanziato dallo Human Frontiers Science Program Award.
Good Vibes vuole scoprire i meccanismi molecolari e fisiologici delle risposte delle piante ai segnali vibroacustici emessi dagli insetti. I ricercatori utilizzeranno le bocche di leone (Antirrhinum spp.) e gli insetti che ne visitano i fiori come modello di studio. Durante il volo, questi insetti producono suoni differenti a seconda della specie, una sorta firma acustica, e possono fungere da efficienti impollinatori o sfruttare le risorse della pianta sottraendo nettare senza contribuire al trasferimento del polline e dunque al potenziale riproduttivo delle bocche di leone.
L’ipotesi principale che i ricercatori vogliono verificare è se le piante siano in grado di discriminare i diversi insetti visitatori dei fiori sulla base della loro firma acustica e di reagire con risposte atte a incrementare l’attrattività e la fedeltà alla pianta soltanto nel caso in cui siano visitate da impollinatori efficienti.
Più in generale, i risultati ottenuti tramite un approccio multidisciplinare che combina etologia, bioacustica, biologia vegetale, biologia molecolare, ingegneria, fisica e modellistica permetteranno di rispondere, almeno in parte, ad alcune domande fondamentali: come reagiscono le piante ai suoni emessi dagli insetti che ne visitano i fiori? Nel corso dell’evoluzione, forma e materiali florali possono essere stati determinati anche dall’esigenza di migliorare la propagazione dei segnali vibroacustici? Perché la comunicazione vibroacustica si è evoluta nelle piante?
L’intento di Good Vibes è colmare le lacune nella conoscenza delle dinamiche complesse dei sistemi pianta-impollinatori affrontandone lo studio da una prospettiva completamente nuova. Il progetto coinvolgerà tre unità: Insect-Behaviour Unit guidata da Francesca Barbero (Università di Torino, Italia), Engineering-Modelling Unit guidata da Sebastian Oberst (University of Technology Sydney, Australia) e Plant-Physiology Unit guidata da J. Tomás Matus, ricercatore del programma Ramon y Cajal (Università di Valencia) presso I2SysBio (UV-CSIC).
L’ente internazionale Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) ha stanziato 37 milioni di dollari per sostenere il 4% dei migliori progetti di ricerca HFSP nei prossimi 3 anni. I vincitori dell’anno 2022 hanno superato un rigoroso processo di selezione durato un anno, che ha visto la partecipazione di 716 proposte da parte di ricercatori di oltre 50 diversi paesi. Tra questi sono stati selezionati 7 progetti dedicati a giovani ricercatori e 25 progetti senior. Il finanziamento del progetto Good Vibes ammonta a 1.140.000 dollari e avrà una durata di tre anni.
Testo e foto dall’Ufficio Stampa dell’Università degli Studi di Torino