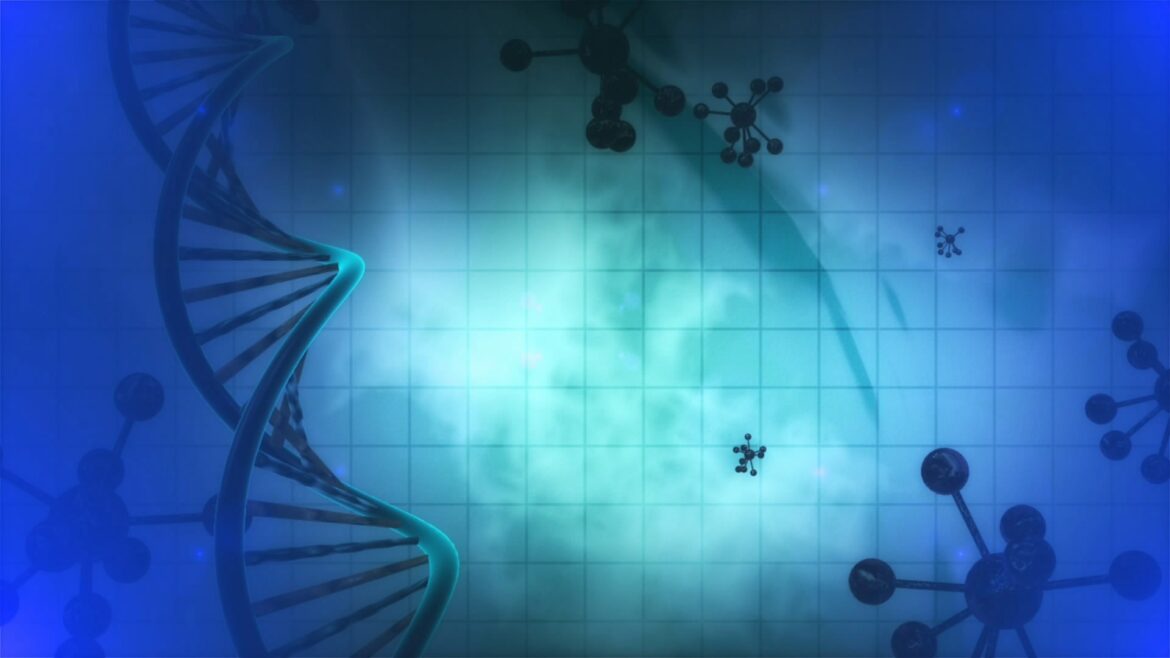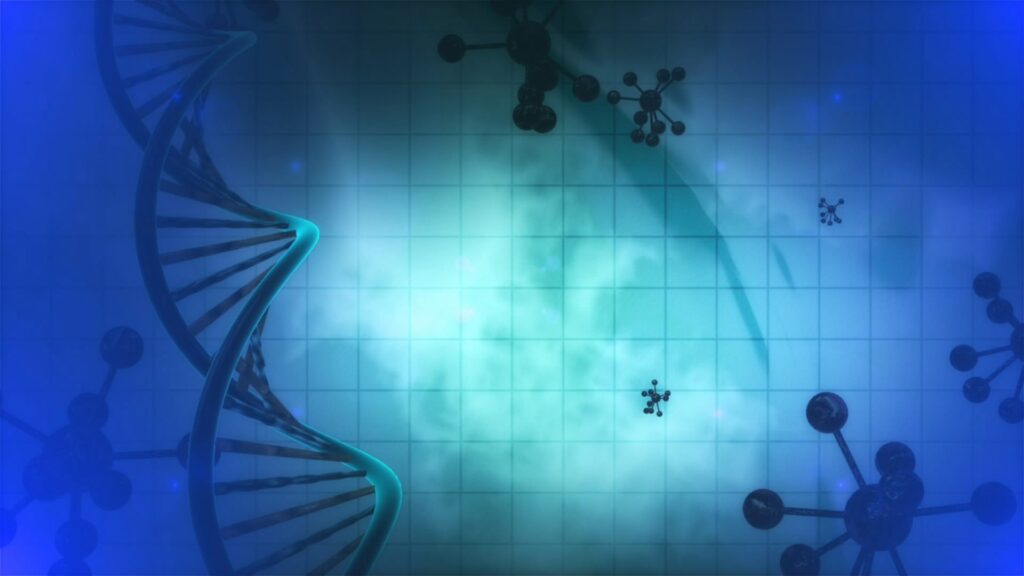ERC Proof of Concept per il progetto FLORA (Fusing LiDAR Observations with Remote-sensing Analysis)
Innovazione e benessere urbano: un progetto dell’Università degli Studi di Milano si aggiudica un finanziamento complessivo di 150mila euro
Il riconoscimento dell’European Research Council è stato assegnato a due docenti della Statale di Milano: Valentina Bollati, al suo quarto ERC, ed Elia Biganzoli, con FLORA (Fusing LiDAR Observations with Remote-sensing Analysis), un progetto interdisciplinare per rispondere alle necessità di benessere e alla salute dei cittadini. Lo studio coinvolgerà le istituzioni e i cittadini di Legnano, in provincia di Milano, per creare un modello replicabile a livello globale.
Milano, 23 gennaio 2025 – Migliorare l’estetica urbana e la vivibilità delle città, per tutelare e promuovere la salute dei cittadini: è l’obiettivo che si pone il progetto FLORA (Fusing LiDAR Observations with Remote-sensing Analysis), vincitore di un ERC Proof of Concept (PoC) di 150 mila euro. FLORA è guidato da Valentina Bollati, docente dei Medicina del Lavoro e responsabile dell’EPIGET Lab, il Laboratorio di Epidemiologia, Epigenetica e Tossicologia del Dipartimento Scienze Cliniche e di Comunità ed Elia Biganzoli, docente di Statistica Medica e responsabile del gruppo di Epidemiologia e Statistica Bioinformatica del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dello stesso Ateneo, cofondatori dell’iniziativa INES nella quale si colloca anche il progetto FLORA e componenti del Centro di Ricerca Coordinata DESIRE sulla Scienza delle Decisioni.
FLORA avrà come compito quello di analizzare con metodi di Intelligenza Artificiale il legame tra la salute e l’esposoma, ovvero l’insieme di tutte le esposizioni ambientali, comportamentali e occupazionali, non genetiche, cui un individuo è esposto nel corso della sua vita. Questo studio, che sarà svolto a Legnano (Mi), è un’importante applicazione del progetto MAMELI “MApping the Methylation of repetitive elements to track the Exposome effects on health: the city of Legnano as a LIving lab”, progetto guidato sempre da Valentina Bollati per il quale nel 2023 si è aggiudicata un ERC Consolidator Grant di circa 3 milioni di euro, che si è avvalso della collaborazione con diversi gruppi di ricerca di Ateneo, tra cui quello coordinato da Elia Biganzoli. Il riconoscimento PoC viene infatti conferito ai progetti che si propongono di esplorare il potenziale commerciale e sociale delle ricerche già finanziate da un ERC iniziale, risultando così ancora più significativo.
“Con FLORA avremo la possibilità di integrare alcune informazioni dettagliate sul paesaggio urbano – come spazi verdi, qualità dell’aria, flussi di traffico – con le percezioni dei cittadini. Inoltre si potranno creare metriche per quantificare la percezione estetica, la vivibilità e la salute urbana, identificando le aree che necessitano di interventi mirati. E soprattutto, coinvolgendo urbanisti, amministratori, comunità locali e abitanti, si potrà dare avvio a una nuova progettazione delle città che risponda alle esigenze di benessere e salute”, spiega Valentina Bollati, già vincitrice anche di un ERC Starting Grant nel 2011 e di un ERC PoC nel 2018.
Un team multidisciplinare di eccellenza, composto anche da Fabio Mosca (Università degli Studi di Milano), Pilar Guerrieri (Politecnico di Milano), Andrea Cattaneo (Università dell’Insubria) e Giovanni Sanesi (Università degli Studi di Bari) collaborerà con le autorità locali e i cittadini di Legnano per raccogliere dati e implementare un cruscotto di indicatori multidimensionali (FLORA dashboard), capace di integrare diverse tecnologie, come lo strumento laser LiDAR (Light Detection and Ranging) per rilevare la distanza di un oggetto, i sistemi GIS (Geographic Information System) e i sondaggi sulla percezione umana, con l’obiettivo finale di creare un modello replicabile e trasferibile a livello globale.
“La forza di FLORA risiede proprio nella capacità di unire competenze interdisciplinari, con l’uso responsabile e trasparente dell’Intelligenza Artificiale e della Scienza delle Decisioni, superando i tradizionali approcci settoriali e adottando una visione integrata e sostenibile del benessere urbano”, conclude Elia Biganzoli.

Testo dall’Ufficio Stampa Direzione Comunicazione ed Eventi istituzionali Università Statale di Milano.