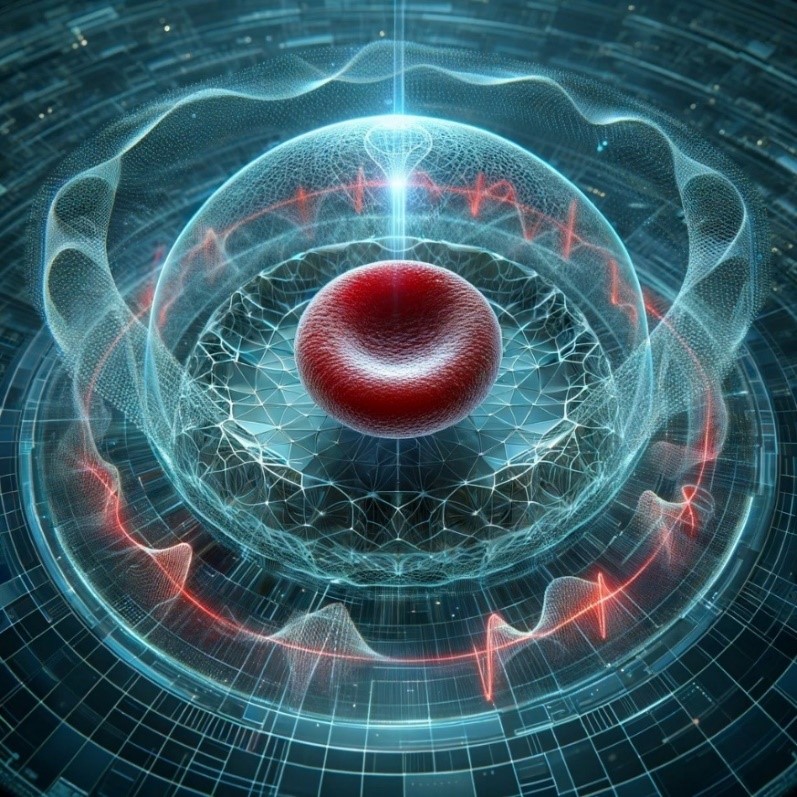Comunicazione cervello-corpo: il ruolo delle piastrine
Secondo lo studio coordinato dalla Sapienza e pubblicato sulla rivista Cell Reports, questi frammenti di cellule presenti nel sangue condizionano l’apprendimento e la memoria della paura.
Accanto al ruolo cardine che le piastrine svolgono nella coagulazione del sangue e nel processo di emostasi, recenti studi hanno dimostrato che questi piccoli frammenti di cellule presenti nel sangue assolvono ad altre importanti funzioni. Se il ruolo delle piastrine nel sistema immunitario è noto, come esse agiscano nella modulazione delle interazioni neurologiche è un aspetto ancora poco indagato.
Le piastrine influenzano in qualche misura il comportamento? È questa la domanda di partenza dello studio, coordinato da Cristina Limatola del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia della Sapienza e recentemente pubblicato sulla rivista Cell Reports. La risposta sembra essere positiva: la ricerca, infatti, identifica le piastrine come un elemento chiave nella comunicazione cervello-corpo, in grado di attivare meccanismi che influenzano la memoria e il comportamento.
Questa funzione deriva dal fatto che le piastrine immagazzinano serotonina, un neurotrasmettitore prodotto principalmente nel sistema nervoso e nell’apparato gastrointestinale. Come è ben noto, la serotonina regola l’umore, influenza alcune funzioni biologiche quali il sonno e l’appetito, e ha un effetto anche nei processi di apprendimento e di memorizzazione. Se si considera che le piastrine contengono la maggior parte della serotonina presente nel nostro corpo, appare chiaro come esse siano coinvolte nella regolazione delle risposte neuro immunitarie.
Lo studio ha dimostrato che, riducendo o alterando il numero delle piastrine in modelli murini, si riduceva anche la quantità di serotonina presente nel cervello, con effetti su comportamenti legati alla paura nei topi. Generalmente sia il cervello umano che quello animale tendono a modulare il comportamento in base alle esperienze pregresse. Se per esempio in passato un evento è stato associato a un pericolo, la sua ricomparsa determinerà immediatamente risposte di fuga o di difesa. Al contrario stimoli nuovi molto diversi da quelli percepiti come pericolosi non indurranno comportamenti dettati dalla paura. Questo avviene perché, a seconda delle circostanze, si attivano nell’ippocampo – l’area del cervello che controlla la memoria –neuroni inibitori, cioè neuroni che rallentano il processo di memorizzazione.
I ricercatori hanno identificato nella minore presenza di serotonina nel cervello un fattore in grado di bloccare l’attività dei neuroni inibitori, causando un’alterata formazione della memoria e l’insorgenza delle risposte di paura anche in presenza di stimoli innocui. Lo studio ha dimostrato inoltre che la riduzione di serotonina nel cervello deriva da un meccanismo che viene regolato da cellule specifiche, le Natural Killer. Si tratta delle cellule che inducono la produzione di serotonina nel tratto gastrointestinale determinando quindi il carico trasportato dalle piastrine in tutto il corpo. Diminuendo sperimentalmente le cellule Natural Killer o le piastrine si riduce la quantità di serotonina nel cervello e viene innescato il processo che modula i comportamenti di paura attraverso il controllo della neurotrasmissione inibitoria e della plasticità nell’ippocampo.
“Il nostro studio – spiega Cristina Limatola della Sapienza – aggiunge un nuovo elemento alla comprensione dei meccanismi con cui il cervello comunica e riceve informazioni dal corpo, definendo un nuovo meccanismo di comunicazione tra le cellule del sistema immunitario, le piastrine e l’asse intestino-cervello per il mantenimento dell’omeostasi cerebrale”
Riferimenti bibliografici:
Garofalo S, Mormino A, Mazzarella L, Cocozza G, Rinaldi A, Di Pietro E, Di Castro MA, De Felice E, Maggi L, Chece G, Andolina D, Ventura R, Ielpo D, Piacentini R, Catalano M, Stefanini L, Limatola C. “Platelets tune fear memory in mice”. Cell Rep. 2025 Feb 25;44(2):115261. doi: 10.1016/j.celrep.2025.115261

Testo dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma