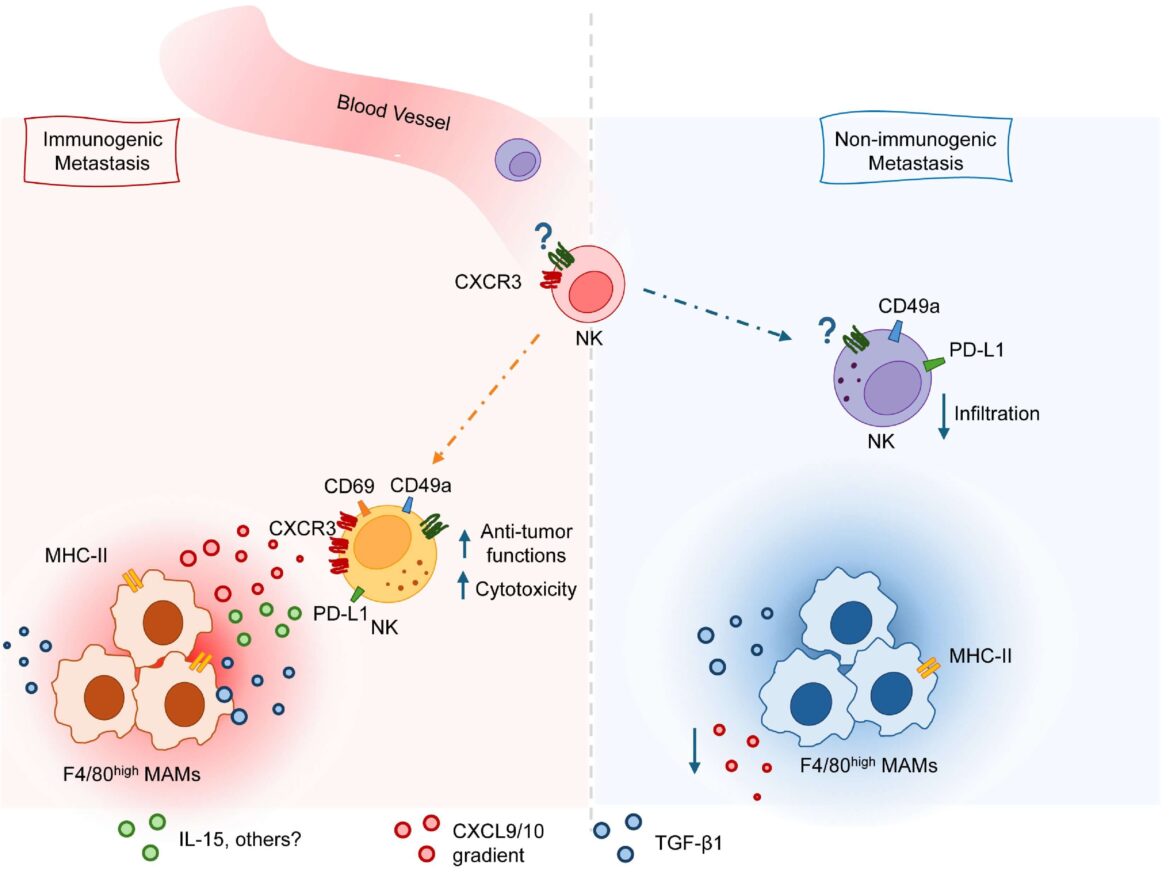TIP60, la centralina multiproteica che “viaggia” all’interno delle cellule per garantirne la corretta replicazione
La review, pubblicata sulla rivista Epigenetics & Chromatin dai ricercatori della Sapienza, fa il punto sulle conoscenze riguardanti il complesso multiproteico TIP60, in particolare sulle sue funzioni “non canoniche” relative alla mitosi. Lo studio apre nuove prospettive nella comprensione delle malattie legate a difetti della divisione cellulare e nell’individuazione di strategie terapeutiche
Il complesso multiproteico TIP60 è una sorta di “centralina” cellulare che controlla il rimodellamento della cromatina. La cromatina è la sostanza che compone il nucleo delle cellule ed è costituita da DNA avvolto a mo’ di gomitolo attorno alle proteine.
TIP60 svolge un ruolo cruciale per il corretto funzionamento delle cellule, regolando, tra l’altro, l’espressione dei geni e le sue alterazioni possono contribuire all’insorgenza di patologie umane, tra cui il cancro e disturbi dello sviluppo neurologico.
Da anni il Laboratorio di Epigenetics and cell division della Sapienza (Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin), coordinato da Patrizio Dimitri, studia le funzioni “non canoniche” svolte da TIP60.
“In particolare – spiega Dimitri – siamo stati incuriositi dall’osservazione che proteine note per svolgere funzioni cromatiniche si spostassero dal nucleo ai siti dell’apparato mitotico che controlla varie fasi divisione cellulare”.
Tali osservazioni, condotte su diversi organismi dall’uomo a Drosophila melanogaster (il moscerino della frutta), fino alle piante, indicano che questo fenomeno è conservato nel corso dell’evoluzione. Da questa esigenza è nata la recente review, con l’obiettivo di fare il punto sulle conoscenze attuali e stimolare nuove direzioni di ricerca in un campo tanto promettente quanto ancora poco esplorato.
L’articolo, pubblicato sulla rivista Epigenetics & Chromatin, si focalizza in particolare su quello che Dimitri ha chiamato il viaggio mitotico delle proteine rimodellatrici, un fenomeno che rivela le funzioni moonlighting del complesso TIP60, capace di svolgere compiti differenti in compartimenti cellulari distinti, mostrando una sorprendente versatilità.
Si tratta di un fenomeno di grande interesse, perché suggerisce l’esistenza di meccanismi genetico-molecolari ancora da chiarire, che svolgono un ruolo fondamentale nel controllo della divisione cellulare e nella stabilità del genoma. Approfondire questi meccanismi potrebbe aprire nuove prospettive nella comprensione delle malattie legate a difetti nei processi di divisione e regolazione genica. Non a caso, il TIP60 rappresenta un potenziale bersaglio per lo sviluppo di future strategie terapeutiche.
“Lo studio tocca anche aspetti centrali dell’evoluzione biologica – osserva Paolo Dimitri –Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’evoluzione non crea necessariamente geni o proteine del tutto nuovi. Molto più spesso riutilizza e modifica molecole già esistenti, adattandole a nuovi compiti senza far loro perdere del tutto le funzioni originarie”.
Le ricerche sono state condotte grazie a finanziamenti ottenuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Progetto PRIN 2022: Integrating genetic models to mechanistically dissect cytokinesis failure in neurodevelopmental disorders).

La fotografia mostra il risultato di un esperimento di immunofluorescenza condotto da Maria Virginia Santopietro, presso l’Advanced Imaging Core Facility di Trento, utilizzando la Expansion Microscopy, una raffinata tecnica di imaging a super-risoluzione. La freccia indica la presenza sul midbody della proteina TIP60 (che dà il nome al complesso). Il midbody è l’organello che definisce l’evento finale della divisione cellulare (final cut), che dà luogo alla formazione di due cellule figlie (il segnale di TIP60 è in arancione, mentre i fasci di microtubuli del fuso mitotico sono in verde).
Riferimenti bibliografici:
Santopietro, M.V., Ferreri, D., Prozzillo, Y. et al., The multitalented TIP60 chromatin remodeling complex: wearing many hats in epigenetic regulation, cell division and diseases, Epigenetics & Chromatin 18, 40 (2025), DOI: https://doi.org/10.1186/s13072-025-00603-8
Testo e immagine dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma