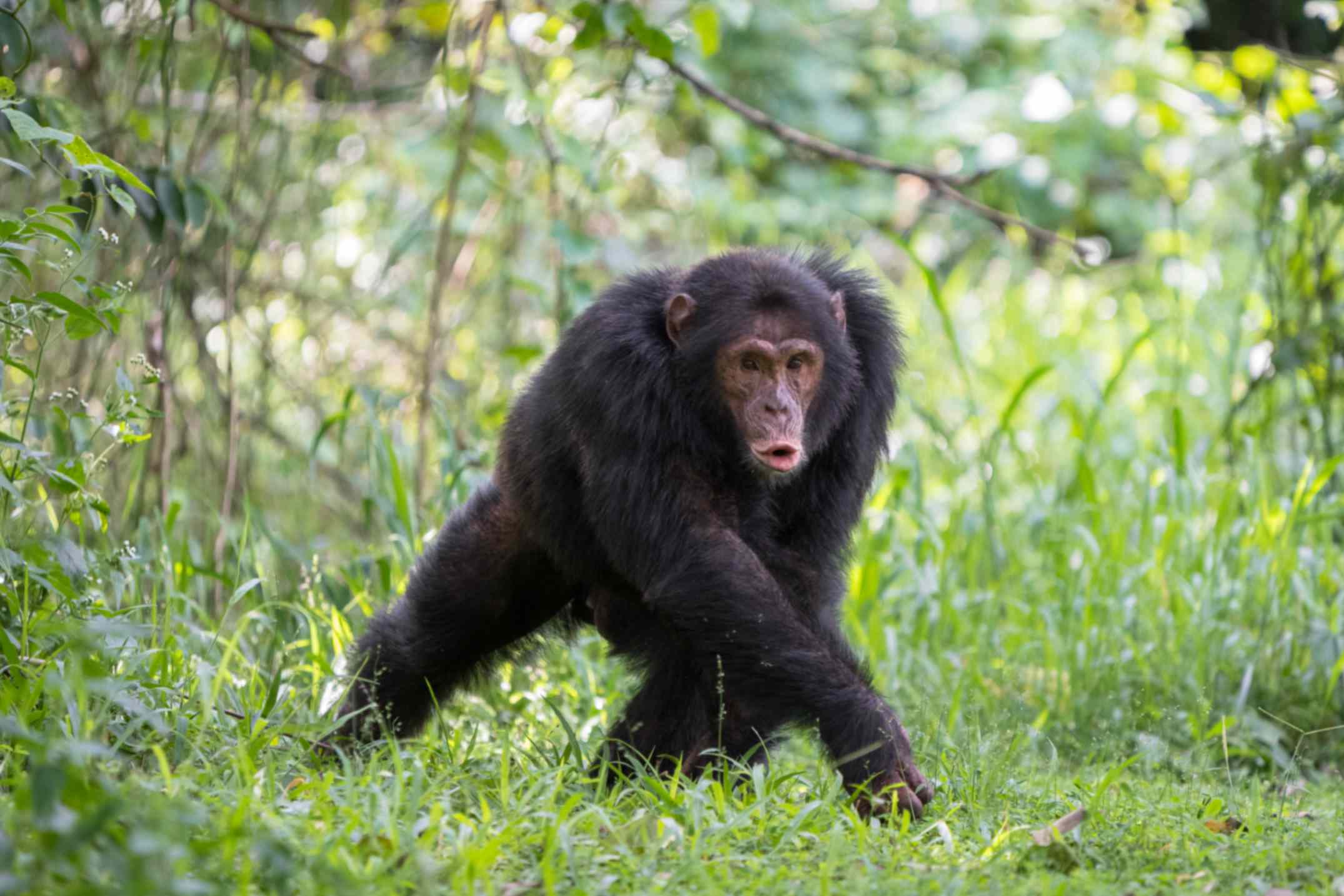Litigare o fare pace? Le scimmie gelada lo capiscono solo ascoltando
Uno studio coordinato dall’Università di Pisa e pubblicato sulla rivista PLoS ONE dimostra che queste scimmie hanno una capacità di “ascolto” orientata alla comprensione delle relazioni sociali nel gruppo.
I gelada, primati che vivono sugli altopiani dell’Etiopia, sono capaci di riconoscere e interpretare le interazioni vocali dei propri simili collegando i versi a dinamiche sociali di conflitto o riconciliazione, anche senza vedere la scena, solo dal suono. È questo quanto emerso da una ricerca internazionale pubblicata sulla rivista PLoS ONE, coordinata dall’Università di Pisa in collaborazione con l’Università di Rennes e l’Università di Addis Abeba.
Durante gli esperimenti, condotti sul campo, i ricercatori hanno fatto ascoltare ai gelada vocalizzazioni aggressive seguite da altre consolatorie (sequenza naturale), e poi l’opposto (sequenza anomala). Le scimmie mostravano maggiore attenzione – misurata dalla durata dello sguardo verso la fonte del suono e dall’interruzione di ciò che stavano facendo – nei confronti dello stimolo “anomalo”, ovvero quando le vocalizzazioni consolatorie precedevano l’urlo dell’aggressione.
Secondo i ricercatori, questo comportamento indica che i gelada non percepiscono i segnali acustici come semplici eventi isolati, ma li interpretano come risultato di interazioni sociali legate alla risoluzione dei conflitti e al conforto. In altre parole, la loro capacità di “ascolto” implica un’elaborazione cognitiva, orientata alla comprensione delle relazioni sociali nel gruppo.
“I nostri risultati suggeriscono che i gelada possiedono una forma di intelligenza sociale che si manifesta anche attraverso l’ascolto degli altri – spiega Elisabetta Palagi, professoressa associata al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e responsabile del progetto – Sono in grado, attraverso la percezione e la decodifica delle sequenze vocali, di comprendere, interpretare e reagire alle dinamiche sociali in modo appropriato anche senza avere davanti la scena di ciò che sta accadendo. Un’abilità che getta luce sulle basi evolutive delle nostre stesse capacità empatiche”.
Litigare o fare pace? Le scimmie gelada lo capiscono solo ascoltando. Gallery
Lo studio, durato 15 mesi, è stato finanziato dalla Leakey Foundation attraverso il progetto “Science for reconciliation” e da numerosi zoo e fondazioni europee nell’ambito del progetto BRIDGES dell’Università di Pisa. In particolare, per l’Università di Pisa, hanno partecipato allo studio Luca Pedruzzi, dottorando in cotutela con l’Università Rennes, che si occupa dei comportamenti a base empatica e alla complessità comunicativa in diverse specie di primati. Martina Francesconi e Alice Galotti, dottorande presso il Dipartimento di Biologia, che studiano il comportamento sociale in diverse specie animali. Infine, Elisabetta Palagi, professoressa associata al Dipartimento di Biologia, da anni impegnata a far luce sul comportamento sociale in varie specie animali, uomo incluso, in particolare la comprensione dell’evoluzione di alcuni comportamenti come il gioco, i meccanismi di risoluzione dei conflitti e le capacità empatiche alla base della vita sociale. Nel 2020, Palagi ha ricevuto il premio dall’Animal Behavior Society per i risultati conseguiti grazie ai suoi studi sul comportamento animale.
Riferimenti bibliografici:
Pedruzzi L, Francesconi M, Galotti A, Bogale BA, Palagi E, Lemasson A, Wild gelada monkeys detect emotional and prosocial cues in vocal exchanges during aggression, PLoS ONE (2025) 20(5): e0323295, DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323295
Testo e immagini dall’Ufficio comunicazione di Ateneo dell’Università di Pisa