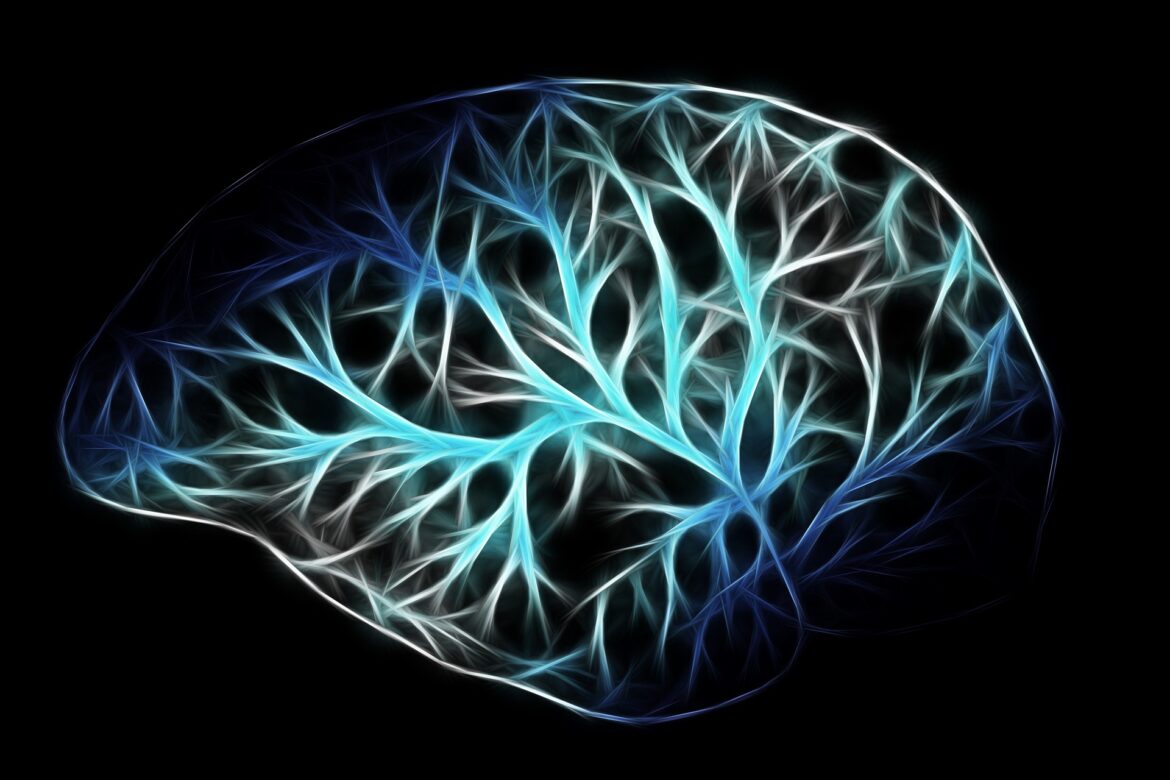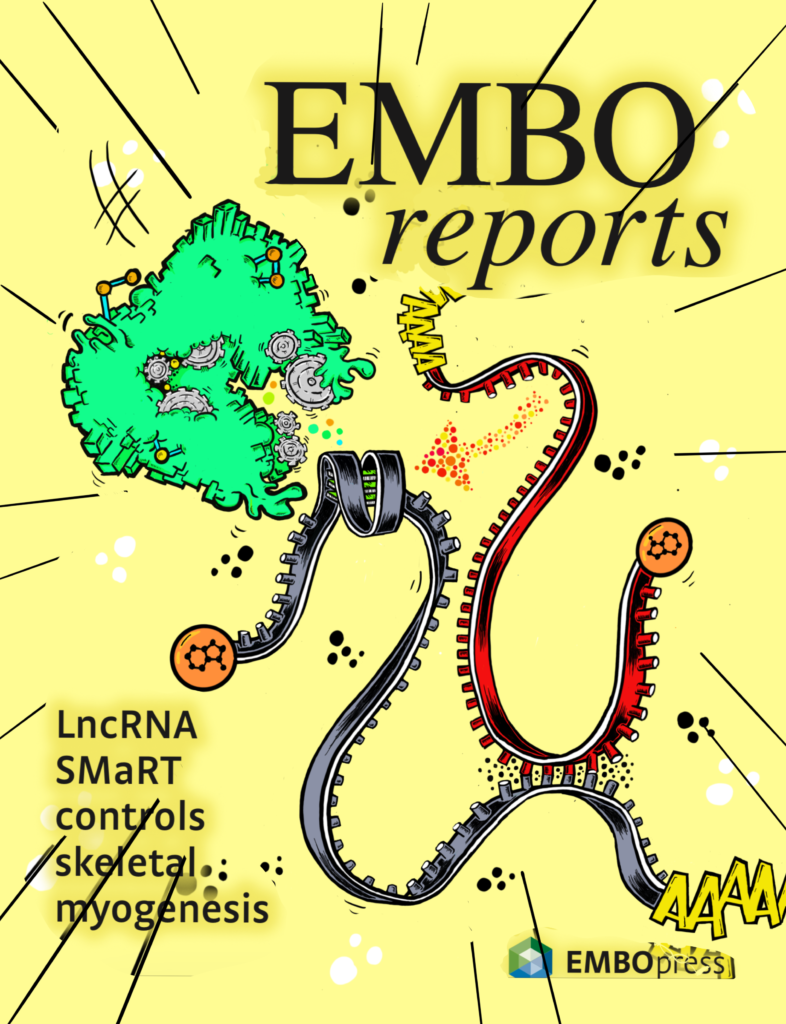L’RNA non codificante regola la trasmissione dei segnali nervosi, un nuovo studio chiarisce come – Una ricerca della Sapienza e dell’Istituto Italiano di Tecnologia ha descritto per la prima volta un meccanismo di controllo della morfologia dei neuroni e delle comunicazioni nervose che si basa sull’interazione tra un RNA non codificante e un RNA messaggero. Lo studio, pubblicato su Nucleic Acids Research, apre nuove interpretazioni sull’effettivo ruolo dei vari tipi di RNA nei processi biologici.
Le molecole di RNA che non producono proteine, dette non codificanti, sono state descritte nell’ultimo decennio di ricerche come fondamentali per la modulazione dell’espressione dell’informazione contenuta nei geni e dei processi che determinano lo sviluppo di tessuti e organi diversi, compreso il sistema nervoso. La loro peculiare caratteristica di agire sul singolo tessuto in maniera specifica e in momenti precisi dello sviluppo e del differenziamento cellulare rende questa classe di molecole estremamente interessante nell’ ambito della ricerca biomedica.
In un recente studio coordinato dalla Sapienza Università di Roma e dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), e finanziato da un progetto ERC-Synergy, è stata scoperta una nuova molecola di RNA non codificante lungo (lncRNA), denominata CyCoNP, ed è stato descritto il meccanismo attraverso il quale regola la ramificazione dei prolungamenti neurali (neuriti) artefici della trasmissione e ricezione degli impulsi nervosi. I risultati del lavoro, pubblicati sulla rivista Nucleic Acids Research, confermano il ruolo degli RNA non codificanti nel controllo dell’omeostasi neuronale, ampliando così la lista di possibili bersagli e approcci terapeutici per il trattamento delle patologie neurologiche.
I ricercatori, coordinati da Irene Bozzoni del Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin della Sapienza e del centro CLN2S di IIT, hanno caratterizzato il meccanismo molecolare e biologico attraverso cui questo lncRNA agisce. Nello specifico, è stato scoperto che CyCoNP è molto abbondante nei motoneuroni umani, in particolare nella fase precoce di differenziamento dove sono abbondanti cellule allo stadio di progenitori neurali. In queste cellule, il lncRNA regola in maniera puntuale i livelli di espressione di NCAM1, una proteina fondamentale per la funzionalità neuronale e specialmente per la regolazione della ramificazione dei neuriti. I ricercatori sono riusciti a dissezionare nel dettaglio il meccanismo d’azione di CyCoNP, che coinvolge l’interazione fisica tra il lncRNA, l’RNA messaggero che permette la produzione di NCAM1 e un microRNA che è in grado di bersagliare entrambe le molecole.
Il lavoro, che descrive un meccanismo di azione finora non ancora caratterizzato per gli RNA non codificanti, contribuisce in maniera significativa ad espandere le conoscenze sul funzionamento di questa eterogenea classe di molecole e di quanto queste possano avere un ruolo chiave in processi vitali delle nostre cellule, come la regolazione della trasmissione dei segnali nervosi.
Mantenere alta l’attenzione sullo studio delle molteplici modalità d’azione degli RNA non codificanti è cruciale per chiarire nuovi meccanismi attraverso i quali l’RNA funziona in specifici processi biologici.
Riferimenti bibliografici:
CyCoNP lncRNA establishes cis and trans RNA-RNA interactions to supervise neuron physiology – Desideri F, Grazzi A, Lisi M et al., Nucleic Acids Research 2024, DOI:10.1093/nar/gkae590

Testo dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma