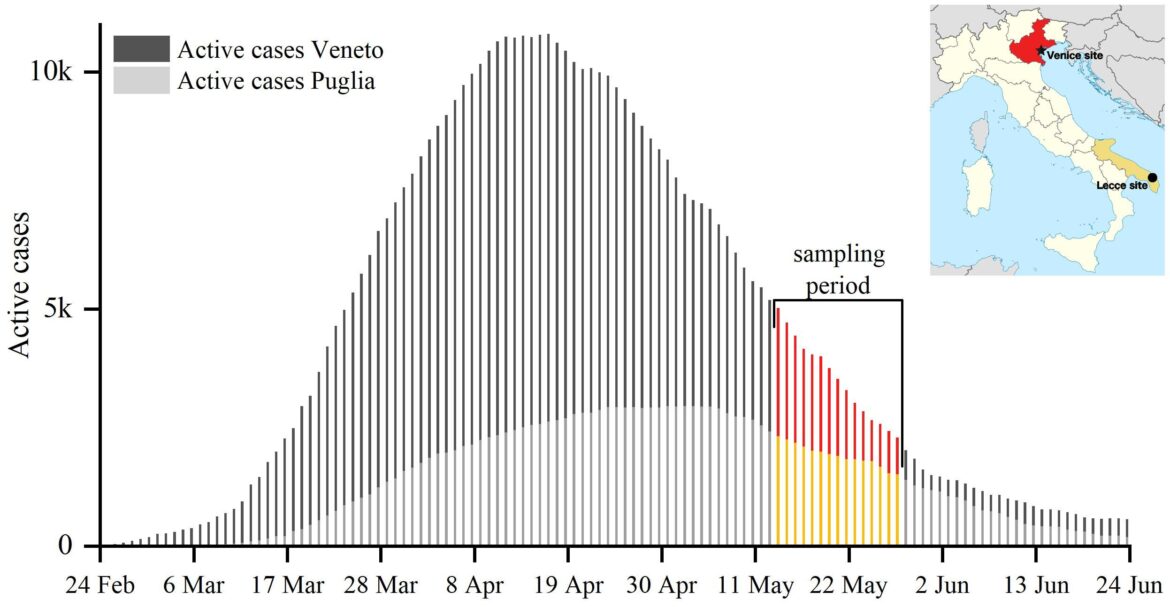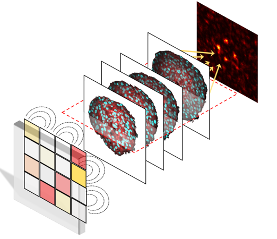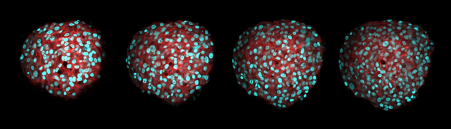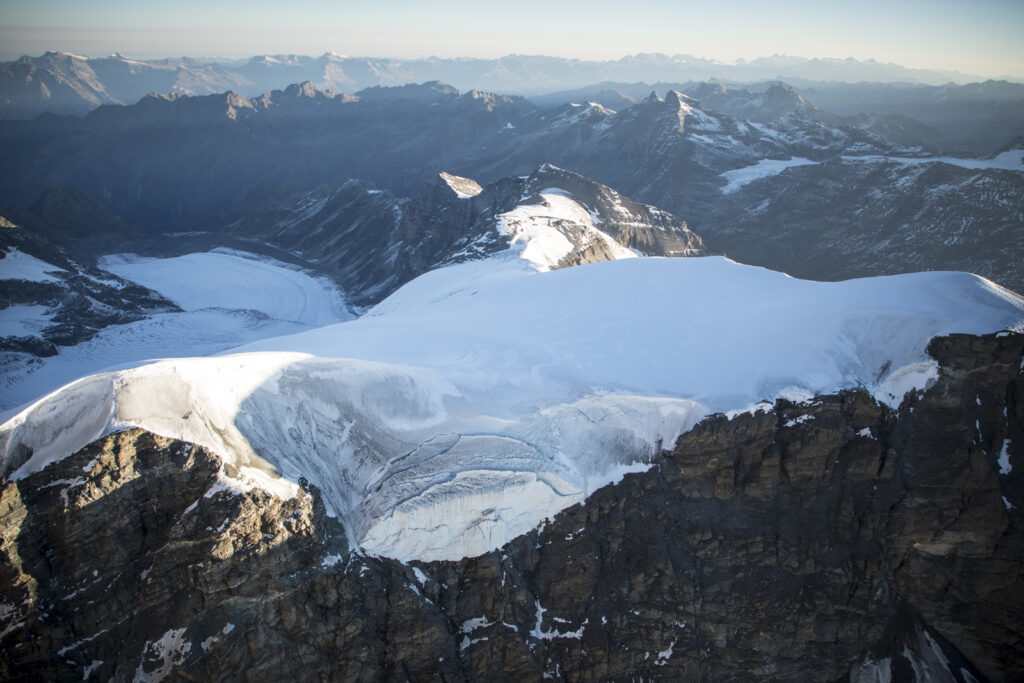Futuro Remoto 2020 – XXXIV edizione – Pianeta, tra cambiamenti epocali e sfide globali
La ricerca scientifica e tecnologica rappresenta un punto cardine con cui preservare e migliorare il benessere dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. Il suo ruolo indiscusso non è sempre in connessione con i cittadini, a discapito di un sapere scientifico che dovrebbe essere accessibile a tutti, soprattutto in un momento storico nel quale le informazioni scorrono in maniera disordinata e rapida, distorcendo spesso la realtà. Quest’anno più di qualsiasi altro ci ha dimostrato uno degli effetti dei cambiamenti che il Pianeta Terra sta subendo, ovvero la pandemia da Covid-19, un fenomeno altamente ripetibile in futuro.

Mostra Missione Antartide alla XXXIV edizione di Futuro Remoto
Futuro Remoto, giunto alla XXXIV edizione, ha come filo conduttore quello di creare una rete di conoscenze tra scienza e pubblico, con più di 300 eventi in programma, tra mostre, rubriche speciali ed incontri internazionali in streaming per discutere dei cambiamenti climatici, della salute del Pianeta e della pandemia da Covid-19. Il festival è promosso da Città della Scienza di Napoli, con il sostegno della Regione Campania, la co-organizzazione delle sette Università della Campania e la collaborazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica-Inaf, del Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, dell’Ambasciata italiana in Messico, del consolato Generale Usa di Napoli e dell’Unione Industriali di Napoli.

L’evento inaugurale tenutosi il 20 Novembre ha dato inizio, a pieno ritmo, al festival con una diretta tenuta da Riccardo Villari, Presidente Fondazione IDIS – Città della Scienza, che introduce il saluto del Ministro MIUR Gaetano Manfredi e di Valeria Fascione, assessore alla ricerca, innovazione e startup della Regione Campania, i quali ricordano lo spirito di Futuro Remoto come luogo dove far crescere la cultura nella collettività con l’incontro tra scienza e pubblico.
Città della Scienza propone da anni il festival come una realtà che possa trasferire il sapere e la conoscenza scientifica ai cittadini, creando una vetrina per la ricerca, affinché si abbia una maggiore consapevolezza sulla salute dell’uomo e, in questo caso, del Pianeta Terra.
È seguito il talk introdotto da Luigi Nicolais – Coordinatore CTS Fondazione IDIS – Città della Scienza – e moderato da Luca Carra – direttore di Scienzainrete – in cui sono intervenuti illustri studiosi. Da Piero Genovesi, zoologo, ecologo specializzato in biodiversità a Filippo Giorgi, fisico e climatologo parte del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPPC). Sono intervenuti poi Roberto Danovaro, ecologo e biologo marino presidente della Stazione zoologica Anton Dohrn, Patrizia Caraveo, astrofisica la quale mette in risalto il tema dell’inquinamento luminoso, e Paolo Vineis, medico epidemiologo e docente all’Imperial College di Londra in salute globale. Egli risponde al tema dell’emergenza ambientale come fattore influente sulla salute dell’uomo insieme alle diseguaglianze sociali.
Al termine dell’inaugurazione, sono intervenuti i rettori delle Università della Campania insieme a Marcella Marconi – Direttore Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Luisa Franzese – Ufficio scolastico regionale per la Campania e Massimo Inguscio – Presidente CNR.
La settimana successiva è iniziata ancor più a pieno ritmo, con nomi noti al grande pubblico, come Ilaria Capua. La virologa di fama mondiale per gli studi sull’influenza aviaria e i dibattiti riguardo la scienza open-source, ha partecipato alla live moderata da Luca Carra, discutendo su approcci atti a migliorare le metodiche con cui affrontare eventi tra cui quelli pandemici. Durante il talk si sono proposti temi contenuti del suo libro “Salute circolare: una rivoluzione necessaria”, come l’importanza dell’interdisciplinarietà nella ricerca scientifica utile a creare equilibri nuovi e virtuosi rendendola più sostenibile e convergente. Il concetto di salute è da considerare come un punto di connessione tra uomo, animali ed ambiente e le conoscenze trasversali virando l’approccio verticale alla complessità dei problemi.
Nel pomeriggio di Lunedì 23 è seguito un talk di approfondimento a ricordi dei 40 anni dal terremoto dell’Irpinia-Lucania, uno dei più forti che si ricordino in Italia. Giorgio Della Via a moderare insieme a Maddalena De Lucia, addetta alla divulgazione presso l’Osservatorio vesuviano, hanno introdotto gli argomenti trattati ed i relatori, i quali si sono tutti trovati a vivere in prima persona il fenomeno sismico ed in un secondo momento a studiarlo. Mario Castellano, dirigente tecnologo dell’Osservatorio Vesuviano sezione Napoli dell’ INGV, Girolamo Milano, ricercatore geofisico dell’Osservatorio Vesuviano e Giuliana Alessio, ricercatore presso l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno raccontato il tipo di sisma, come fu studiato, le cause e gli aspetti tecnici del terremoto dell’Irpinia. La rete sismica del Meridione era composta da una serie di stazioni il cui numero fu ampliato sul territorio per aumentare le informazioni da raccogliere ed analizzare meglio il fenomeno anche ai finiti studi successivi riguardo la dinamica sismica. Il terremoto del 1980 è stato un momenti di svolta per capire i meccanismi alla base e per confermare, il termini di prevenzione, l’aspetto edile come unica chiave per limitare i danni.
Nella mattina di Martedì 24 si è tenuta una live molto interessante, dal titolo “Istruzione, Ricerca e Medicina in Africa” durante la quale sono intervenuti Pasquale Maffia, professore associato in immunologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Mayowa Ojo Owolabi, Preside della Facoltà di Medicina di Ibadan in Nigeria, Ntobeko Ntusi, Preside della Facoltà di Medicina presso l’Università di Cape Town e Wilson Mandala Oda, Professore alla Malawi University of Science and Technology e al College of Medicina dell’Università del Malawi. Si è discusso sul tema pandemia da Covid-19 in Africa, su come è stata affrontata e sul suo andamento in associazione ad un approccio più precario riguardo le campagna di vaccinazione, oltre all’importanza dell’istruzione e dell’università nella risoluzione di problematiche sanitarie, ricerca scientifica e medicina.
Per giovedì 26 gli appuntamenti sono stati tanti, tra cui alle ore 15:00 un talk dal titolo “+Innovation +Green +Future. Tecnologie digitali e processi Industriali Virtuosi di sostenibilità ambientale”. Luigi Nicolais introduce Riccardo Villari, Presidente della Fondazione IDIS, Valeria Fascione, assessore alla ricerca, innovazione e startup della Regione Campania e Maurizio Manfellotto, presidente Unioni Industriali Napoli, i quali hanno riflettuto sul tema della sostenibilità con un richiamo all’assetto politico e sociale che la gestisce.
Il primo intervento è stato di Reimung Neugebauer, Presidente del Fraunhofer – Gesellschaft, la più grande organizzazione di ricerca applicata in Europa. Illustrata la diffusione dei centri in Europa ed in Italia, tra cui con l’Università degli studi di Napoli Federico II, e l’aspetto strategico ed economico del “Fraunhofer model”. Si è sottolineato come sia fondamentale realizzare la sostenibilità e mirare a creare strategie innovative per raggiungere quest’obiettivo, coinvolgendo le industrie.
A seguire Pietro Palatino, Presidente di MediTech Competence Centre I4.0, che ha richiamato il concetto di economia circolare applicata all’industria. Sono intervenuti anche Marco Zigon, Presidente di GETRA, azienda che appartiene alla filiera di produzione e distribuzione dell’energia elettrica; Massimo Moschini, Presidente e Amministratore Delegato Laminazione Sottile e Maria Cristina Piovesana, Vicepresidente Confindustria per l’Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura.
Nel pomeriggio di Giovedì 26, un altro appuntamento ha visto come protagonista Barbara Gallavotti, biologa ed autrice di programmi come SuperQuark e Ulisse. La giornalista scientifica ha discusso la paura che l’uomo ha di non poter controllare la scienza, insieme a Giulio Sandini, bioingegnere dell’IIT, a Claudio Franceschi, immunologo dell’Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna, a Maurizio Mori, professore di bioetica presso l’Università di Torino e a Gennaro Carillo, filosofo dell’Università SuorOrsola Benincasa di Napoli.
Nella live del titolo “Da Frankenstein al futuro”, la Gallavotti ha raccontato di Mary Shelley e di Frankestein, un corpo che da vita alla paura che la scienza non sia sotto il controllo dell’uomo. Nel talk si è affrontato in maniera interdisciplinare come queste paure siano traslate alla nostra epoca ed al futuro, toccando punto come l’aspettativa di vita, la trasmissione della vita umana ed il non adattamento dell’uomo al mondo.
A cornice dei vari eventi, Venerdì 20, Domenica 22, Lunedì 23, Mercoledì 25 e Sabato 28 il pirata Barbascura X ha tenuto live con ospiti importanti, tutte visionabili sul suo canale Twitch o su YouTube.
Tanti altri eventi si sono articolati in rubriche speciali, mostre virtuali, laboratori virtuali e talk, disponibili sulla pagina Facebook o sul canale YouTube.

Si ringrazia Futuro Remoto – Città della Scienza per le foto.