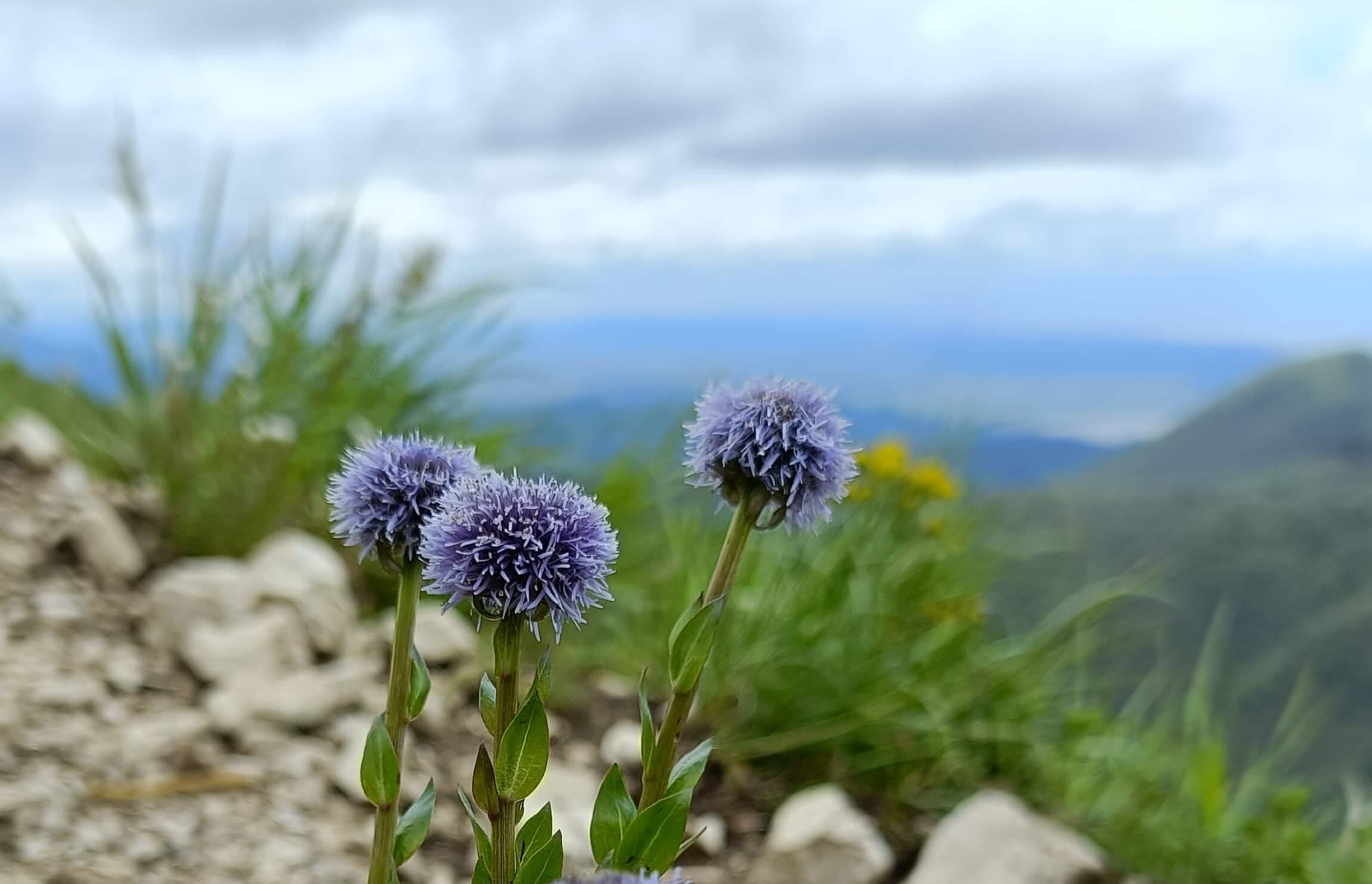PALMA DI GOETHE: ALL’ORTO BOTANICO DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA È STATO SEQUENZIATO IL SUO GENOMA
È il primo sequenziamento genomico di alta qualità a livello cromosomico della palma nana del Mediterraneo, unica nativa dell’Europa continentale e specie con la distribuzione più a nord tra tutte le palme. Nel suo DNA vi sono molte sequenze ripetute: tracce di antichi adattamenti.
È stato pubblicato su «Scientific Data» con il titolo “Chromosome-level assembly of the 400-year-old Goethe’s Palm (Chamaerops humilis L.)” lo studio, coordinato da Francesco Dal Grande dell’Università di Padova e frutto della collaborazione con il Centro per la Biodiversità Genomica di Francoforte e altri partner internazionali, in cui è stato effettuato il primo sequenziamento genomico di alta qualità a livello cromosomico della palma nana del Mediterraneo ed è stato effettuato sulla “Palma di Goethe” all’Orto Botanico dell’Università di Padova.
Il rapido declino della biodiversità globale mette in luce la necessità di aumentare gli sforzi di conservazione. I giardini botanici di tutto il mondo svolgono un ruolo cruciale nella conservazione ex situ delle piante. In particolare, le piante monumentali hanno un grande valore ecologico e culturale, che deve essere tutelato.
L’esemplare di palma nana o palma di San Pietro (Chamaerops humilis L.), messa a dimora nel 1585, è la pianta più antica dell’Orto botanico di Padova ed è nota come Palma di Goethe. Dopo averla ammirata il 27 settembre 1786, infatti, il poeta tedesco ne trae ispirazione per formulare una intuizione evolutiva nel suo saggio La metamorfosi delle piante del 1790, legando così il suo nome a quello della palma “padovana”, per sempre. Nel tempo, la Palma di Goethe è diventata simbolo del legame profondo tra scienza, cultura e natura. La palma nana cresce spontaneamente lungo le coste del Mediterraneo occidentale in formazioni a macchia degradata, spesso in luoghi inaccessibili per sfuggire allo sfruttamento e sottrarsi così alle azioni invasive messe in atto dall’essere umano. Eredità della flora italiana del Terziario (circa 65 milioni di anni fa), attualmente è l’unica specie di palma autoctona a essere sopravvissuta alle glaciazioni che hanno colpito l’Europa fino a 12.000 anni fa.
«Oggi, quasi 240 anni dopo, siamo ripartiti dalla stessa palma per intraprendere un nuovo viaggio. Lo abbiamo fatto in collaborazione con il Centro di Biodiversità Genomica di Francoforte sul Meno, in Germania. La città natale di Goethe, appunto. E abbiamo ottenuto un genoma di altissima qualità. All’Orto botanico dell’Università di Padova abbiamo sequenziato il genoma della Palma di Goethe, la palma coltivata più antica preservata in un orto botanico», spiega Francesco Dal Grande, docente di Botanica sistematica ed Ecologia applicata al Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova. «Si tratta del primo genoma della palma nana del Mediterraneo, Chamaerops humilis, l’unica palma nativa dell’Europa continentale e la specie con la distribuzione più a nord tra tutte le palme. Nel nostro studio abbiamo scoperto che nel suo DNA vi sono tantissime sequenze ripetute: tracce di antichi adattamenti che, molto probabilmente, hanno permesso alla specie di adattarsi a climi aridi e caldi, come quelli del Mediterraneo. Il genoma ottenuto ci ha permesso anche di svelare un segreto storico: l’origine di questa pianta», continua Dal Grande. «I dati genomici indicano chiaramente un legame tra questa palma e le popolazioni dell’area occidentale del Mediterraneo, la Penisola Iberica e il Marocco. Questo è un esempio di come il DNA possa nutrire la storia, qualora i documenti da soli non bastassero. In un’epoca di forte declino della biodiversità, conoscere in maniera così approfondita il genoma di una specie diventa un vantaggio, uno strumento in più e molto potente per capirla, proteggerla e conservarla nel tempo».
«Grazie alla ricerca pubblicata oggi sappiamo di più sul nostro simbolo, la Palma di Goethe del 1585, e sulla sua provenienza – dice Tomas Morosinotto, Prefetto dell’Orto Botanico -. Utilizzando i metodi più attuali di analisi possiamo capire come la pianta più antica del nostro Orto botanico si è adattata a un clima che non era il suo: uno studio attuale su una pianta con più di quattro secoli di storia, nell’epoca del cambiamento climatico».
In questo nuovo studio, Dal Grande e colleghi presentano il primo assemblaggio genomico di alta qualità, a livello cromosomico, di Chamaerops humilis L., ottenuto grazie a tecnologie all’avanguardia che consentono di leggere e organizzare il DNA con estrema precisione (PacBio HiFi e Arima Hi-C). Ad oggi, questo genoma è il più contiguo e completo all’interno della famiglia delle Arecaceae, con un contenuto di sequenze ripetute dell’88%, di cui il 63% è attribuito agli elementi Long Terminal Repeat (LTR). Un contenuto così elevato di sequenze ripetute ci dice che il genoma è stato modellato da pressioni evolutive intense, probabilmente legate al clima mediterraneo.
Lo studio presenta anche la prima analisi completa dei microRNA in una palma. I microRNA sono piccole molecole regolatorie che controllano quali geni vengono attivati o disattivati. È stata identificata per la prima volta nelle palme la famiglia miR827, che nelle piante aiuta a regolare l’assorbimento di nutrienti fondamentali come il fosforo e l’azoto. Trovare una famiglia di microRNA finora sconosciuta nelle palme apre nuove strade per capire come le piante rispondano a stress ambientali e carenze nutrizionali.
Infine, grazie all’analisi dei microsatelliti – brevi sequenze ripetute di DNA utilizzate per tracciare le origini genetiche – i ricercatori hanno scoperto che l’esemplare patavino condivide affinità con popolazioni dell’area occidentale del Mediterraneo, in particolare tra Marocco e Penisola Iberica.
Questi risultati rappresentano un significativo progresso nella genomica della conservazione della specie e gettano le basi per nuove strategie di conservazione: in questo scenario i giardini botanici sono e, sempre di più, saranno attori protagonisti nella salvaguardia della biodiversità globale.
Riferimenti bibliografici:
Beltran-Sanz, N., Prost, S., Malavasi, V. et al., Chromosome-level assembly of the 400-year-old Goethe’s Palm (Chamaerops humilis L.), Scientific Data, 12, 1542 (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41597-025-05673-7
Testo, video e immagini dall’Ufficio Stampa dell’Università di Padova