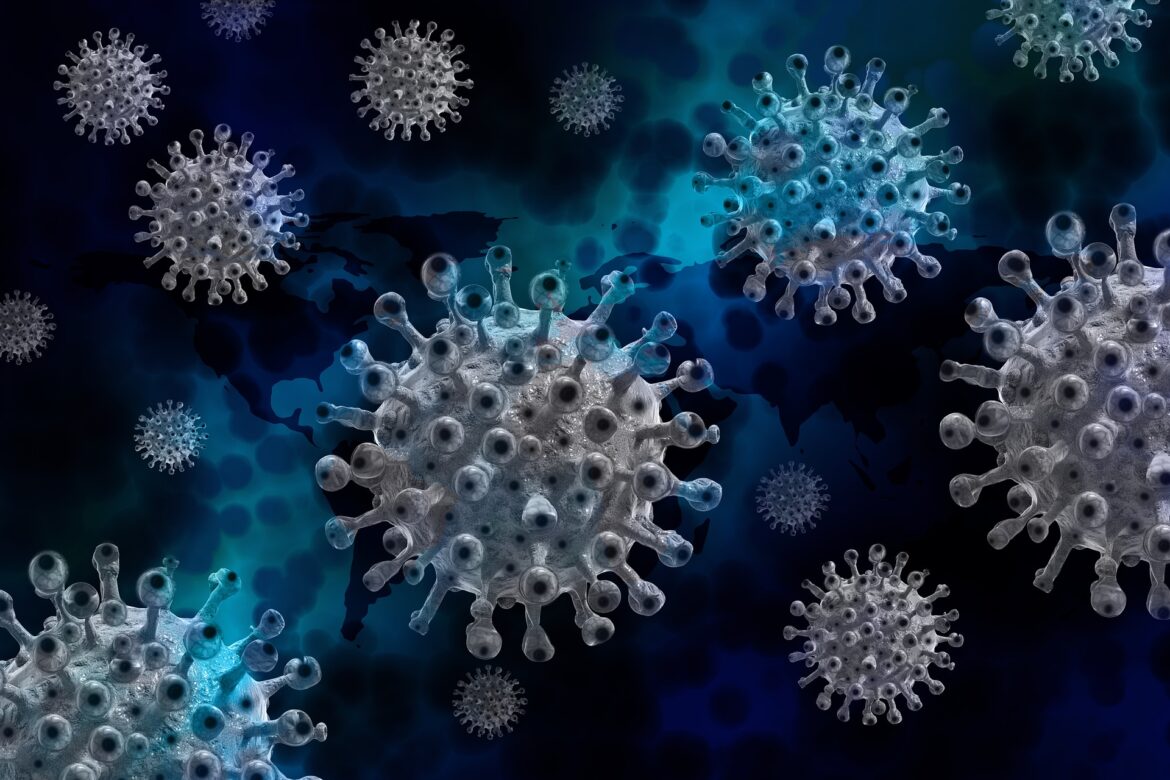L’oro verde delle Alpi: il progetto NETTLE (ri)scopre le piante alpine e i loro benefici
Il progetto transfrontaliero NETTLE, coordinato dalla Libera Università di Bolzano, mira a valorizzare le piante alpine caratterizzando le proprietà funzionali dei loro estratti. Un futuro promettente con applicazioni in campo farmaceutico ed alimentare.

Le piante officinali sono note ed utilizzate sin dall’antichità per le loro proprietà aromatiche e curative. La saggezza del detto di Ippocrate “Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo” rappresenta bene il rinato interesse verso le piante medicinali che è alla base di un sempre maggiore numero di studi che si occupano delle loro funzioni curative. A questa filosofia si è ispirato anche il progetto NETTLE, finanziato dal programma europeo Interreg Italia-Austria, che mira a scoprire e far riscoprire il valore delle piante alpine ai cittadini, alle imprese e agli istituti di ricerca.
NETTLE nasce da una collaborazione tra la Libera Università di Bolzano, l’Università di Udine e l’Università di Salisburgo. I tre atenei collaborano, condividendo competenze ed esperienze già a partire dal campo dove vengono raccolte le piante di interesse. La meta è rappresentata dalla creazione di un database accessibile al pubblico che permetta a tutte le persone o istituzioni pubbliche e private interessate di conoscere le proprietà delle piante alpine. Un esempio è l’achillea millefoglie, una tra le specie più presenti nei prati delle nostre montagne che però non è molto conosciuta. Questa pianta presenta una lunghissima lista di proprietà medicinali: nelle valli è infatti usata non solo come calmante e antidepressivo, ma anche per disintossicare il corpo, per alleviare i dolori e come condimento nelle pietanze. Più conosciuta è invece l’ortica, ricca di ferro e potente diuretico, utilizzata per rafforzare il sistema immunitario, ma ottima soprattutto in piatti tipici dell’Alto Adige e dell’Austria come canederli e spätzle.
“L’intento del progetto NETTLE è quello di trasferire al tessuto produttivo, alla cittadinanza e agli enti di ricerca della regioni coinvolte le competenze necessarie per immettere sul mercato ed utilizzare gli estratti naturali ottenuti dalle piante alpine”,
afferma Giovanna Ferrentino, professoressa di Scienze e tecnologie alimentari alla Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari di unibz e responsabile del progetto.

Le fasi del progetto
NETTLE, iniziato a febbraio di quest’anno, si divide in più fasi. I ricercatori e le ricercatrici delle Università di Bolzano e di Salisburgo si occuperanno della raccolta di oltre 30 piante alpine della regione transfrontaliera coordinati dal prof. Stefan Zerbe, botanico della Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari di unibz. La raccolta in Alto Adige si svolgerà sui prati del maso “Il Castellino delle Erbe” a Coldrano, che da anni si impegna nella coltivazione biologica di erbe officinali ed aromatiche. Una volta ottenute ed essiccate le piante, si procederà all’estrazione dei composti di interesse. In questa fase i ricercatori confronteranno l’efficacia delle tecniche tradizionali, quali l’estrazione con solventi organici, con quella di metodi più innovativi e sostenibili dal punto di vista ambientale, come l’uso di anidride carbonica supercritica, ultrasuoni e campi elettrici pulsati. Gli estratti ottenuti verranno poi testati su linee cellulari umane per valutare le loro proprietà antiossidanti, antimicrobiche, antiinfiammatorie e cicatrizzanti. Oltre alle proprietà farmaceutiche, verrà valutata anche l’attività antiossidante degli estratti negli alimenti.
“Questi estratti potrebbero fungere da conservanti naturali in quanto il loro utilizzo in oli vegetali, come ad esempio quelli di girasole e lino, o la loro applicazione in grassi di origine animale quali lo speck potrebbe favorire un rallentamento della loro ossidazione, evitandone quindi l’irrancidimento”, conclude Ferrentino.
Il progetto NETTLE rappresenta quindi un’importante punto di incontro tra la crescita delle aziende locali e la conservazione della biodiversità dell’area transalpina e sottolinea l’importante ruolo della natura nell’economia e nella società.

Testo e foto dall’Ufficio Stampa e organizzazione eventi Libera Università di Bolzano