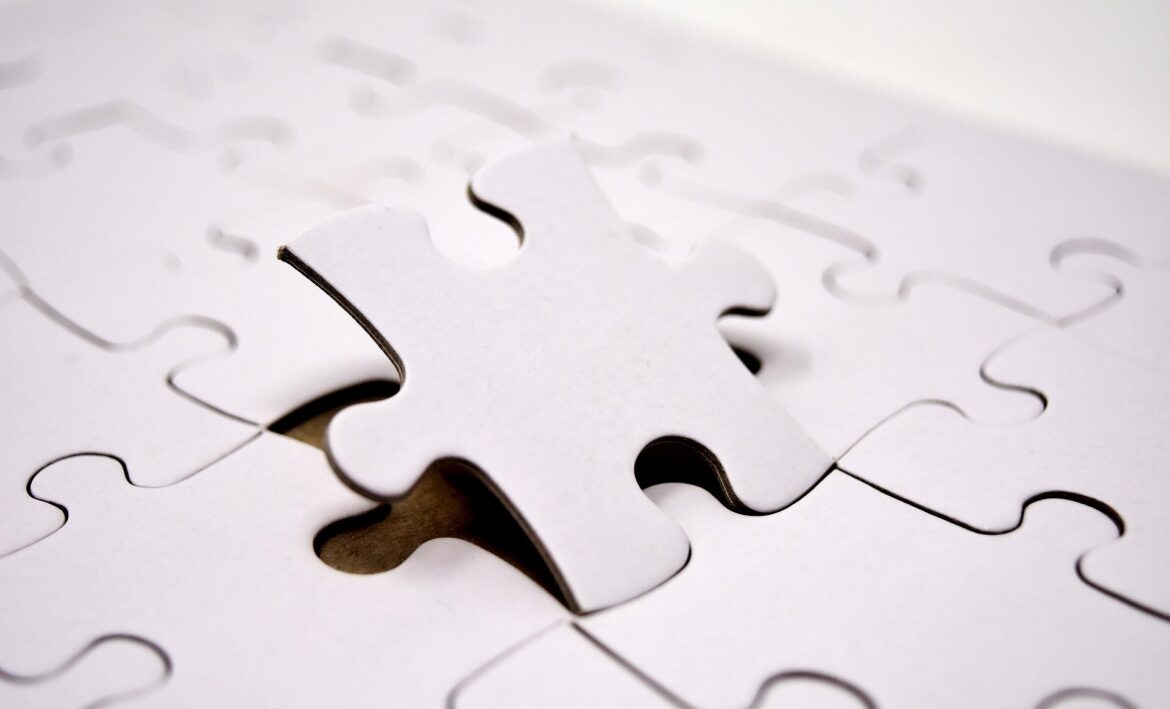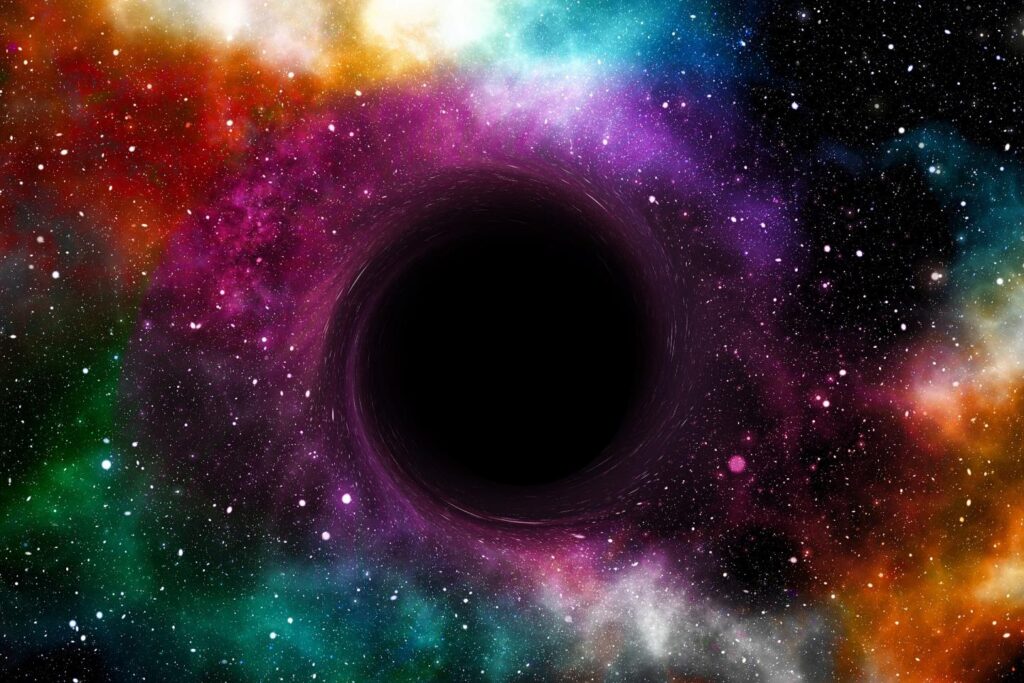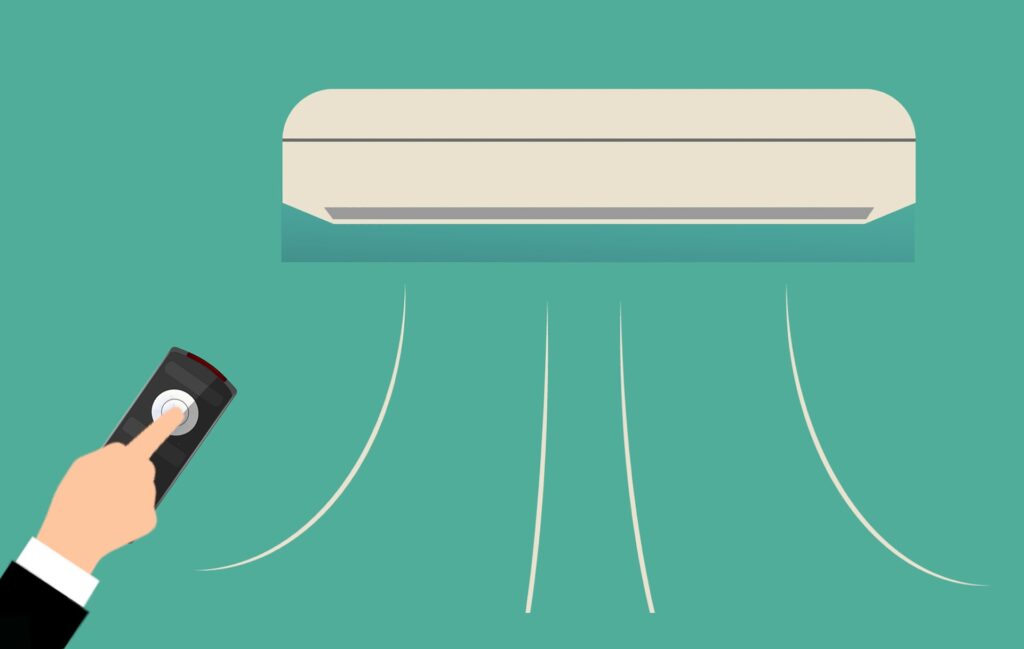Nuovo modello epidemico da economisti di Ca’ Foscari e Cambridge
COVID-19: MISURE ‘SOFT’ POSSONO EVITARE SECONDO PICCO
CONFERMA DA STUDIO CHE CONSIDERA I CASI ‘SOMMERSI’
In Lombardia e a Londra censita solo una minima parte dei casi.
Mascherine, distanze, igiene e isolamento degli infetti possono prevenire una nuova ondata di decessi
VENEZIA – Mascherine e distanziamento fisico possono sostituire il lockdown in modo efficace, scongiurando una seconda ondata dell’epidemia, in Lombardia come a Londra. Due economisti italiani sono giunti a questa conclusione considerando sia i dati ufficiali di contagi, guarigioni e decessi, sia i numeri, più difficili da stimare, dei casi non osservati (almeno il doppio di quelli censiti) e delle morti per Covid-19 non rilevate (il 35% in più del dato ufficiale in Lombardia, il 17% in più a Londra). Lo studio è stato pubblicato nei giorni scorsi su Covid Economics, una pubblicazione speciale del Centre for Economic Policy Research.
“Il modello epidemico che proponiamo è stimato in Lombardia e a Londra, due regioni particolarmente colpite dal virus – spiega Dario Palumbo, “Carlo Giannini” Fellow al Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e coautore dello studio con Salvatore Lattanzio dell’Università di Cambridge – tiene conto anche degli stati non osservati e delle politiche sulla mobilità e prevede l’evoluzione della malattia in base a diverse politiche. Mostriamo come mitigare la probabilità di contagio con misure ‘soft’, riducendola fino al 20/40% rispetto a uno scenario senza misure, abbia effetti positivi paragonabili a quelli di un prolungamento del lockdown”.
Per i ricercatori, è evidente come le statistiche ufficiali abbiano sottostimato casi e decessi. Per questo, hanno elaborato un modello matematico che prevede quattro possibili stati delle persone rispetto all’epidemia (suscettibile, esposto, infetto e deceduto), ma introducendo per infetti, guariti e deceduti due tipologie: osservati e non osservati.
Alla fine del periodo su cui è stato testato il modello (9 aprile in Lombardia e 15 aprile per Londra), stimano che fossero stati contagiati il 5,7% dei lombardi e il 2% dei londinesi. Significa che i ‘non osservati’ sarebbero stati il doppio dei casi riportati dalle statistiche, che i guariti sarebbero stati tra le 20 e le 26 volte in più rispetto a quelli censiti e che il numero di decessi per Covid-19 sia stato sottovalutato del 35% in Lombardia e del 17% a Londra.
Grazie al modello, poi, gli economisti hanno calcolato scenari di progressivo riavvio della mobilità, ipotizzando una ripresa della circolazione delle persone fino al 75% del livello pre-pandemia.
“Senza alcuna misura di contenimento, vediamo inevitabile un secondo picco dell’epidemia e una ripresa dei decessi – afferma Palumbo – tuttavia, agendo sulla probabilità di contagio il secondo picco diventa meno probabile. In particolare, riducendo tale probabilità del 40% in Lombardia e tra il 20 e il 30% a Londra, il bilancio delle vittime torna in linea con quello di un lockdown permanente”.
La rimozione delle restrizioni del lockdown, dimostra la ricerca, non implica una ripresa della curva epidemica in presenza di politiche attive che promuovono la riduzione della probabilità di infezione come distanziamento fisico, mascherine, migliore igiene e isolamento dei casi infetti.
“Non adottare queste misure di mitigazione – conclude Palumbo – significa rischiare un secondo picco anche in scenari in cui il lockdown viene allentato in modo molto graduale, come avvenuto in Italia”.
Il metodo
La novità dello studio sta anche nella metodologia sviluppata dai due economisti, che a un modello epidemiologico di tipo SEIRD (Susceptible-Infected-Exposed-
Lo studio: https://cepr.org/sites/

Testo dall’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo Università Ca’ Foscari Venezia