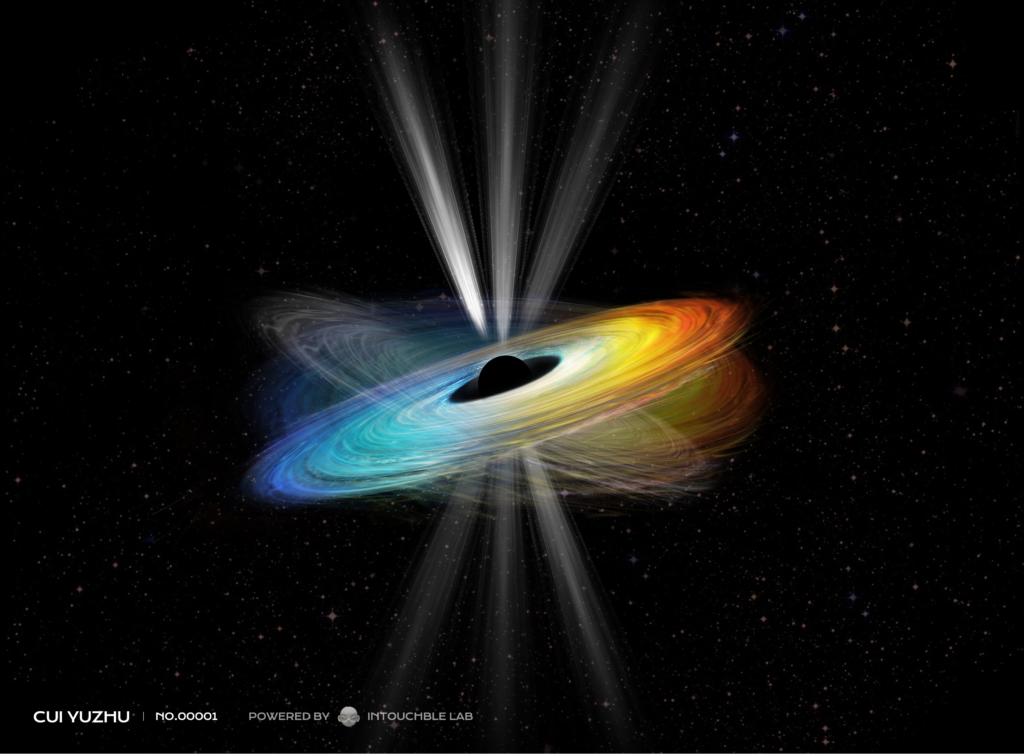LOFAR SVELA FILAMENTI RADIO DI ORIGINE INCERTA: L’IMMAGINE PIÙ PROFONDA E AD ALTA RISOLUZIONE DELL’AMMASSO DI GALASSIE ABELL 2255
Un team internazionale di astrofisici guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha ottenuto l’immagine più profonda e ad alta risoluzione mai realizzata dell’ammasso di galassie Abell 2255, situato a circa 800 milioni di anni luce dalla Terra e caratterizzato da complesse strutture radio su molteplici scale. Lo studio, pubblicato su Astronomy & Astrophysics, ha permesso di osservare con dettaglio senza precedenti le principali radiogalassie dell’ammasso, generate da getti di particelle che viaggiano a velocità prossime a quella della luce ed espulsi da enormi buchi neri centrali, rivelando per la prima volta una rete intricata di filamenti sottili, emittenti radiazione non termica, la cui origine è ancora sconosciuta.

Le nuove immagini sono state ottenute in modalità di interferometria a lunghissima base VLBI (o VLBI dall’inglese Very Long Baseline Interferometry) dalle stazioni internazionali del radiotelescopio europeo Low Frequency Array (LOFAR), la più estesa rete al mondo, attualmente operativa, per osservazioni radioastronomiche a bassa frequenza. Si tratta delle osservazioni più profonde mai realizzate con questa tecnica su un ammasso di galassie e hanno permesso di ricostruire la storia evolutiva delle radiogalassie, dalle prime fasi fino al loro spegnimento. Un risultato che apre nuove prospettive sullo studio dell’evoluzione di questi oggetti e delle complesse interazioni con il mezzo intergalattico turbolento in ambienti dinamici come Abell 2255.

Grazie a 56 ore di osservazioni alla frequenza radio di 144 MHz, i ricercatori e le ricercatrici hanno ottenuto immagini profonde e con una risoluzione angolare fino a 0,3 arcosecondi: una combinazione eccezionale a queste frequenze, resa possibile dalla lunga esposizione e da tecniche interferometriche avanzate. Questo ha permesso di rivelare strutture filamentose estremamente allungate, con lunghezze comprese tra 260 mila e 360 mila anni luce — ovvero tre o quattro volte il diametro della Via Lattea — e spessori oltre dieci volte inferiori. Secondo i ricercatori questi filamenti potrebbero originarsi all’interno delle radiogalassie, per poi essere trascinati via da moti turbolenti fino a mescolarsi con il mezzo esterno.
L’attenzione si è concentrata in particolare sulla cosiddetta Original Tailed Radio Galaxy, una galassia radio dalla coda intricata e ricca di filamenti, mai osservata prima con un tale livello di dettaglio. Le nuove immagini rivelano inoltre dettagli inediti di altre radiogalassie all’interno dell’ammasso, come la Goldfish, la Beaver e l’Embryo, caratterizzate da morfologie distorte e lunghe code radio che si estendono per oltre 200 mila anni luce.
“Il nostro obiettivo principale era utilizzare LOFAR-VLBI per individuare eventuali filamenti nelle code delle radiogalassie di Abell 2255, al fine di studiarne le caratteristiche morfologiche e comprenderne l’origine”, spiega Emanuele De Rubeis, primo autore dello studio e dottorando al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Università di Bologna e l’INAF nella sede bolognese.
“Fenomeni di questo tipo emergono sempre più frequentemente grazie ai moderni interferometri, come i precursori del progetto SKA, e offrono preziose opportunità per indagare le proprietà magnetiche del gas caldo che permea l’ammasso e i meccanismi di accelerazione delle particelle”.
Questo lavoro è stato possibile grazie ai recenti sviluppi delle tecniche di calibrazione dei dati LOFAR-VLBI, in cui la comunità INAF gioca un ruolo di primo piano. Dal 2018 l’INAF è infatti parte integrante del consorzio LOFAR e il contributo dei suoi team di ricerca è stato determinante sia nell’analisi che nell’interpretazione dei dati. L’intera fase di analisi è stata condotta presso l’Istituto di Radioastronomia di Bologna, grazie alle ingenti risorse computazionali messe a disposizione dalle macchine dei cluster LOFAR e del sistema di calcolo ad alte prestazioni INAF-Pleiadi nel Centro di Calcolo dell’istituto bolognese.
De Rubeis aggiunge: “Abbiamo calibrato 56 ore di osservazioni, suddivise in sessioni notturne da circa 8 ore ciascuna. I dati grezzi di ogni notte pesano circa 4 terabyte, ma dopo la calibrazione il loro volume sale a 18–20 terabyte per un totale di circa 140 terabyte complessivi”.
È una mole di dati enorme per una osservazione di un campo singolo, tra le più vicine per scala a quelle previste per il progetto SKA.
“Ovviamente, calibrare i dati e ottenere immagini di qualità ha richiesto molti tentativi. Per elaborare completamente una singola notte e produrre le immagini di tutte le sorgenti, abbiamo impiegato in media circa un mese”.
“Questi risultati aprono la strada a nuove prospettive per lo studio non solo delle radiogalassie ma anche delle proprietà del gas che permea gli ammassi di galassie” conclude Marco Bondi primo ricercatore INAF a Bologna e secondo autore dello studio.
Questo lavoro rappresenta un primo passo verso un’indagine più ampia: un secondo articolo, già in preparazione, combinerà i dati di LOFAR con osservazioni a frequenze più elevate, ottenute con il Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) in India e il Very Large Array (VLA) negli Stati Uniti, per analizzare l’indice spettrale e la polarizzazione delle strutture appena scoperte.
Per ulteriori informazioni:
Con oltre 25 mila antenne raggruppate in 51 stazioni distribuite in numerosi stati europei e concepito per catturare le onde radio alle frequenze più basse captabili da Terra, LOFAR è la più estesa rete per osservazioni radioastronomiche in bassa frequenza attualmente operativa. Alla fine del 2023 LOFAR è ufficialmente diventato una European Research Infrastructure Consortium (ERIC), di cui l’Italia – tramite l’INAF – è uno dei membri fondatori. Questo nuovo assetto rafforza il coordinamento scientifico e tecnico su scala europea, promuovendo una maggiore interoperabilità tra i nodi della rete e creando sinergie con altre grandi infrastrutture astronomiche di ricerca. L’INAF guida un consorzio nazionale e sta partecipando allo sviluppo della nuova generazione di dispositivi elettronici che equipaggeranno questo radiotelescopio diffuso sul territorio europeo. Il consorzio ha l’obiettivo di fornire agli scienziati italiani le condizioni per l’accesso e l’analisi dei dati di LOFAR, massimizzando l’impatto scientifico della ricerca. L’INAF gestisce, inoltre, l’infrastruttura computazionale nazionale per l’analisi dei dati LOFAR, distribuita in tre siti: Bologna, Trieste e Catania.
L’articolo “Revealing the intricacies of radio galaxies and filaments in the merging galaxy cluster Abell 2255. I. Insights from deep LOFAR-VLBI sub-arcsecond resolution images”, di E. De Rubeis, M. Bondi, A. Botteon, R. J. van Weeren, J. M. G. H. J. de Jong, L. Rudnick, G. Brunetti, K. Rajpurohit, C. Gheller, H. J. A. Röttgering, è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics.
Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF