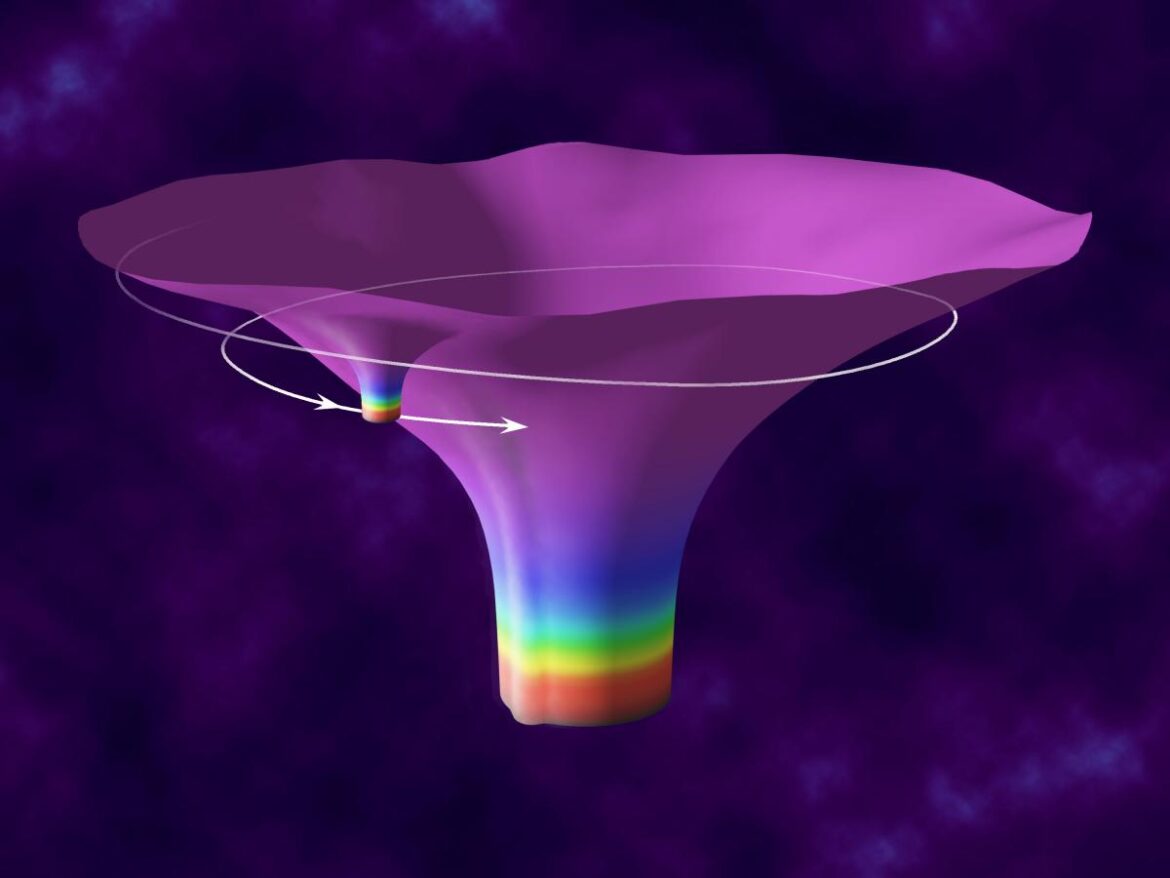Tumori cerebrali: l’effetto positivo della riserva cognitiva
Ci rende più resilienti e attenua le conseguenze del danno cerebrale su memoria e linguaggio: pubblicato su Brain Communications studio dell’IRCCS Medea in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine, la SISSA di Trieste e l’Università di Nottingham.
La riserva cognitiva, cioè la capacità di massimizzare le prestazioni intellettive attraverso il reclutamento differenziale di reti cerebrali o strategie cognitive alternative, protegge le funzioni cognitive dei pazienti affetti da tumore cerebrale.
È quanto è emerso dallo studio Cognitive reserve and individual differences in brain tumor patients, appena pubblicato su Brain Communications. Il lavoro è frutto di una collaborazione tra i ricercatori dell’IRCCS Medea, i neurochirurghi e radiologi dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di Udine e due professori della SISSA di Trieste e della Scuola di Economia dell’Università di Nottingham.
“La crescita di un tumore cerebrale può comportare una riduzione delle abilità cognitive come la memoria, il linguaggio, l’attenzione, le abilità visuo-spaziali – spiega Barbara Tomasino, responsabile scientifica del Polo friulano del Medea e prima autrice dello studio -. Tuttavia si riscontrano tra i pazienti discrepanze tra il grado di malattia e le manifestazioni cognitive della malattia: con i colleghi abbiamo voluto indagare l’origine di queste differenze”.

Lo studio ha incluso un ampio campione di circa 700 pazienti con diagnosi di tumore cerebrale, sottoposti a una risonanza magnetica del cervello e a una batteria di prove volte a misurare le loro capacità cognitive prima di essere sottoposti a un intervento di neurochirurgia.
I ricercatori hanno stimato la loro riserva cognitiva con misure indirette, come l’istruzione, l’occupazione e l’ambiente in cui vivono. Queste misure sono ritenute importanti in quanto espongono il sistema cognitivo a continue stimolazioni dall’ambiente. L’analisi statistica ha tenuto accuratamente conto del tipo, del lato, della sede e della dimensione del tumore, del quoziente d’intelligenza, dell’età e del sesso dei pazienti, al fine di misurare l’effetto della riserva cognitiva su ciascuno dei test eseguiti.
I risultati, oltre a confermare gli effetti attesi delle variabili cliniche sulle funzioni cognitive, hanno mostrato che la riserva cognitiva ha un effetto positivo sulle prestazioni neuropsicologiche: i pazienti con livelli di istruzione maggiori, un’occupazione stimolante dal punto di vista cognitivo e la residenza in un ambiente urbano, ottengono infatti punteggi più elevati ai test neuropsicologici. In particolare, l’effetto negativo dato dall’aumento delle dimensioni del tumore sulle prestazioni dei pazienti è meno grave per i pazienti con riserva cognitiva più elevata.
“La riserva cognitiva è stata utilizzata per spiegare le differenze individuali nell’invecchiamento normale e patologico. Il nostro studio dimostra anche che la plasticità indicizzata dalla riserva cognitiva permette agli individui di far fronte ad un danno delle funzioni cerebrali in situazioni anche estreme come può essere un tumore cerebrale. Sono necessarie ulteriori ricerche per identificare i meccanismi neurali alla base della plasticità cerebrale”, commenta la professoressa Raffaella Rumiati della SISSA.
“Il nostro studio, contribuendo a spiegare il ruolo della riserva cognitiva in risposta ai tumori cerebrali e quello delle note variabili neurologiche, può aiutare a sviluppare strategie di prevenzione e di interventi riabilitativi personalizzati”, commenta la dottoressa Tomasino.
Testo dagli Uffici Stampa IRCCS Medea e SISSA