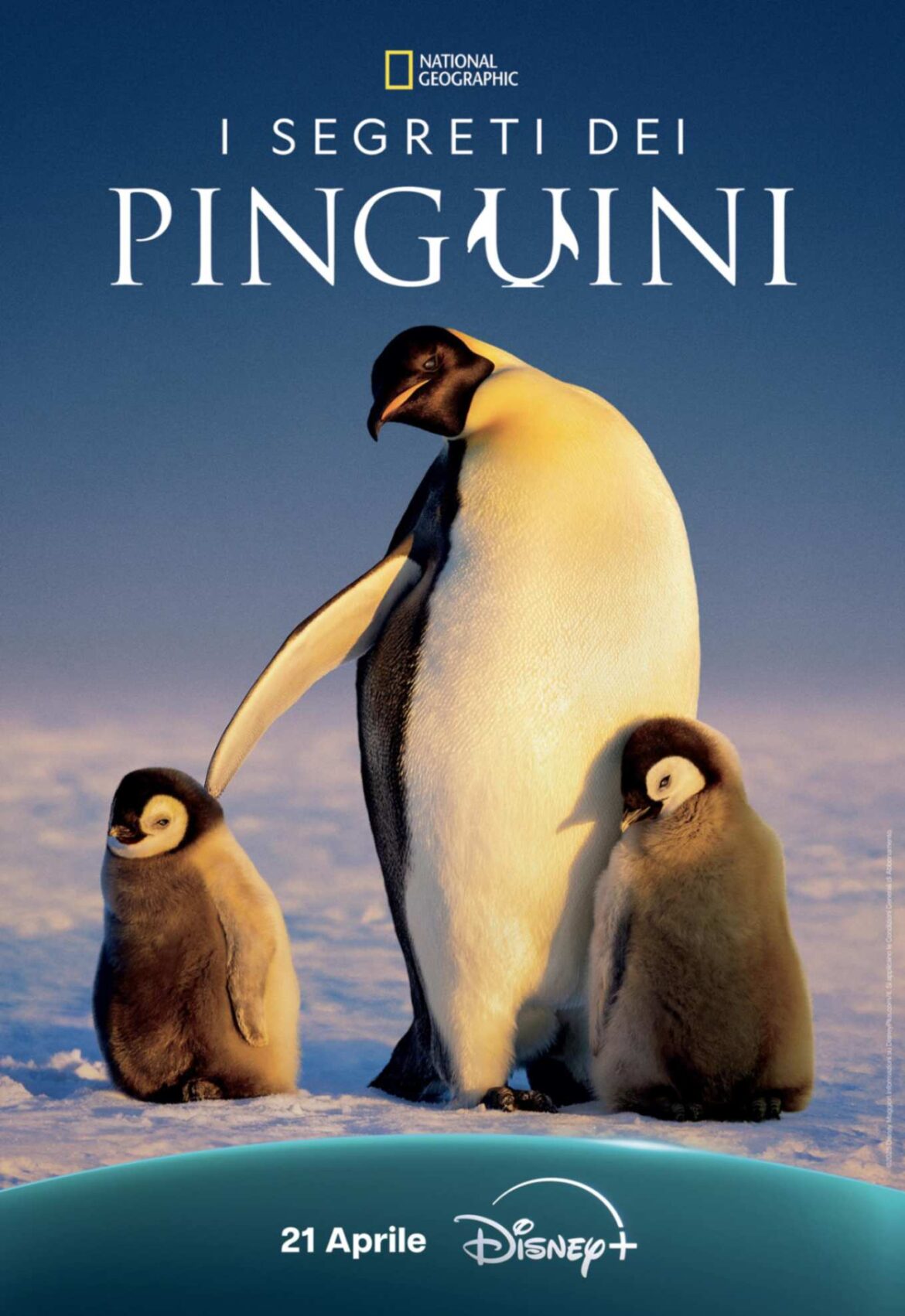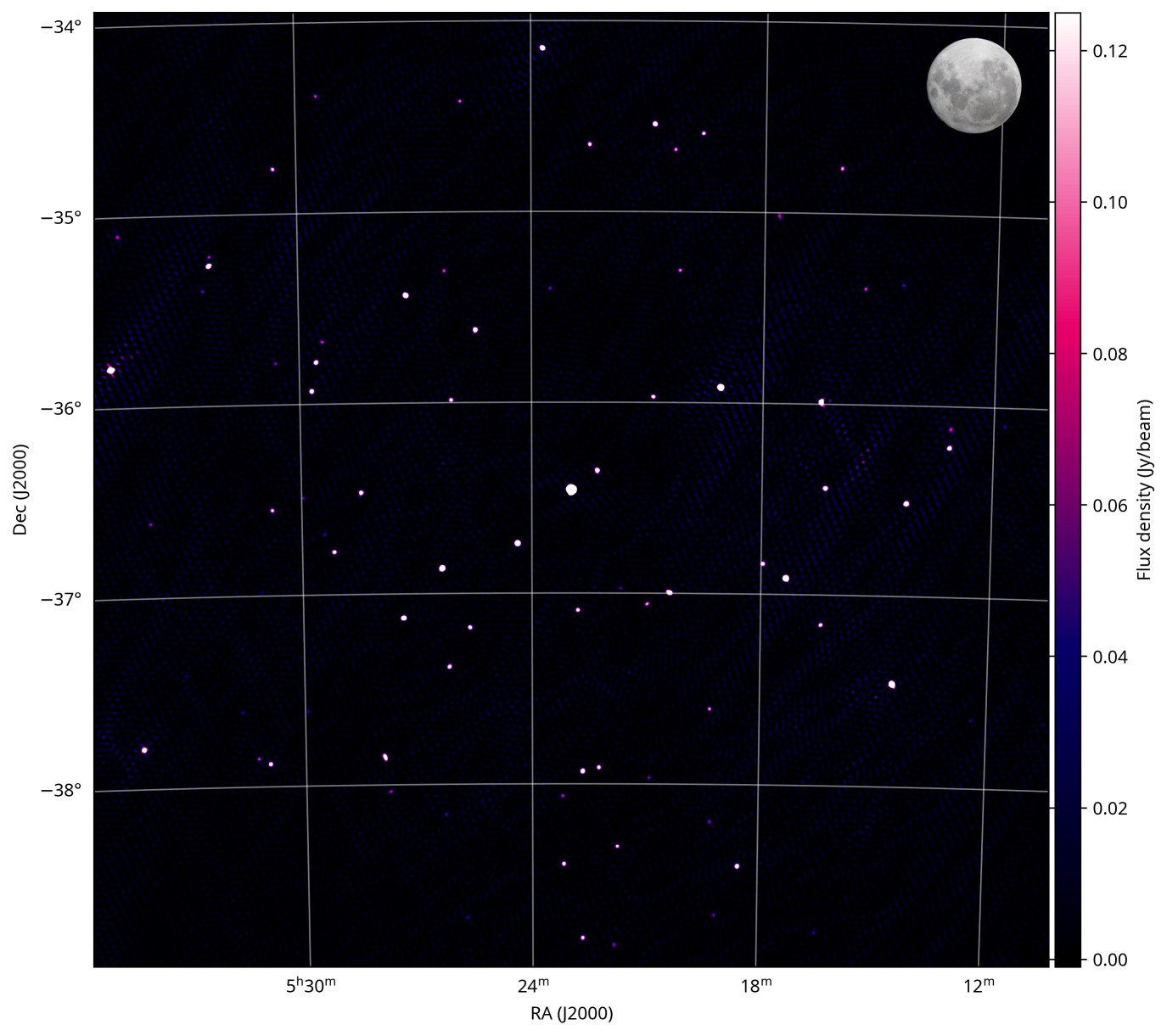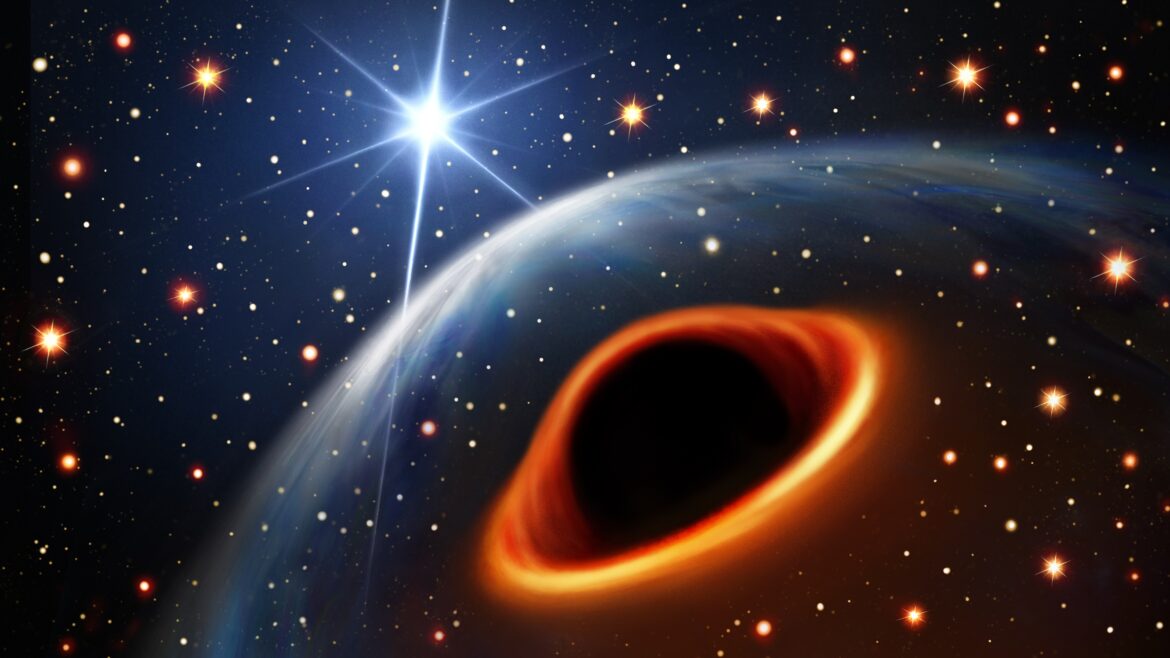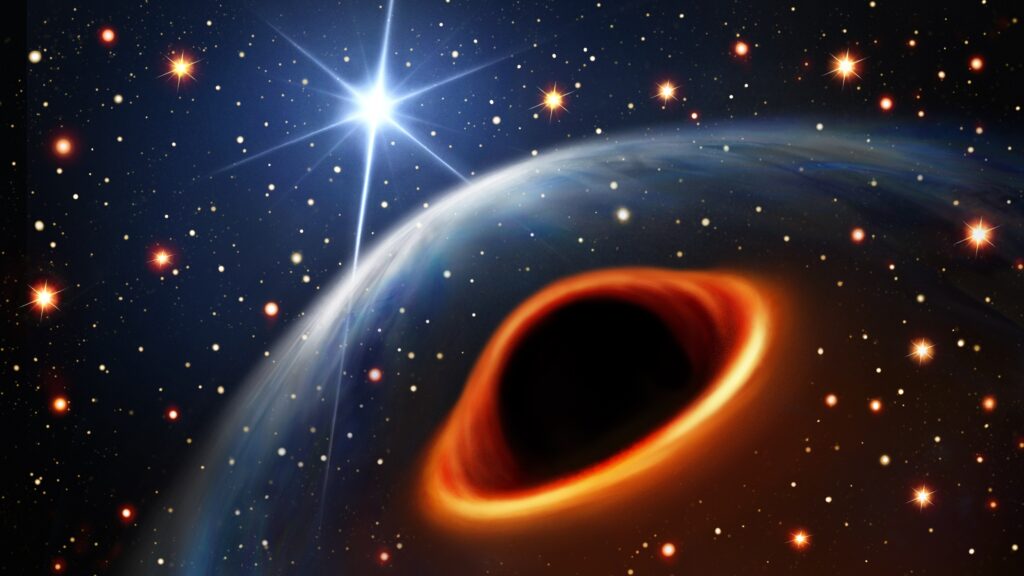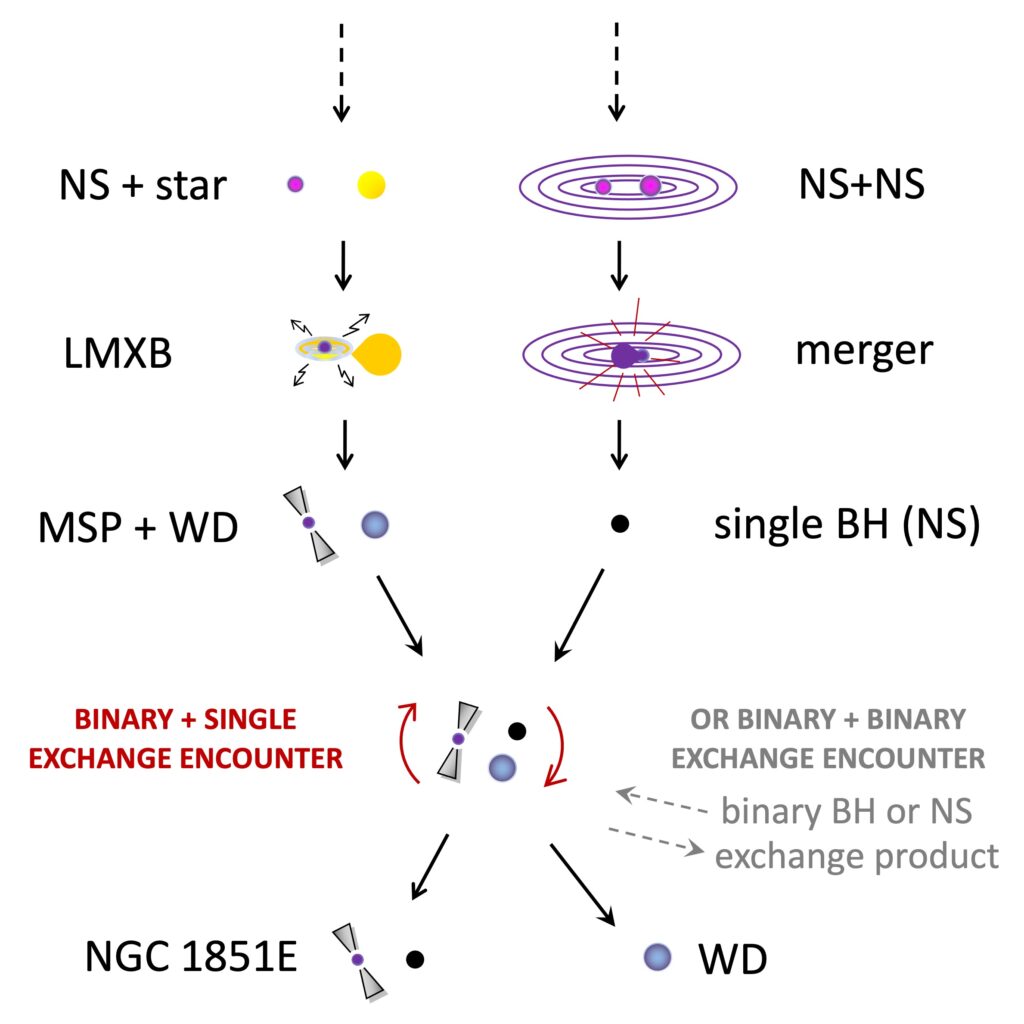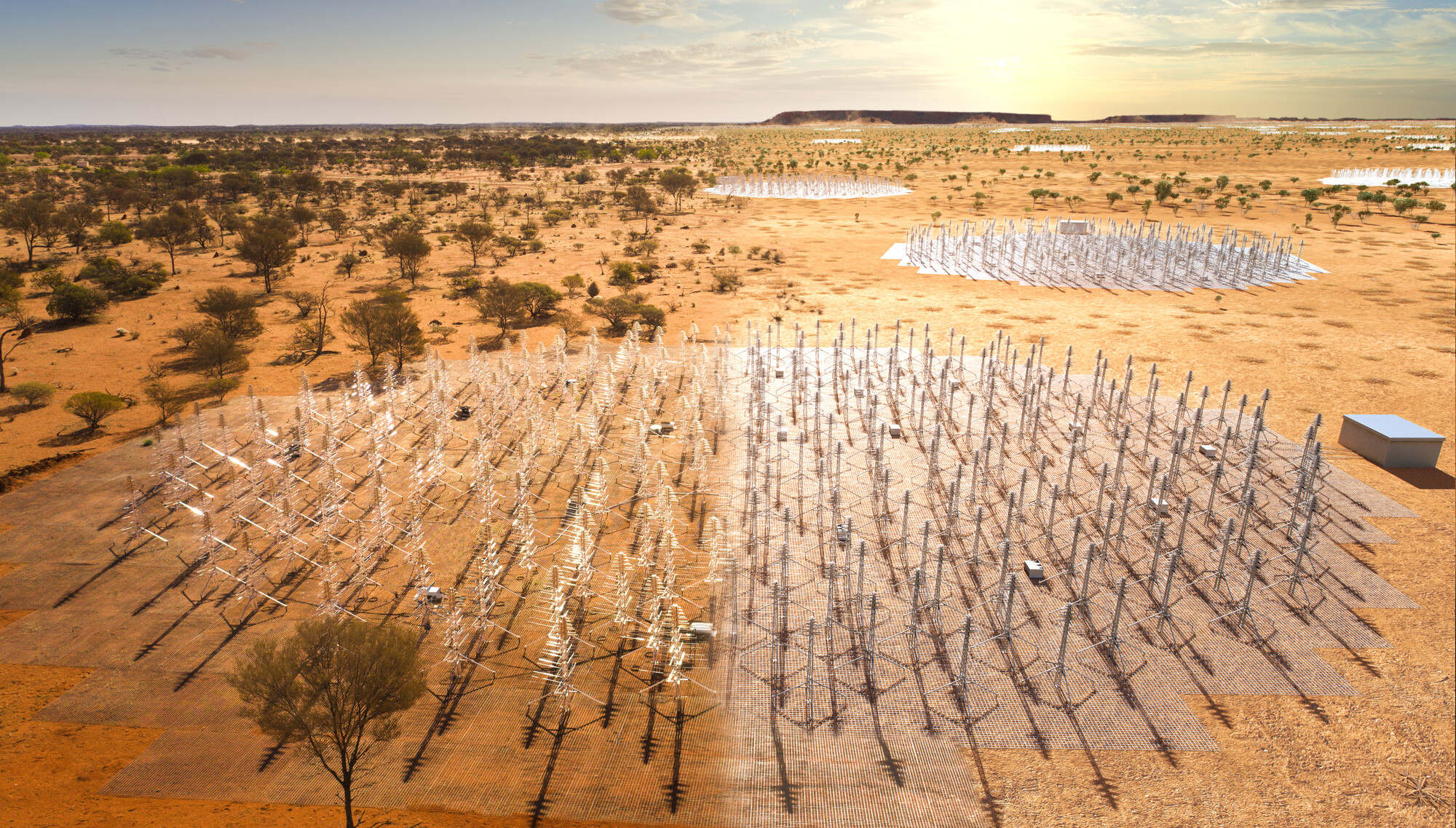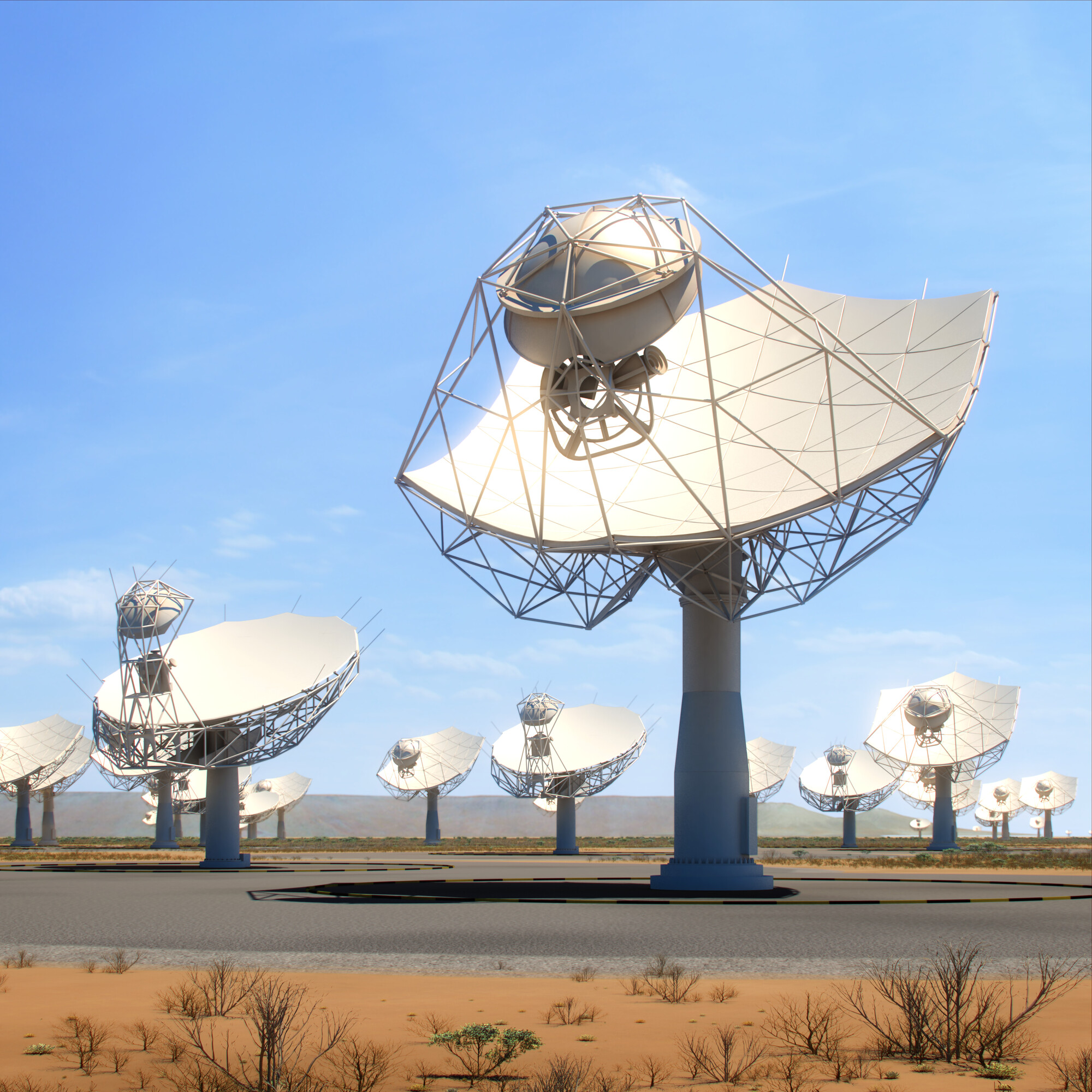I SEGRETI DEI PINGUINI, LA NUOVA SERIE NATIONAL GEOGRAPHIC CHE SVELA COMPORTAMENTI INEDITI CON UNA FOTOGRAFIA MOZZAFIATO DEBUTTERÀ IL 21 APRILE SU DISNEY+
Guidata da Bertie Gregory, National Geographic Explorer e regista vincitore di premi Emmy e BAFTA, la serie si immerge nel mondo incontaminato dei pinguini, mostrando momenti unici, coraggiosi e affascinanti
Narrata nella versione originale da Blake Lively (Un altro piccolo favore), la serie in tre parti vede come produttore esecutivo James Cameron, National Geographic Explorer at Large e vincitore del premio Oscar, ed è prodotta dalla pluripremiata Talesmith
I segreti dei pinguini fa parte della campagna di Disney e National Geographic per il Mese della Terra, per ispirare il pubblico ad apprezzare il mondo naturale usando il potere dello storytelling

15 aprile 2025 – In occasione della Giornata della Terra, sarà possibile immergersi in un’indimenticabile avventura con I segreti dei pinguini assieme a Bertie Gregory (@BertieGregory), National Geographic Explorer e vincitore di premi Emmy® e BAFTA. Gli executive producer sono James Cameron, National Geographic Explorer at Large e regista vincitore dell’Academy Award®, e i vincitori di Emmy e BAFTA Ruth Roberts e Martin Williams di Talesmith. Questo ultimo capitolo del franchise “I segreti di”, targato National Geographic e vincitore di un Emmy, accompagna gli spettatori di tutte le età negli angoli più remoti del mondo per assistere ai comportamenti dei pinguini catturati su pellicola per la prima volta, mostrando questi simpatici e soffici uccelli che non possono volare, mentre affrontano alcuni degli ambienti più estremi della Terra. Narrata nella versione originale da Blake Lively (Un altro piccolo favore), la serie debutterà il 21 aprile 2025 su Disney+ con tutti e 3 gli episodi.
Quest’anno, The Walt Disney Company celebra il Mese della Terra con una campagna aziendale insieme a National Geographic per ispirare il pubblico ad apprezzare il mondo che ci circonda attraverso il potere dello storytelling. Per tutto il mese di aprile, la campagna ourHOME offrirà nuovi contenuti, attività digitali ed esperienze, e metterà in luce gli sforzi globali per proteggere, ripristinare e celebrare il mondo naturale, permettendo agli spettatori e ai fan di scoprire tanti altri motivi per amare questo luogo chiamato casa.
Nonostante molti documentari abbiano studiato questi animali, I segreti dei pinguini li porta a un livello completamente nuovo. Il team di Talesmith, guidato da Bertie Gregory e da oltre 70 scienziati e filmmaker di fama mondiale, si è imbarcato in un’avventura di due anni per tutto il mondo, dalle spiagge rocciose di Città del Capo e le coste ghiacciate dell’Isola della Georgia del Sud, fino alle Galapagos tropicali e alle grotte desertiche della Namibia, per osservare i pinguini come mai era stato fatto prima. Spingendosi oltre i confini del cinema naturalistico, una troupe di tre persone ha affrontato ben 274 giorni di riprese sulla piattaforma di ghiaccio Ekström, in Antartide, dove vive una colonia di 20.000 pinguini imperatori. Affrontando uno degli ambienti più difficili del pianeta, hanno catturato momenti inediti, come una coppia di pinguini imperatori che si esercita con una palla di neve a trasferire le uova per affinare le proprie capacità in vista del momento in cui dovranno farlo con un uovo vero; pulcini tenaci che navigano tra ghiaccio frammentato in un contesto di cambiamento climatico e giovani pinguini che usano il becco per sollevarsi da un crepaccio.
Con una fotografia mozzafiato e una tecnologia di ripresa all’avanguardia, la serie cattura momenti rari e mai visti prima in natura. Per la prima volta, si potranno osservare pulcini di “rockaroni”, un raro ibrido di pinguini saltarocce (rockhopper) e ciuffodorato (macaroni), con uno sguardo approfondito alla potenziale evoluzione e all’adattamento. Tra le altre scene, un coraggioso pinguino saltarocce che respinge un leone marino meridionale, le prime riprese di una colonia di pinguini africani in una grotta nascosta e gli intelligenti pinguini delle Galapagos che si alleano per un audace furto: rubare il pesce direttamente dal becco dei pellicani e radunare abilmente le palline di sardine come esca.
Nell’aprile del 2024, National Geographic ha presentato per la serie un filmato mozzafiato sui pinguini imperatori, catturato da Bertie Gregory sulla piattaforma di ghiaccio Ekström in Antartide. Per la prima volta, l’equipaggio ha registrato uno spettacolo sorprendente: centinaia di pulcini di pinguino imperatore che saltano da una scogliera di 15 metri nell’oceano ghiacciato sottostante, uscendone indenni. La serie mostrerà l’intero spettacolo di questo comportamento straordinario, insieme a nuove riprese che inizialmente non erano state incluse nel video virale. A oggi, il filmato ha ottenuto 74 milioni di visualizzazioni sull’account TikTok di National Geographic – il suo video più performante di sempre – e ha ricevuto oltre 165 milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme social di National Geographic. Le riprese di storia naturale di Gregory hanno avuto una tale risonanza tra gli spettatori da far sì che egli abbia registrato alcuni dei video più visti nell’ultimo anno sull’account Instagram di National Geographic. Il video dei pinguini imperatori conta circa 63 milioni di visualizzazioni, mentre il secondo più visto è quello sulle api del Parco Nazionale Dzanga-Sangha con 34 milioni di visualizzazioni, seguito da quello sulle orche antartiche B1 con 23 milioni di visualizzazioni, entrambi tratti dalla sua serie originale Disney+ di National Geographic Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali, attualmente in fase di riprese della seconda stagione.
La serie, adatta alle famiglie, si avvale della passione e dell’esperienza di scienziati e ambientalisti di fama mondiale, tra cui il National Geographic Explorer e biologo marino Pablo Borboroglu, la biologa ambientalista Michelle LaRue, l’esperta di pinguini africani Andrea Thiebault, il dottore in medicina veterinaria Gustavo Jiménez Uzcátegui, l’esperta di pinguini Jessica Kemper e la biologa marina Katta Ludynia.
EPISODI
- “Il cuore dell’imperatore”
Gli imperatori sono i pinguini più grandi e forti, e vivono nell’ambiente più freddo ed estremo della Terra. Il National Geographic Explorer Bertie Gregory, inserito in una colonia antartica, si imbatte in capacità relazionali mai riprese prima, scoprendo che i legami forgiati fin dalla nascita tra famiglia, amici ed estranei fanno la differenza tra la vita e la morte. - “La sopravvivenza del più intelligente”
Milioni di anni fa, un gruppo di pinguini ha lasciato i ghiacci, seguendo forti correnti e arrivando in nuove e strane terre. Qui hanno rimodellato le loro tradizioni per i deserti e i tropici e persino per vivere tra gli esseri umani. Messi alla prova fino all’estremo, sono diventati forse i più intelligenti tra tutti i pinguini. Il National Geographic Explorer Bertie Gregory scopre la loro capacità di risolvere i problemi, di “parlare” e di andare alla ricerca di nuovi mondi. - “Ribelli per una causa”
Ci vuole un tipo speciale di pinguino coraggioso per sopravvivere al feroce Oceano Antartico, ma 40 milioni di esemplari affollano i suoi avamposti isolati e rocciosi, e sono tra i pinguini più impavidi sulla Terra. Il National Geographic Explorer Bertie Gregory segue i saltarocce, i gentoo e i ciuffodorato alla scoperta di un mondo fatto di amanti del rischio, ribelli e genitori non convenzionali.
I precedenti capitoli di “I segreti di” comprendono I segreti del polpo, narrata nella versione originale da Paul Rudd; I segreti degli elefanti, narrata nella versione originale da Natalie Portman; e I segreti delle balene, vincitrice di un Emmy, narrata nella versione originale da Sigourney Weaver. Tutti gli episodi sono attualmente disponibili in streaming su Disney+.
I segreti dei pinguini è prodotto da Talesmith per National Geographic. Gli executive producer sono i vincitori del premio Emmy James Cameron e Maria Wilhelm per Lightstorm Earth. Bertie Gregory, vincitore di un BAFTA e di un Emmy Award, è narratore principale, direttore della fotografia e produttore. Per Talesmith, gli executive producer sono i vincitori di Emmy e BAFTA Ruth Roberts e Martin Williams. Il produttore della serie è Serena Davies. Pam Caragol è executive producer per National Geographic.
Hashtag
#DisneyPlus
Testo, video e immagini dagli Uffici Stampa The Walt Disney Company Italia, Opinion Leader, Cristiana Caimmi.