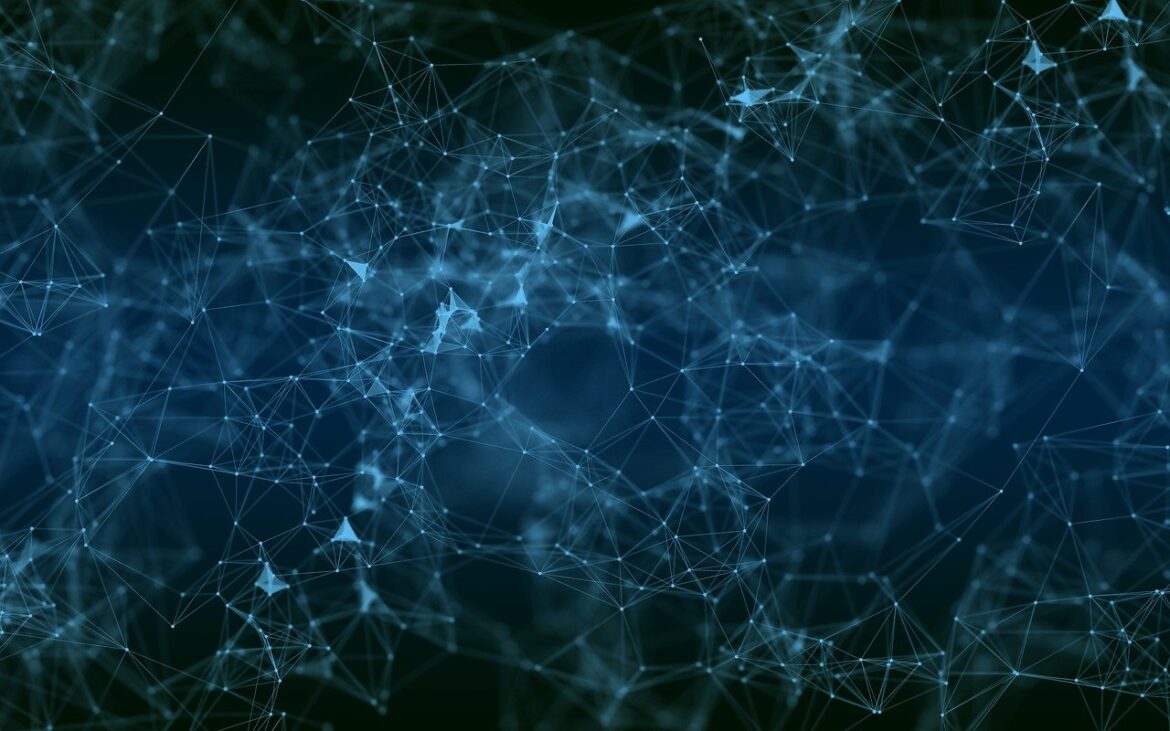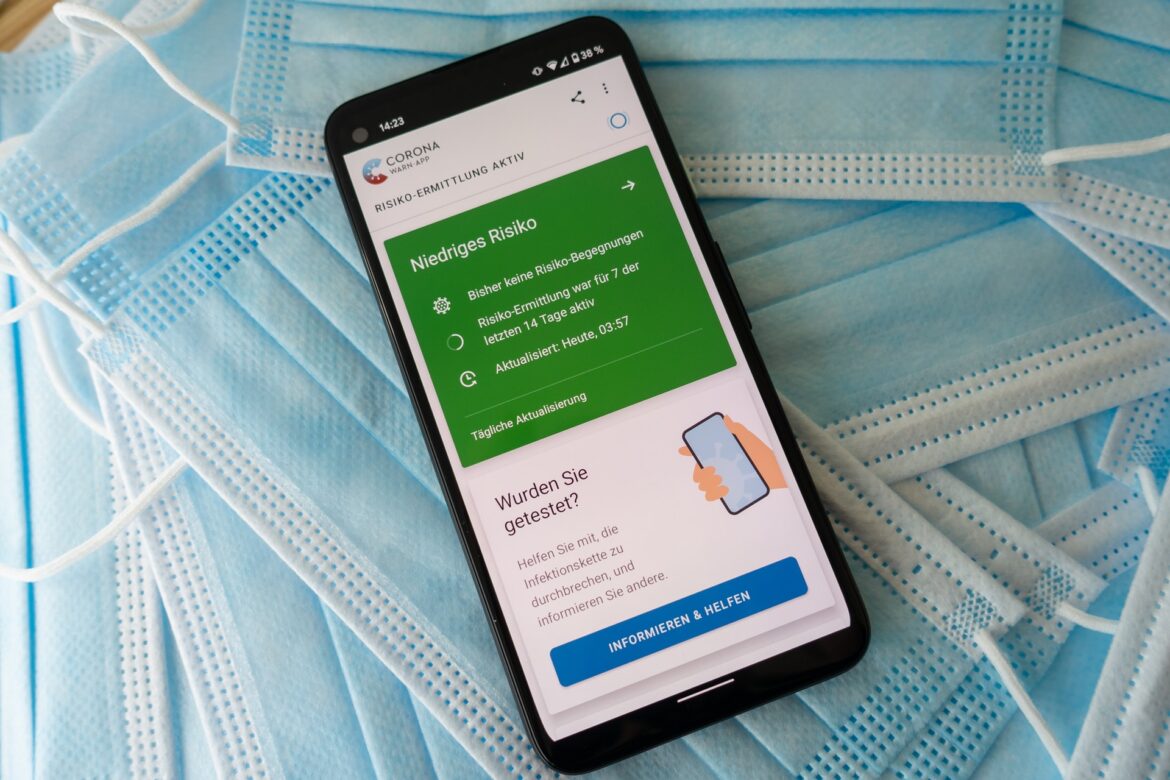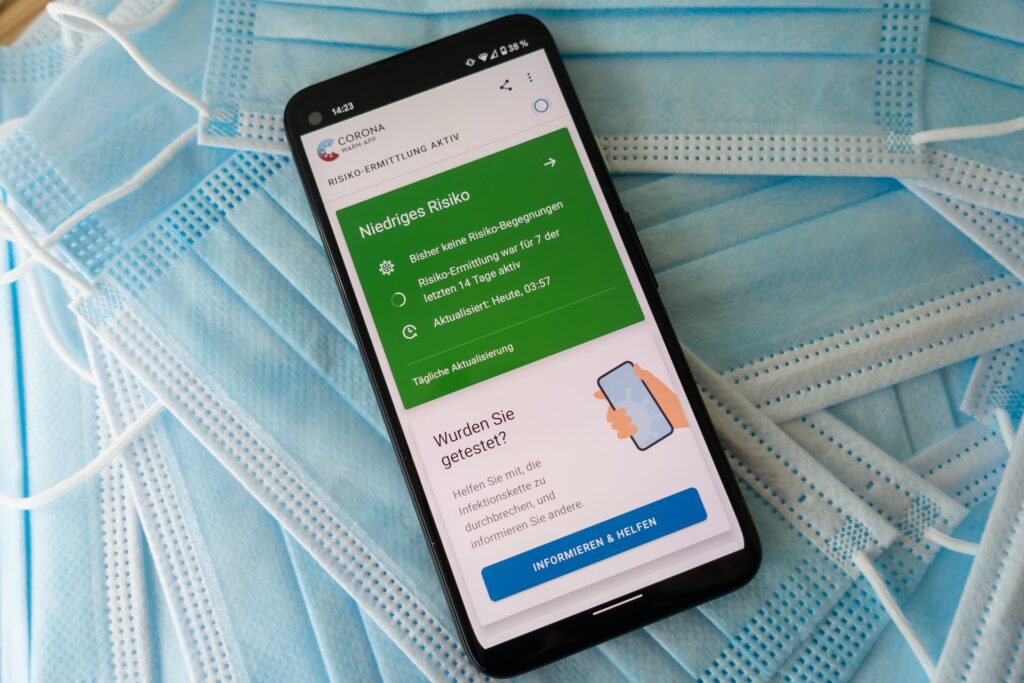Un cloud quantistico sicuro: da oggi è possibile proteggere la privacy di gruppi di utenti che effettuano calcoli contemporaneamente su server distanti
Un gruppo di ricerca internazionale ha ideato e dimostrato che è possibile effettuare calcoli da remoto su processori quantistici mantenendo intatta la privacy di tutti gli utenti coinvolti. I risultati dell’esperimento, condotto presso il Quantum Lab dell’Università Sapienza di Roma, sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications e costituiscono un passo in avanti fondamentale verso la realizzazione di reti quantistiche sicure.
Un numero crescente di aziende e laboratori in tutto il mondo sta mettendo a disposizione degli utenti diverse tipologie di prototipi di processori quantistici. Infatti, con le tecnologie attuali, i costi di acquisto e manutenzione di questi dispositivi sono inaccessibili per utenti comuni. Invece, tramite un approccio di cloud computing, chiunque può “mettersi in fila” per prenotare l’utilizzo di un piccolo processore e poter fare il proprio esperimento di calcolo quantistico. Il problema di mantenere la privacy di questi utenti costituisce di conseguenza un’importante sfida da affrontare.
Nonostante fosse già noto come mantenere la privacy di un singolo utente connesso a un server remoto, rimaneva comunque aperto il problema di proteggere la privacy di un gruppo di utenti che collaborino allo stesso calcolo. Questo potrebbe essere il caso, ad esempio, di un gruppo di banche che puntano ad elaborare in modo congiunto i dati dei propri clienti per sviluppare un modello finanziario comune, ma senza che né le altre banche partecipanti, né i gestori del processore remoto possano carpire alcuna informazione sui dati dei loro clienti.
In un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, è stato dimostrato un protocollo di crittografia adattabile a piattaforme di crescente complessità e grandezza, che permette a più utenti di portare avanti un calcolo in comune mantenendo intatta la sicurezza dei loro dati e proteggendo tutti i dettagli del calcolo.
Questo è stato il risultato di una collaborazione scientifica nel campo di protocolli di computazione e crittografia quantistica tra la Sapienza Università di Roma, l’università La Sorbona di Parigi, il Centro Nazionale della Ricerca Scientifica (CNRS) francese e l’impresa VeriQloud.
Le piattaforme basate su stati di luce quantistica sono tra le principali candidate per la realizzazione di reti quantistiche densamente interconnesse, che possano mettere in comunicazione più utenti, sia tra di loro che con server dotati di potenza di calcolo. Infatti, le sue proprietà fisiche la rendono un sistema molto promettente per la trasmissione di informazioni su lunga distanza, come hanno dimostrato alcuni esperimenti di comunicazione quantistica tra stazioni terrestri e satelliti in orbita.
L’esperimento guidato da Fabio Sciarrino e condotto presso il Quantum Lab del Dipartimento di Fisica della Sapienza ha dimostrato, per la prima volta, un protocollo in cui due utenti elaborano un calcolo quantistico su un server distante, pur assicurando la totale sicurezza dei dati relativi al calcolo. La piattaforma sperimentale sfrutta fibre ottiche per collegare i clienti tra loro e con il server, dimostrando la sicurezza e l’efficacia del protocollo anche nel caso in cui i partecipanti al protocollo si trovino a distanza.
Il protocollo e la sua sicurezza sono stati ideati e dimostrati da gruppi di ricerca diretti da Elham Kashefi e Marc Kaplan ed affiliati rispettivamente all’Università La Sorbona di Parigi e all’azienda VeriQloud.
“Il nostro lavoro – commenta Beatrice Polacchi, dottoranda del team Quantum Lab – è la prima dimostrazione sperimentale di un protocollo sicuro di delegazione di calcolo quantistico che coinvolge più di un cliente, e costituisce pertanto un mattoncino per la costruzione di reti quantistiche più grandi e sicure.”
Un altro importante risultato di questa collaborazione è la possibilità di continuare su questa strada per dimostrare protocolli di computazione sempre più sicuri e investigare reti quantistiche di crescente dimensione e connettività.
“I nostri risultati – conclude Fabio Sciarrino, responsabile del Quantum Lab – motivano la ricerca volta ad identificare nuovi protocolli sicuri calcolo quantistico delegato e nuove architetture modulari per le reti quantistiche. Ci aspettiamo che questo lavoro fornirà uno stimolo significativo alla ricerca sulla futura realizzazione di un cloud quantistico”.
Questa linea di ricerca è supportata dal programma europeo per la ricerca e l’innovazione “European Union’s Horizon 2020” attraverso il progetto FET “PHOQUSING”: www.phoqusing.eu.
Riferimenti bibliografici:
Multi-client distributed blind quantum computation with the Qline architecture – Beatrice Polacchi, Dominik Leichtle, Leonardo Limongi, Gonzalo Carvacho, Giorgio Milani, Nicolò Spagnolo, Marc Kaplan, Fabio Sciarrino & Elham Kashefi – Nature Communications 14, 7743 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-43617-0
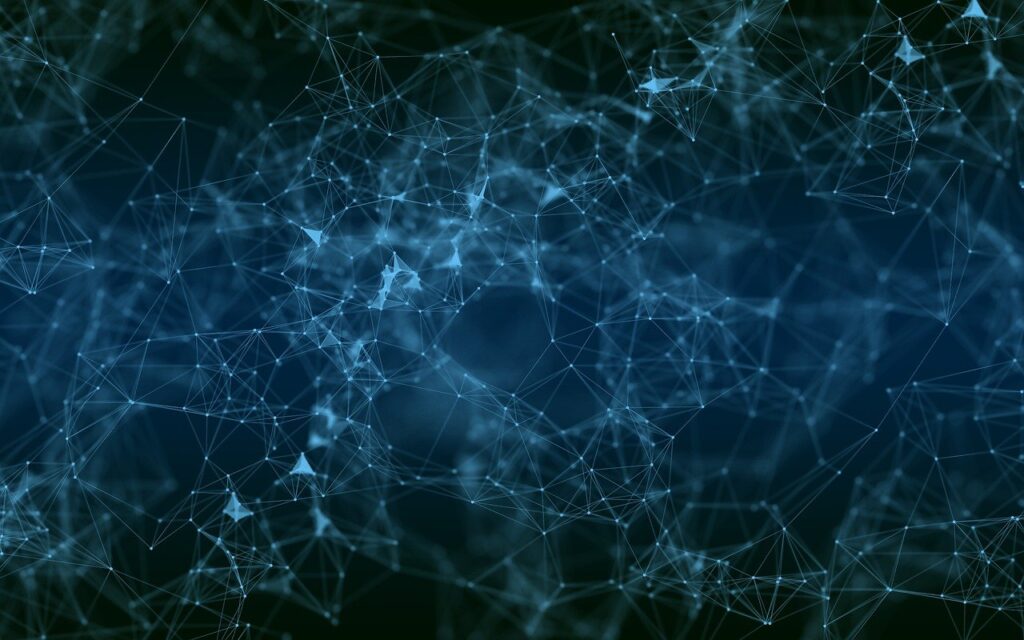
Testo dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma