SIAMO “CIÒ CHE MANGIAMO” MA NON SIAMO “DOVE VIVIAMO”
Uno studio di ricercatori dell’Università di Torino, Trieste e Padova – pubblicato su PNAS – ha esaminato le preferenze alimentari di sei popolazioni lungo l’antica Via della seta e ha scoperto come le nostre scelte, più che dal luogo dove siamo nati o abitiamo, dipendono maggiormente dal sesso biologico, dall’età e da altri fattori culturali.
Gli studi genetici degli ultimi 20 anni hanno ampiamente dimostrato che, tra le popolazioni di tutto il mondo, la maggior parte delle differenze genetiche si riscontrano a livello individuale piuttosto che a livello di popolazione. Due individui presi a caso nella stessa popolazione tendono infatti a essere geneticamente più diversi l’uno dall’altro rispetto alla differenza media fra due popolazioni distinte. Si può dire la stessa cosa anche se si parla di stile di vita e cultura?
In un recente articolo pubblicato sulla rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) da ricercatori delle Università di Torino, Trieste e Padova, gli autori hanno indagato la questione utilizzando le abitudini alimentari come una possibile fonte di differenze culturali fra individui. In particolare, hanno esaminato le preferenze alimentari relative a 79 diversi alimenti in sei popolazioni lungo la Via della seta, l’antica rotta commerciale che si estende attraverso tutta l’Asia centrale.
“Abbiamo scoperto che la preferenza per alcuni cibi era informativa della preferenza per altri cibi, o che, in altre parole, le preferenze alimentari possono essere descritte combinando un numero discreto di ‘profili alimentari’”, ha affermato il Prof. Luca Pagani, autore senior dello studio, professore associato in Antropologia Molecolare presso l’Università di Padova.

Inaspettatamente, i profili così individuati non sono tipici di un determinato villaggio o nazione, ma sono invece legati ad altre caratteristiche degli individui partecipanti come la loro età, il sesso e altre scelte culturali. Questo naturalmente con qualche eccezione, rappresentata da alcuni alimenti disponibili solo in determinati Paesi: tra questi spiccano alcuni prodotti locali, come il “sulguni”, un formaggio in salamoia tipico della Georgia ed il “kurut”, un alimento diffuso tra le popolazioni nomadi dell’Asia centrale a base di yogurt essiccato.
I ricercatori hanno verificato che solo il 20% delle abitudini alimentari sono legate al Paese di origine, un valore piuttosto alto se confrontato con la sua controparte genetica (1%) ma ancora non sufficiente a spiegare le differenze osservate, nonostante le migliaia di chilometri che separano le aree geografiche oggetto di studio.

I ricercatori hanno poi condensato le differenze nella composizione genetica e nelle preferenze alimentari tra i Paesi in distanze “genetiche” e “alimentari”, e le hanno confrontate con le distanze geografiche reali tra i luoghi di campionamento, rappresentandole insieme in una mappa. Da essa emerge che la “localizzazione culturale” è leggermente più simile a quella geografica, rispetto a quella “genetica” per i gruppi analizzati (Figura 1), coerentemente con quanto emerso dal resto dei risultati.
“Non importa dove viviamo o dove siamo nati. Le nostre scelte (almeno quelle legate all’alimentazione) dipendono maggiormente dal sesso biologico, dall’età e da altri fattori culturali”, ha concluso la dott.ssa Serena Aneli, prima autrice dello studio, ricercatrice del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino.
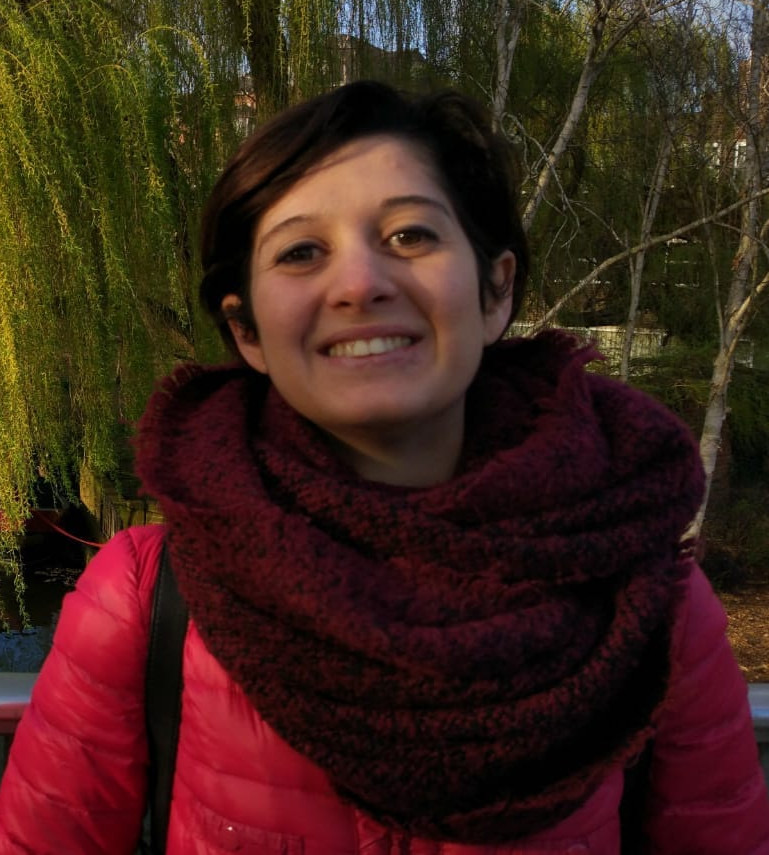
Informazioni
Titolo dell’articolo: “The impact of cultural and genetic structure on food choices along the Silk Road”
Autori: Serena Aneli, Massimo Mezzavilla, Eugenio Bortolini, Nicola Pirastu, Giorgia Girotto, Beatrice Spedicati, Paola Berchialla, Paolo Gasparini, Luca Pagani
LINK: https://www.pnas.org/cgi/doi/
Testo e immagini dall’Area Relazioni Esterne e con i Media dell’Università degli Studi di Torino





