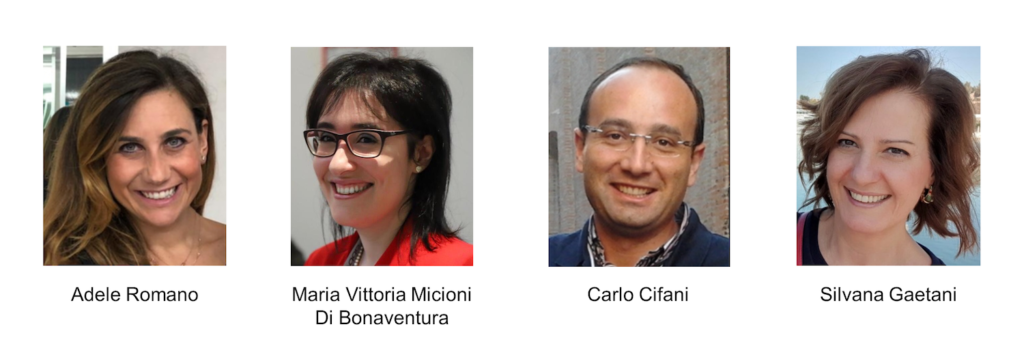MECCANISMI NEUROBIOLOGICI DELL’LSD
Il possibile utilizzo di sostanze psichedeliche usate a fini terapeutici in micro-dosi, ossia minime quantità che non inducono allucinazioni, sta ritornando al centro del dibattito scientifico nella letteratura internazionale.
Lo studio pubblicato sulla rivista «Neuropsychopharmacology» con il titolo “Repeated lysergic acid diethylamide (LSD) reverses stress-induced anxiety-like behavior, cortical synaptogenesis deficits and serotonergic neurotransmission decline” – coordinato da Gabriella Gobbi del Dipartimento di Psichiatria della McGill University di Montreal, a cui ha partecipato Stefano Comai del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Padova e che ha come primo autore Danilo De Gregorio dell’Università Vita Salute San Raffaele di Milano – rivela i meccanismi neurobiologici, precedentemente inspiegati, attraverso i quali l’LSD (dietilamide dell’acido lisergico) potrebbe alleviare i disturbi d’ansia.
È risaputo che le condizioni di stress cronico siano un fattore di rischio importante per lo sviluppo di patologie quali ansia e depressione. Il team di ricerca internazionale ha determinato gli effetti di una somministrazione di basse dosi di LSD, per un periodo di sette giorni, su un gruppo di animali soggetti a condizioni di stress cronico. Due i principali risultati: da un lato le micro-dosi ripetute di LSD porterebbero a una riduzione dei comportamenti ansiosi causati dallo stress, dall’altro la riduzione dei sintomi dell’ansia segue percorsi neurobiologici simili agli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, cioè quelli di alcune classi di antidepressivi e ansiolitici comunemente prescritti nella pratica clinica.
Meccanismi neurobiologici e LSD
La serotonina è un neurotrasmettitore che svolge un ruolo essenziale nello stato di benessere e l’uso di LSD aumenta la neurotrasmissione serotoninergica. Lo studio pubblicato dimostra che periodi prolungati di stress provocano una diminuzione dell’attività dei neuroni della serotonina. Con meccanismo analogo agli antidepressivi SSRI comunemente in commercio (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina), i ricercatori hanno scoperto che l’LSD desensibilizza i recettori della serotonina che regolano l’attività stessa dei neuroni serotoninergici. Il risultato finale di questa desensibilizzazione in seguito a trattamento prolungato con LSD a basse dosi è che questi neuroni serotoninergici rilasciano più serotonina.
Inoltre si è scoperto che LSD promuove la formazione di nuove spine dendritiche, ossia i “rami” dei neuroni che sono responsabili della trasmissione del segnale elettrico al corpo delle cellule nervose: il trattamento con LSD porta a una ricostruzione di quei rami che erano stati “smantellati” a causa dello stress.
La ricerca pubblicata si ricollega a uno studio condotto nel 2016 dallo stesso team in cui si dimostrava che basse dosi di LSD influenzavano solo la trasmissione serotoninergica, mentre dosi più elevate condizionavano l’attività della dopamina, un altro neurotrasmettitore, causando gli effetti psicotici.
Uso dell’LSD e contesti clinici molto rigorosi
Nell’assistenza e nella cura delle malattie psichiatriche è essenziale sviluppare nuove alternative terapeutiche in quanto le attuali purtroppo funzionano in modo ottimale solo in una percentuale dei pazienti: LSD, psilocibina, ayahuasca e MDMA sono tra i farmaci in fase di sviluppo per il trattamento di vari disturbi psichiatrici come ansia, depressione, disturbo da stress post-traumatico e dipendenza, nonché alcune malattie neurodegenerative. In alcuni paesi come il Canada è stato recentemente autorizzato l’uso di droghe psichedeliche in un contesto clinico molto rigoroso perché le sostanze psichedeliche possono causare psicosi ed effetti neurotossici.

«L’utilizzo di queste sostanze deve essere fatto in un contesto rigidamente regolamentato, per evitare il rischio di incorrere in importanti effetti collaterali, potenzialmente molto dannosi per la salute dell’individuo. Non esiste cioè un fai-da-te della cura attraverso sostanze psicotrope o droghe illegali – dice Stefano Comai del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Padova –. Dobbiamo ricordare i possibili rischi psicologici quali suscettibilità a episodi psicotici o maniacali, traumi associati a esperienze difficili e reazioni di rimbalzo di depressione o ansia. Inoltre, vanno sottolineate due cose: la dose è un fattore fondamentale e che la purezza di queste sostanze comprate attraverso i canali di spaccio è molto variabile».
Non meno importante è infine il fatto che non si conosca ancora nel dettaglio né quali siano gli effetti di queste sostanze quando sono somministrate ripetutamente o per lunghi periodi di tempo, né come queste sostanze agiscano a livello cerebrale.
«Il nostro lavoro ci ha permesso di compiere un passo avanti in questa direzione, ma ulteriori studi sono ancora necessari sia a livello preclinico sia a livello clinico. Negli ultimi quattro anni sono decine i trial clinici che sono iniziati per valutare l’efficacia degli psichedelici, principalmente psilocibina e MDMA, ma anche LSD, per il trattamento di diversi disturbi psichiatrici. Allo stesso modo, sono centinaia gli studi a livello preclinico. La speranza – conclude Stefano Comai – è di capire se e come poter utilizzare queste sostanze da un punto di vista terapeutico, riducendo il rischio di eventi avversi e dannosi. Queste ricerche, in ogni caso, potrebbero comunque aiutarci a meglio capire i meccanismi, ad oggi ancora per molti aspetti ignoti, alla base di disturbi quali depressione e ansia. La loro comprensione è di fondamentale importanza per poter studiare e sviluppare nuovi farmaci che possano avere da un lato la stessa efficacia terapeutica degli psichedelici e, dall’altro, un profilo di sicurezza migliore».
Link alla ricerca: https://www.nature.com/articles/s41386-022-01301-9
Titolo: “Repeated lysergic acid diethylamide (LSD) reverses stress-induced anxiety-like behavior, cortical synaptogenesis deficits and serotonergic neurotransmission decline” – «Neuropsychopharmacology» (2022)
Autori: Danilo De Gregorio, Antonio Inserra, Justine P. Enns, Athanasios Markopoulos, Michael Pileggi, Youssef El Rahimy, Martha Lopez-Canul, Stefano Comai & Gabriella Gobbi
Testo e foto dall’Ufficio Stampa Università degli Studi di Padova