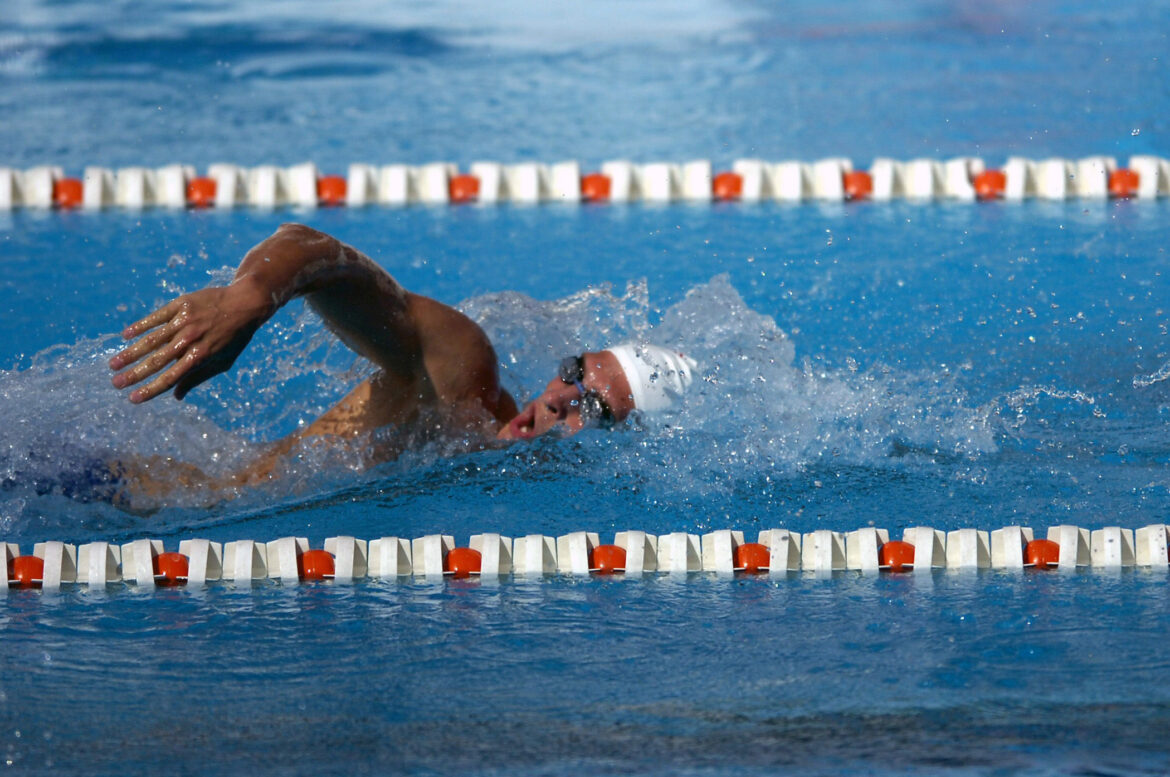Un orologio interno che spacca il secondo lo si può ottenere grazie al nuoto e alla corsa
Uno studio pubblicato sulla rivista Psychology of Sport & Exercise, frutto di una collaborazione tra Università di Milano-Bicocca e Università di Pavia, dimostra come il cervello dei nuotatori (ma anche di chi pratica la corsa) abbia elevate capacità di percepire e misurare il tempo.
Milano, 19 ottobre 2023 – Bracciata dopo bracciata, vasca dopo vasca, i nuotatori sviluppano un’eccezionale capacità di cronometrare il tempo. Come ci riescono, immersi come sono in un ambiente ovattato come l’acqua? Lo spiega una ricerca intitolata “Temporal perception in closed-skill sports: An experimental study on expert swimmers and runners”, coordinata da Luisa Girelli, insieme a Simona Perrone del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con Daniele Gatti e Luca Rinaldi del Dipartimento di Scienze del sistema nervoso e del comportamento dell’Università di Pavia.
Magari non ce ne accorgiamo, ma il nostro cervello misura continuamente il tempo grazie a una sorta di orologio interno: succede, per esempio, quando pianifichiamo o eseguiamo i movimenti necessari ad attraversare la strada oppure quando siamo alla guida di una macchina. Questa abilità cognitiva ha un ruolo chiave anche in ambito sportivo, non solo perché la prestazione sportiva dipende sempre anche da una perfetta calibrazione temporale dell’azione, ma anche perché in alcuni sport è il fattore tempo a determinare il successo.
È il caso degli sport closed skills: si tratta di discipline – come appunto il nuoto o la corsa – che si svolgono in un contesto stabile e prevedibile, dove la prestazione si basa sulla ripetizione ciclica dello stesso gesto motorio e in cui vince chi fa il miglior tempo.
«In acqua il nuotatore può controllare la performance e cronometrare l’andatura solo basandosi sulla propria percezione interna. Si tratta di un’attività molto diversa rispetto agli sport open skills, dove il contesto è mutevole e imprevedibile», spiega Luisa Girelli. «Pensiamo agli sport di squadra, come il calcio o il basket, dove l’atleta deve di continuo tenere conto delle situazioni esterne e dalle azioni degli altri giocatori in campo per decidere come agire. È sempre stato riconosciuto come queste discipline siano allenanti per funzioni cognitive come l’attenzione, l’abilità decisionale, la pianificazione e l’anticipazione motoria».
Che cosa accade invece a chi pratica a livello intensivo gli sport closed skills?
«La nostra ipotesi di ricerca era che anche questi sport potenziassero determinate competenze cognitive, in particolare, le abilità di percepire e stimare il tempo, facendo ampio conto sul proprio ritmo interno»,
dice Girelli. E le conferme sono arrivate. I partecipanti allo studio – divisi in due gruppi di atleti, nuotatori e corridori, e un gruppo di controllo di non sportivi – sono stati sottoposti a compiti per valutare la loro capacità di stimare durate temporali e tenere il tempo. Gli sportivi sono risultati più abili, in particolare i nuotatori, abituati a sfidare il cronometro in acqua, dove gli stimoli uditivi e visivi sono attenuati e quindi meno rilevanti per mantenere il ritmo e tenere traccia dello scorrere del tempo. Ecco perché, tra una virata e l’altra, il nuotatore controlla al meglio il proprio “orologio” interno, affinandolo sempre di più.

Testo dall’Ufficio Stampa dell’Università di Milano-Bicocca