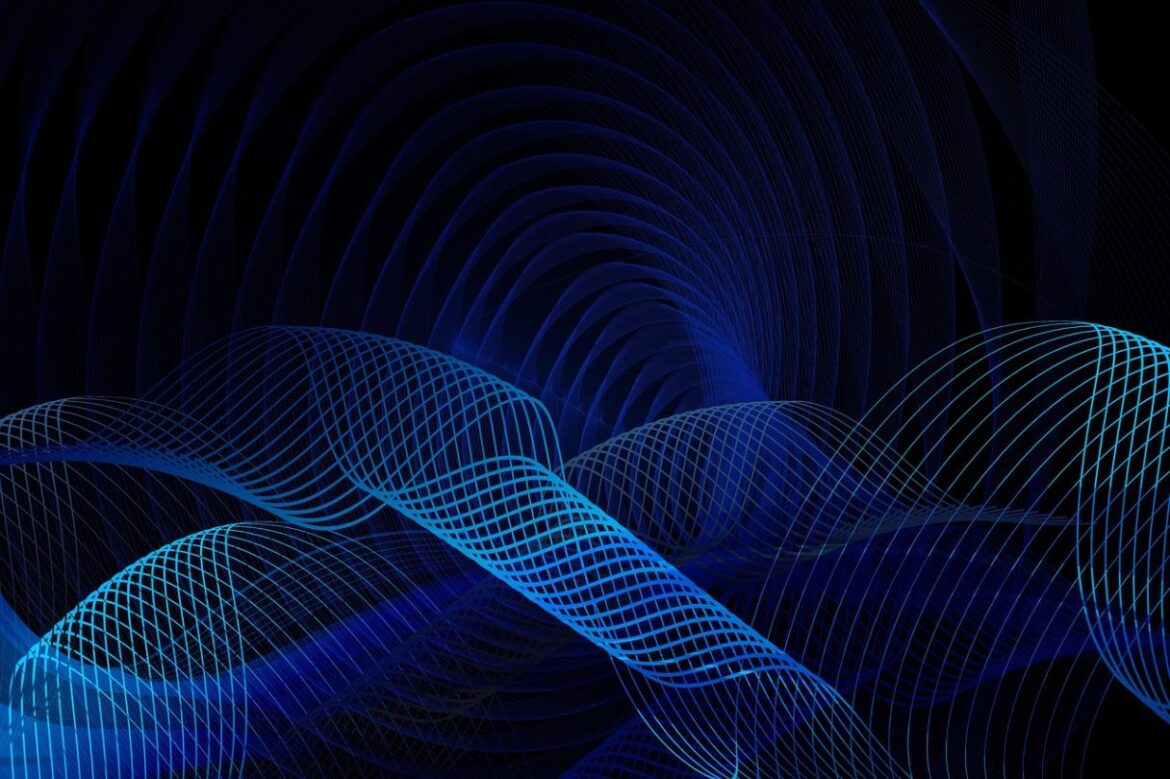TOI-5800 b, TOI-5817 b E TOI-5795 b: TRE ESOPIANETI NETTUNIANI CALDI RIVELANO NUOVI INDIZI SULLA FORMAZIONE DEI SISTEMI PLANETARI
Un team internazionale guidato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Università di Roma Tor Vergata ha confermato e caratterizzato tre nuovi esopianeti della categoria “Nettuniani caldi” — pianeti extrasolari con dimensioni e masse simili a quelle di Urano e Nettuno ma che si muovono intorno alle loro stelle su orbite molto più strette (pochi giorni invece di un centinaio di anni). Le scoperte sono state rese possibili grazie al programma Hot Neptune Initiative (HONEI) e alle misure di alta precisione effettuate con gli spettrografi HARPS all’Osservatorio La Silla dell’ESO in Cile e HARPS-N installato sul Telescopio Nazionale Galileo dell’INAF nelle Canarie, in Spagna, integrando i dati raccolti dal telescopio spaziale TESS della NASA.

Tra i tre pianeti spicca TOI-5800 b, il nettuniano più eccentrico mai osservato all’interno del cosiddetto “deserto dei Nettuniani caldi” — una regione dello spazio dove si riscontra una marcata scarsità di pianeti di dimensioni simili a quelle di Nettuno ma su orbite molto vicine alle proprie stelle, scarsità che può essere causata da diversi fenomeni, come la “migrazione planetaria”, in cui l’orbita dei pianeti viene modificata, l’evaporazione atmosferica che porta a una diminuzione delle loro dimensioni o l’interazione gravitazionale con altri corpi relativamente vicini. In particolare, questa “zona desertica” comprende pianeti con raggi da circa 3 a 7 volte quelli terrestri e periodi orbitali inferiori a pochi giorni.
Nato da una collaborazione tra ricercatori italiani e statunitensi, il programma HONEI ha come obiettivo quello di scoprire e misurare con grande precisione le masse e le altre proprietà fisiche e orbitali dei candidati “Nettuniani caldi” identificati dal satellite TESS. Tali misure permettono di selezionare i migliori target da puntare con i telescopi di nuova generazione come il James Webb Space Telescope, per determinare la composizione chimica delle atmosfere di questi pianeti. La capacità di misurare le masse con strumenti di alta precisione consente di confermare la natura planetaria di questi corpi e di valutare la loro evoluzione dinamica e strutturale. I primi risultati del programma HONEI sono stati presentati per la prima volta in due articoli scientifici appena accettati per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Come spiega Luca Naponiello, primo autore del primo articolo, ex studente di dottorato all’università di Roma Tor Vergata, ora post-doc INAF e fondatore del programma HONEI,
“TOI-5800 b è un sub-Nettuno molto vicino alla propria stella, con un periodo orbitale di soli 2,6 giorni. Ha un raggio di circa 2,5 volte quello terrestre e una massa di circa 9,5 volte quella terrestre. Ciò che ne testimonia l’unicità è l’elevata eccentricità orbitale, inusuale per pianeti con orbite così strette che, per effetto delle forze mareali, di norma si ‘circolarizzano’ rapidamente. Questa eccentricità lascia ipotizzare che il pianeta sia ancora in fase di migrazione orbitale o influenzato gravitazionalmente da un altro corpo celeste nel sistema, ancora da individuare. Inoltre, TOI-5800 b si sta progressivamente avvicinando alla sua stella, perdendo momento angolare, e in futuro potrebbe stabilizzarsi in una regione ancora più interna del deserto dei Nettuniani caldi”.

Il secondo pianeta, classificato come TOI-5817 b, ha un’orbita più ampia di circa 15,6 giorni ed è ideale per studi atmosferici grazie alla luminosità della sua stella ospite.
In un secondo articolo del programma HONEI, con prima autrice Francesca Manni, dottoranda presso il dipartimento di Fisica dell’università di Roma Tor Vergata sotto la supervisione del professor Luigi Mancini, viene presentata la scoperta di TOI-5795 b, un “super-Nettuno caldo” in orbita con un periodo di 6,14 giorni attorno a una stella povera di metalli (ovvero di elementi più pesanti dell’idrogeno e dell’elio).
Francesca Manni spiega: “L’esopianeta è stato scoperto dal satellite TESS intorno alla stella TOI-5795, a circa 162 parsec (ossia circa 528 anni luce) dalla Terra. È stato poi osservato anche con lo spettrografo HARPS, per misurare le variazioni di velocità radiale e quindi stimare la massa del pianeta. La stella è un po’ più grande del Sole ma più povera di metalli. Il pianeta ha un’orbita molto stretta e circolare, e caratteristiche da ‘super-Nettuno caldo’, ovvero massa e raggio superiori a quelli di Nettuno, ma temperature elevate”.
E aggiunge: “Questo pianeta si inserisce al confine del deserto dei Nettuniani caldi e la sua orbita quasi circolare e la composizione stellare pongono sfide ai modelli di formazione planetaria attuali, suggerendo che dinamiche successive alla formazione abbiano modellato la sua configurazione attuale”.
Naponiello sottolinea: “Dopo la scoperta del pianeta ultra-denso TOI-1853 b, confermiamo l’interesse cruciale della comunità scientifica per il deserto dei Nettuniani caldi. Questi risultati gettano nuova luce sui processi di migrazione e perdita atmosferica, fondamentali per capire la formazione di questo tipo di mondi”.
Tali risultati, ottenuti mediante l’impiego di spettrografi di eccellenza gestiti con il coinvolgimento rilevante di INAF, pongono solide basi per il futuro studio delle atmosfere planetarie con il telescopio spaziale James Webb e con telescopi terrestri di nuova generazione come l’Extremely Large Telescope (ELT), e saranno fondamentali per comprendere la diversità dei sistemi planetari e la storia evolutiva del nostro stesso Sistema solare.
Riferimenti bibliografici:
L’articolo “The Hot-Neptune Initiative (HONEI). I. Two hot sub-Neptunes on a close-in eccentric orbit (TOI-5800b) and a farther-out circular orbit (TOI-5817b)”, di L. Naponiello et al., è stato accettato per la pubblicazione online sulla rivista Astronomy & Astrophysics.
L’articolo “The Hot Neptune Initiative (HONEI) II. TOI-5795 b: A hot super-Neptune orbiting a metal-poor star”, di F. Manni et al., è stato accettato per la pubblicazione online sulla rivista Astronomy & Astrophysics.
Testi e immagini dagli Uffici Stampa dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF