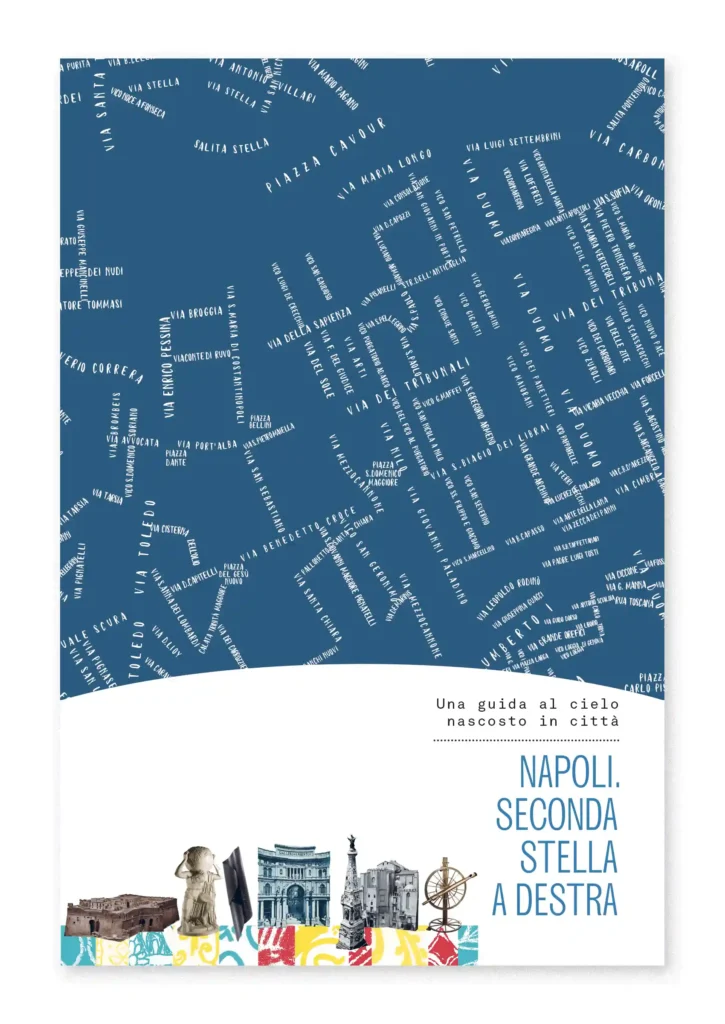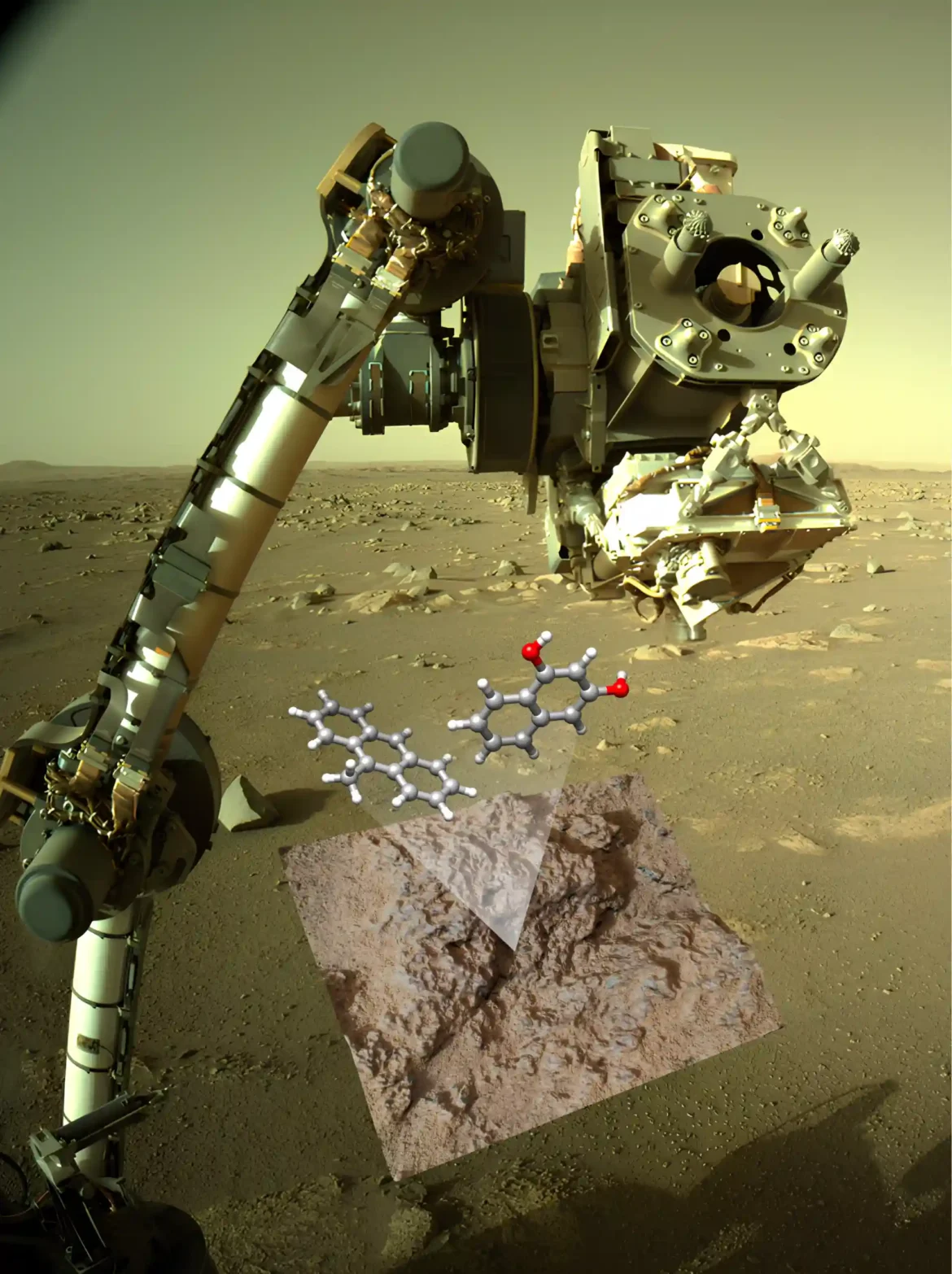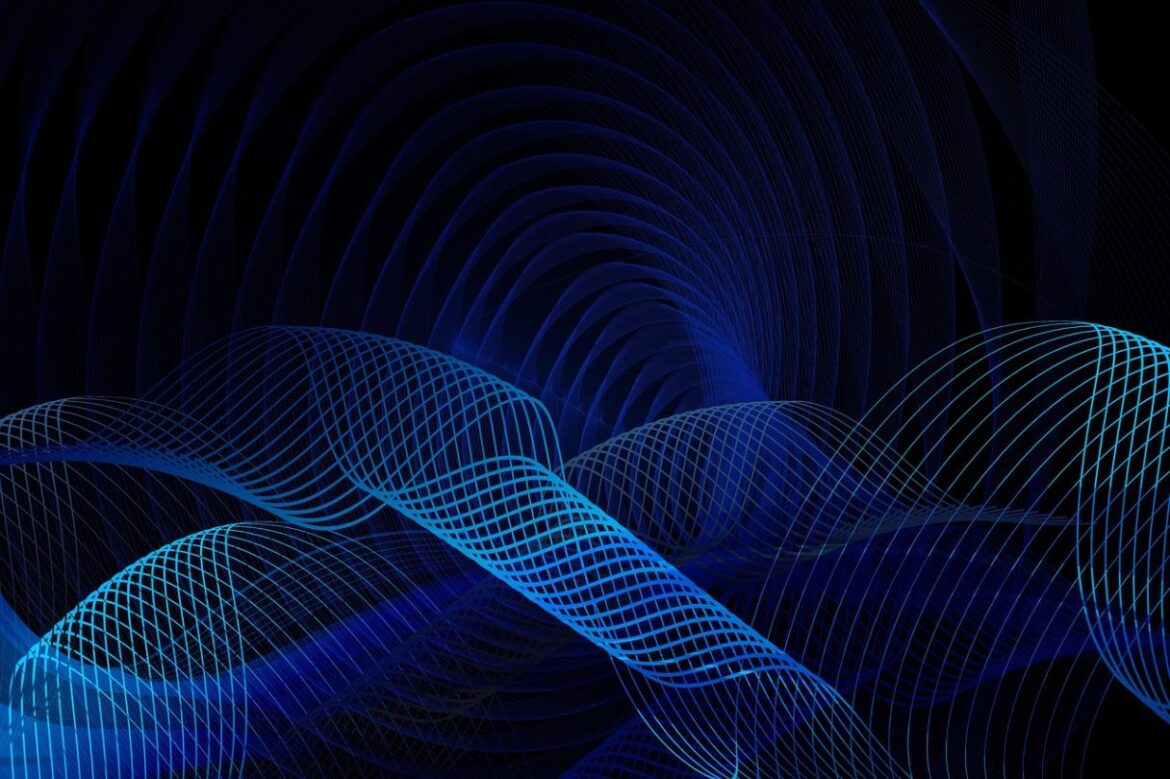EINSTEIN PROBE: RIVELATA LA COMPLESSITÀ DEI FLASH DI RAGGI X NELL’EVENTO EP241021a
Un team di ricerca, con la guida e il contributo fondamentale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha di recente analizzato nel dettaglio l’evento EP241021a, una sorgente di raggi X nota come flash di raggi X (X-Ray Flash o XRF) scoperta il 21 ottobre 2024 dalla missione cinese Einstein Probe. La ricerca, frutto di un’imponente campagna osservativa multibanda accettata per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics, getta nuova luce sull’origine e la natura di questi misteriosi e fugaci transienti cosmici, storicamente legati ai più noti lampi di raggi gamma (Gamma Ray Burst o GRB).
“Cugini” dei transienti veloci di raggi X (FXRT, dall’inglese fast X-ray transient), gli XRF sono brevissime esplosioni di raggi X, con durata che varia dai 10 secondi ai 10 minuti, prodotte da sorgenti extragalattiche. Identificati nei primi anni ’90 dal satellite italo-olandese BeppoSAX, questi eventi condividono molte caratteristiche con i lampi di raggi gamma, ma si differenziano per spettri più “soffici” e un picco energetico meno intenso. Lo strumento Wide-field X-ray Telescope (WXT) a bordo del satellite Einstein Probe, caratterizzato da una capacità unica di osservazione di vaste regioni del cielo in raggi X ad alta sensibilità, ha permesso di rivelare nuovi flash di raggi X e di studiarne in modo accurato la complessa emissione.

EP241021a si distingue per la ricchezza delle sue componenti. Giulia Gianfagna, prima autrice dell’articolo e assegnista di ricerca presso l’INAF di Roma, spiega:
“EP241021a è probabilmente l’XRF scoperto dall’Einstein Probe che presenta nella sua emissione il maggior numero di componenti, e, di conseguenza, un grado di complessità nell’interpretazione fisica non indifferente. Ma, per lo stesso motivo, è l’evento che più dà informazioni sulla famiglia di questi oggetti”.
L’evento transiente presenta, infatti, la caratterizzazione di un getto strutturato che si evolve rapidamente e un ambiente stellare denso che ne modella la forma e la dinamica. Dopo l’emissione nei raggi X scoperta da Einstein Probe, osservazioni nel visibile e soprattutto nelle frequenze radio e millimetriche, grazie all’utilizzo di telescopi e network come ALMA, uGMRT, e-MERLIN e ATCA, hanno permesso di identificare le peculiarità.
“Tutte le componenti – dice Gianfagna – sono consistenti con il collasso di una stella massiccia: subito dopo il collasso, si è creato un sistema formato da un getto centrale stretto ed energetico (detto nucleo o core), circondato da ‘ali’ a più basse energie e meno veloci. Circonda le ali un ‘bozzolo’ sferico (detto cocoon), composto a sua volta da due componenti concentriche, con velocità che diminuisce verso l’esterno. L’emissione dei raggi gamma, quindi il lampo di raggi gamma, viene prodotta dal core del getto”.
Questa emissione gamma non è però visibile in quanto il getto punta lontano dalla Terra.

Tali osservazioni sono un modello unificato secondo cui i flash di raggi X sono varianti dei lampi di raggi gamma, viste da angolazioni diverse o influenzate da condizioni ambientali peculiari, come la densità e la struttura del materiale espulso dalla stella progenitrice. EP241021a è inoltre il primo caso in cui tutte queste componenti si osservano simultaneamente con tale dettaglio.
“Terminata la missione BeppoSAX all’inizio degli anni 2000”, commenta Luigi Piro, dirigente di ricerca INAF e coautore dello studio, “osservare questi transienti è diventato molto più difficile a causa del ridotto campo di vista degli strumenti attivi. Einstein Probe, lanciato nel gennaio 2024, ha riportato in orbita un rilevatore con un ampio campo visivo e una sensibilità superiore. La capacità di osservare porzioni così ampie di cielo ci ha permesso, finalmente, di ricominciare a scoprire nuovi flash di raggi X”.
Gianfagna conclude: “Dimostrare che questo flash di raggi X può essere modellizzato come un lampo di raggi gamma, probabilmente con delle caratteristiche particolari, in un contesto più ampio porterebbe ad avere un’idea più chiara su come muoiono le stelle massicce e cosa producono dopo la loro morte”.
Lo studio in questione è il primo guidato da ricercatrici e ricercatori europei sull’analisi di eventi XRF con dati provenienti da Einstein Probe, segnando una tappa fondamentale nella collaborazione internazionale e nello studio delle esplosioni cosmiche.
Riferimenti bibliografici:
L’articolo di Giulia Gianfagna, Luigi Piro, Gabriele Bruni, Aishwarya Linesh Thakur, Hendrik Van Eerten, Alberto Castro-Tirado, Yong Chen, Ye-hao Cheng, Han He, Shumei Jia, Zhixing Ling, Elisabetta Maiorano, Rosita Paladino, Roberta Tripodi, Andrea Rossi, Shuaikang Yang, Jianghui Yuan, Weimin Yuan, Chen Zhang, “The soft X-ray transient EP241021A: a cosmic explosion with a complex off-axis jet and cocoon from a massive progenitor”, è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics.
Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF