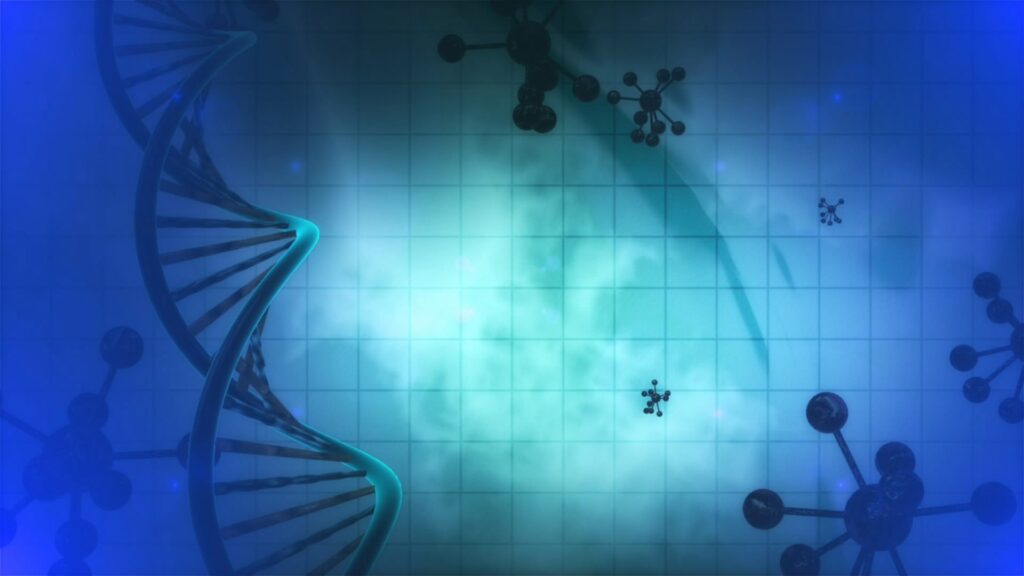Prima evidenza sperimentale del ghiaccio VII plastico, una nuova forma di ghiaccio dal comportamento dinamico
Uno studio internazionale, coordinato dalla Sapienza Università di Roma, ha dimostrato sperimentalmente l‘esistenza del ghiaccio VII plastico, la cui presenza è ipotizzata all’interno di alcune lune del sistema solare. La scoperta, pubblicata su “Nature”, apre nuove opportunità di ricerca per la comprensione dell’evoluzione strutturale dei pianeti ghiacciati.
Una fase cristallina dell’acqua che si forma a pressioni superiori a 50000 atmosfere e 300 °C: il ghiaccio VII plastico che si differenzia dalle altre forme di ghiaccio per la sua natura ibrida tra un solido e un liquido. Le molecole dell’acqua in questa fase sono disposte in un reticolo cubico denso, ma, a differenza delle altre forme di ghiaccio, sono libere di ruotare attorno alle loro posizioni d’equilibrio in modo simile a un liquido. Questo comportamento dinamico conferisce alla fase una natura plastica, la cui esistenza è stata ipotizzata da simulazioni di dinamica molecolare ma mai osservata sperimentalmente.
Il gruppo internazionale di ricerca, guidato da Livia Eleonora Bove del Dipartimento di Fisica della Sapienza, è riuscito a ottenere l’osservazione diretta dell’esistenza del ghiaccio VII plastico. Per dimostrare sperimentalmente il comportamento esotico di questa fase dell’acqua, il team di ricercatori ha utilizzato lo scattering quasi-elastico da neutroni (QENS), una tecnica che consente di misurare direttamente le proprietà rotazionali e la dinamica diffusiva in sistemi molecolari. I dati sperimentali hanno fornito fin da subito la prova dell’esistenza della fase plastica. Tuttavia, per comprendere in dettaglio il meccanismo con cui le molecole ruotano, sono stati necessari ulteriori esperimenti e il confronto con simulazioni di dinamica molecolare. A queste attività di ricerca hanno contribuito in particolare John Russo e Francesco Sciortino del Dipartimento di Fisica della Sapienza.
“Combinando dati sperimentali e simulazioni, abbiamo scoperto che le rotazioni nel ghiaccio plastico non sono completamente libere, ma piuttosto avvengono attraverso salti tra posizioni preferenziali – spiega Maria Rescigno della Sapienza, prima autrice del lavoro – Questo comportamento conferisce al ghiaccio VII plastico proprietà uniche, che lo distinguono dalle altre fasi solide dell’acqua e ne influenzano significativamente le proprietà fisiche”.
Lo studio, non solo fornisce nuove informazioni sulla natura dei legami idrogeno in condizioni estreme – fondamentali per comprendere meglio le proprietà dell’acqua e di molti altri sostanze chimiche – ma apre nuove strade per la comprensione della struttura dei corpi celesti ghiacciati e la loro evoluzione.
Un caso particolarmente interessante è quello delle due lune di Giove, Ganimede e Callisto, la cui differenziazione interna rimane una questione aperta nella planetologia. Una possibile spiegazione di tale fenomeno potrebbe dipendere dalla presenza di ghiaccio plastico in una sola delle due lune. Questa circostanza avrebbe influenzato diversamente la loro evoluzione strutturale.
La ricerca, frutto di una collaborazione internazionale che ha coinvolto ben 9 istituzioni, rappresenta un importante avanzamento nella comprensione del complesso diagramma delle fasi dell’acqua in condizioni estreme e potrebbe aprire nuove prospettive di ricerca nel campo della planetologia.

Riferimenti bibliografici:
Rescigno, M., Toffano, A., Ranieri, U. et al. “Observation of Plastic Ice VII by Quasi-Elastic Neutron Scattering”, Nature (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-08750-4
Al momento in cui si scrive, l’articolo su Nature è ancora in fase di editing.
Testo e immagine dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma