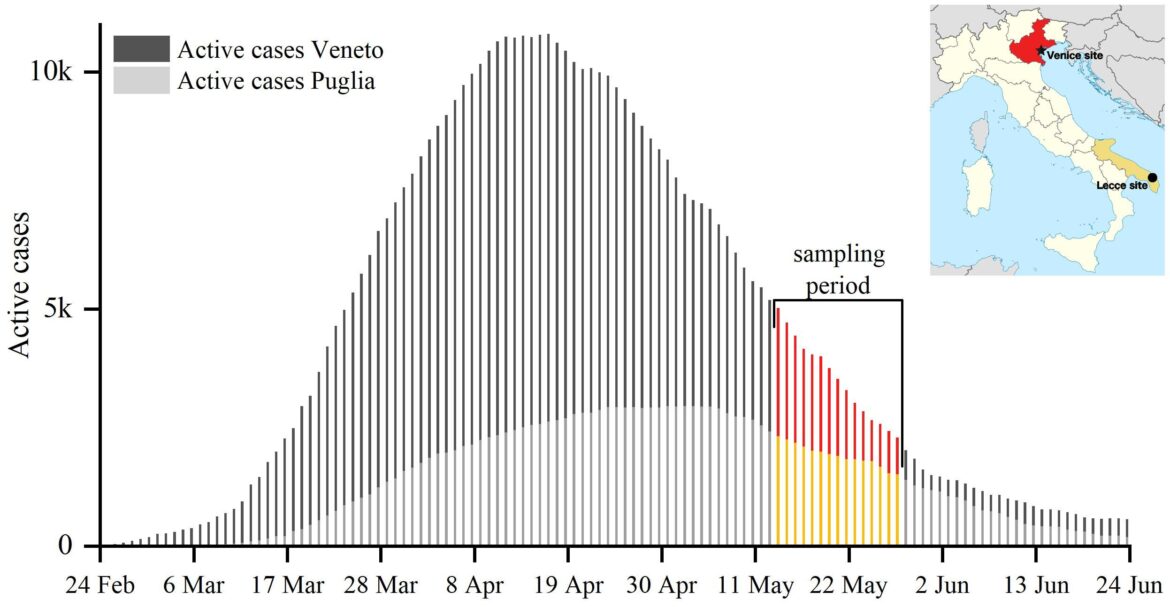Mediterraneo: precipitazioni stabili dalla fine dell’Ottocento, ma in futuro è prevista una diminuzione
Un team di ricercatori di cui fa parte l’Università Statale di Milano ha tracciato l’evoluzione delle precipitazioni nel Mediterraneo a partire dalla fine del diciannovesimo secolo. I dati mostrano una sostanziale stabilità nel passato e confermano l’affidabilità delle recenti simulazioni modellistiche nel prevedere una diminuzione nel XXI secolo. Lo studio è stato pubblicato su Nature.
Milano, 21 marzo 2025 – L’evoluzione delle precipitazioni ha importanti implicazioni per le politiche sociali, economiche e ambientali nella regione del Mediterraneo.
Ora uno studio, condotto da un gruppo internazionale di ricercatori, coordinato da Sergio Vicente Serrano del Pyrenean Institute of Ecology e Yves Tramblay dell’Istituto Francese di Ricerca e Sviluppo (French Institute of Research for Development) e con un importante contributo dell’Università Statale di Milano, dell’Università del Salento e del CNR-ISAC (Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima), ha rilevato che dal 1871 al 2020 le precipitazioni in quest’area sono rimaste sostanzialmente stabili anche se distribuite irregolarmente; tuttavia nel XXI secolo si prevede una diminuzione.
La ricerca, pubblicata su Nature, si basa su dati provenienti da 23.000 stazioni in 27 Paesi e colma una lacuna di conoscenza causata dalla mancanza di dati meteo completi, dovuta a politiche di alcuni Paesi del Mediterraneo non favorevoli a mettere in comune le serie osservative del passato. Questo problema è stato risolto sviluppando un metodo di lavoro innovativo che ha permesso elaborazioni svolte in modo distribuito, ma basate su un unico pacchetto di codici di analisi dati, senza che i singoli Paesi coinvolti dovessero condividere i dati originali.
Lo studio mostra che nel passato le precipitazioni nella regione sono state caratterizzate da una forte variabilità spaziale e temporale, ma sono rimaste fino ad ora in gran parte stabili nel lungo termine. Secondo i ricercatori, le tendenze che possono essere identificate per alcune aree e periodi sono attribuibili alle dinamiche collegate alla variabilità interna del clima. Inoltre evidenziano come le più recenti simulazioni modellistiche (prodotte nel Progetto internazionale CMIP 6) trovino conferma nelle osservazioni. Pertanto, i risultati del progetto attestano l’affidabilità dei modelli e dell’attesa futura diminuzione delle precipitazioni per la regione mediterranea.
“Questo accordo tra le simulazioni modellistiche e le osservazioni sulla stabilità delle precipitazioni nel passato rafforza l’affidabilità delle previsioni di una futura riduzione delle piogge. Questa riduzione è molto preoccupante perché la regione del Mediterraneo sta già attraversando un periodo di crescente aridità climatica, causata dall’aumento dell’evaporazione dovuto al forte incremento delle temperature. Temiamo quindi che nei prossimi decenni si aggraverà la scarsità delle risorse idriche e l’aridità nella regione”,
conclude Maurizio Maugeri, docente del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università Statale di Milano e tra i primi firmatari dello studio insieme al professor Piero Lionello del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento.
Riferimenti bibliografici:
Vicente-Serrano, S.M., Tramblay, Y., Reig, F. et al. High temporal variability not trend dominates Mediterranean precipitation, Nature 639, 658–666 (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-024-08576-6

Testo dall’Ufficio Stampa Direzione Comunicazione ed Eventi istituzionali Università Statale di Milano