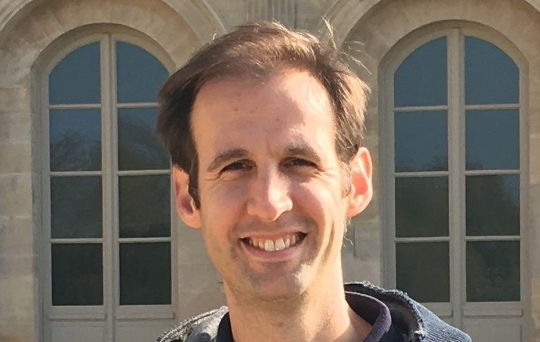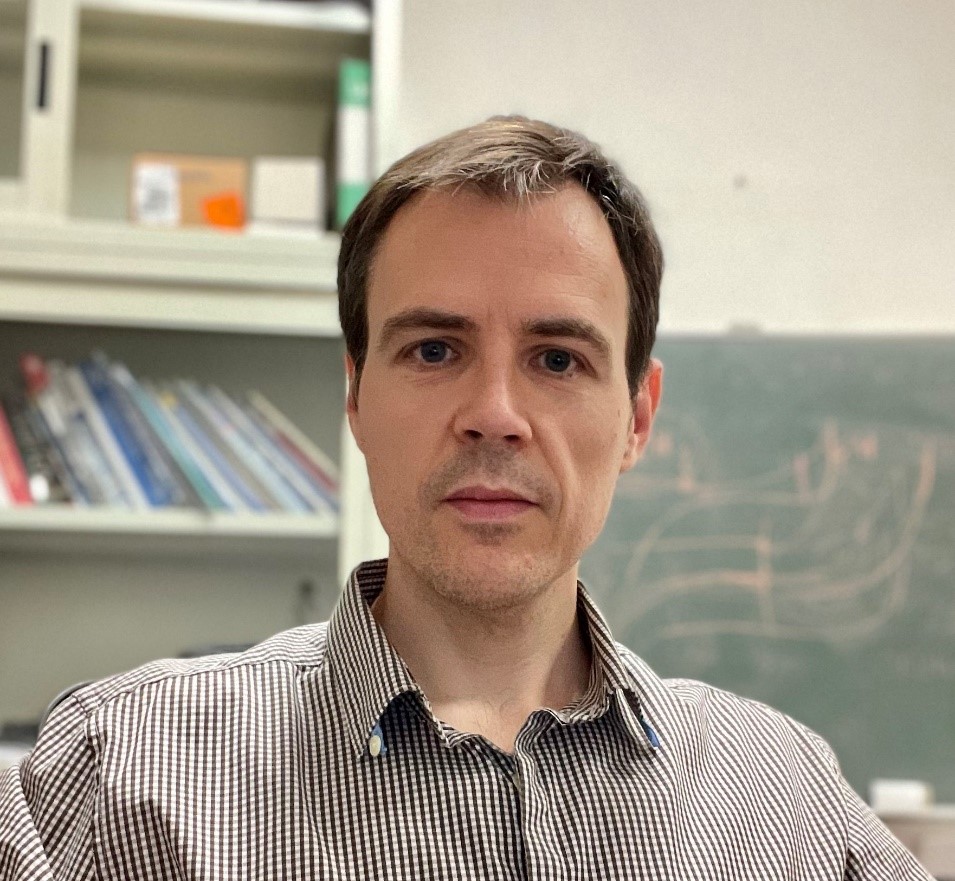Sviluppato il più grande database di genomi microbici da alimenti, curatedFoodMetagenomicData: servirà per migliorarne qualità, sicurezza e sostenibilità; lo studio europeo del progetto MASTER è stato realizzato anche con il Dipartimento di Agraria della Federico II. Pubblicato ieri sulla rivista Cell.

Uno studio guidato anche dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha sviluppato un database fondamentale per la caratterizzazione degli alimenti da dati metagenomici, aprendo nuovi scenari per migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità degli alimenti.
Il database più vasto di metagenomi da alimenti è stato sviluppato dal progetto MASTER, finanziato dall’Unione Europa. Il relativo articolo scientifico intitolato “Unexplored microbial diversity from 2,500 food metagenomes and links with the human microbiome” è stato pubblicato il 29 agosto 2024 sulla rivista Cell.

La risorsa curatedFoodMetagenomicData (cFMD) rappresenta un database fondamentale per lo studio dei metagenomi (il termine che definisce il materiale genomico proveniente da tutti i microrganismi presenti in un ambiente) derivati dagli alimenti. Uno strumento che permetterà di affrontare sfide globali come lo spreco alimentare e la resistenza antimicrobica, aumentando al contempo la sicurezza alimentare attraverso lo studio dei microrganismi che caratterizzano un ambiente.
Il professore Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dichiara: “La disponibilità di un database così vasto, comprendente metagenomi e genomi da alimenti, rappresenterà una risorsa molto importante per studiare la presenza e il ruolo dei microrganismi negli alimenti e nei processi di lavorazione degli alimenti, con l’obiettivo finale di migliorarne la qualità, la sicurezza e la sostenibilità.” Il prof. Edoardo Pasolli dello stesso Dipartimento aggiunge: “cFMD sarà la base per lo sviluppo di database metagenomici da alimenti ancora più completi, che potranno essere integrati con particolari tipologie di alimenti o aree geografiche ancora poco rappresentante.”
Il coordinatore del progetto MASTER, il professore Paul Cotter (Teagasc, Irlanda) afferma: “cFMD è un grande database di dati metagenomici alimentari, rappresentativo di 15 categorie di alimenti provenienti da 50 paesi. cFMD contiene dati relativi a 3,600 specie microbiche diverse, di cui 290 sono specie nuove. È disponibile gratuitamente per poter essere utilizzato per studi sul microbioma e per applicazioni nell’industria alimentare. Ad esempio, per studiare la componente microbica lungo l’intera catena alimentare, studiare la diffusione di geni di resistenza agli antibiotici, rilevare microrganismi indesiderati e investigare la possibile trasmissione di microrganismi all’uomo. La disponibilità di cFMD rappresenta un importante sviluppo verso un futuro in cui il sequenziamento metagenomico potrebbe sostituire la microbiologia classica come strumento più accurato e rapido per il tracciamento dei microrganismi lungo la catena alimentare.”
Il professore Nicola Segata dell’Università di Trento aggiunge: “Questa risorsa è fondamentale anche per comprendere come il microbioma alimentare potrebbe influenzare la salute umana, poiché alcuni dei microrganismi che introduciamo con la dieta potrebbero diventare membri stabili del nostro microbioma. Abbiamo scoperto che le specie microbiche associate agli alimenti compongono circa il 3% del microbioma intestinale nella popolazione adulta, suggerendo che alcuni dei nostri microrganismi intestinali potrebbero essere acquisiti direttamente dal cibo, o che storicamente, le popolazioni umane abbiano ottenuto questi microbi dagli alimenti e poi questi microbi si siano adattati per diventare parte del microbioma umano. Gli alimenti sono quindi cruciali per la nostra salute anche per i microrganismi che forniscono al nostro microbioma.”
I microrganismi presenti negli alimenti possono avere sia un impatto positivo sulla produzione alimentare, come nel caso della produzione di formaggi e bevande alcoliche, sia un impatto negativo, come nel caso del deterioramento o delle malattie di origine alimentare. Fino a poco tempo fa, l’analisi di questi microrganismi si basava principalmente su approcci tradizionali. L’applicazione di metodi basati sul sequenziamento del DNA ha il potenziale di trasformare le analisi alimentari, consentendo analisi rapide e simultanee di tutti i microrganismi in parallelo, inclusi quelli difficili da coltivare.
Il database rappresenta un grande risultato per la ricerca sul microbioma negli alimenti. È stato reso possibile grazie al sequenziamento di circa 2000 campioni raccolti in aziende alimentari in tutta Europa, che aggiunti a collezioni globali esistenti ha portato l’analisi complessiva a 2500. La risorsa, ad accesso libero, faciliterà lo studio dei microrganismi alimentari a livello globale su larga scala, sia in ambito accademico che industriale.
Il Progetto MASTER
MASTER, acronimo di “Microbiome Applications for Sustainable food systems through Technologies and EnteRprise”, è un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di Horizon 2020. Iniziato a gennaio 2019, ha visto il coinvolgimento di 29 partner con l’obiettivo di caratterizzare i microbiomi in diversi ambienti alimentari e non alimentari utilizzando tecnologie di sequenziamento innovative. Lo studio è stato guidato da team dell’Università di Napoli Federico II e dell’Università di Trento (Italia), in collaborazione con Teagasc (Irlanda), Consiglio Superiore di Ricerca Scientifica e Università di León (Spagna), MATIS (Islanda) e FFoQSI (Austria), in aggiunta a molti altri partner.
Riferimenti bibliografici:
Carlino et al., “Unexplored microbial diversity from 2,500 food metagenomes and links with the human microbiome”, Cell, DOI: 10.1016/j.cell.2024.07.039
Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Rettorato Università degli Studi di Napoli Federico II.