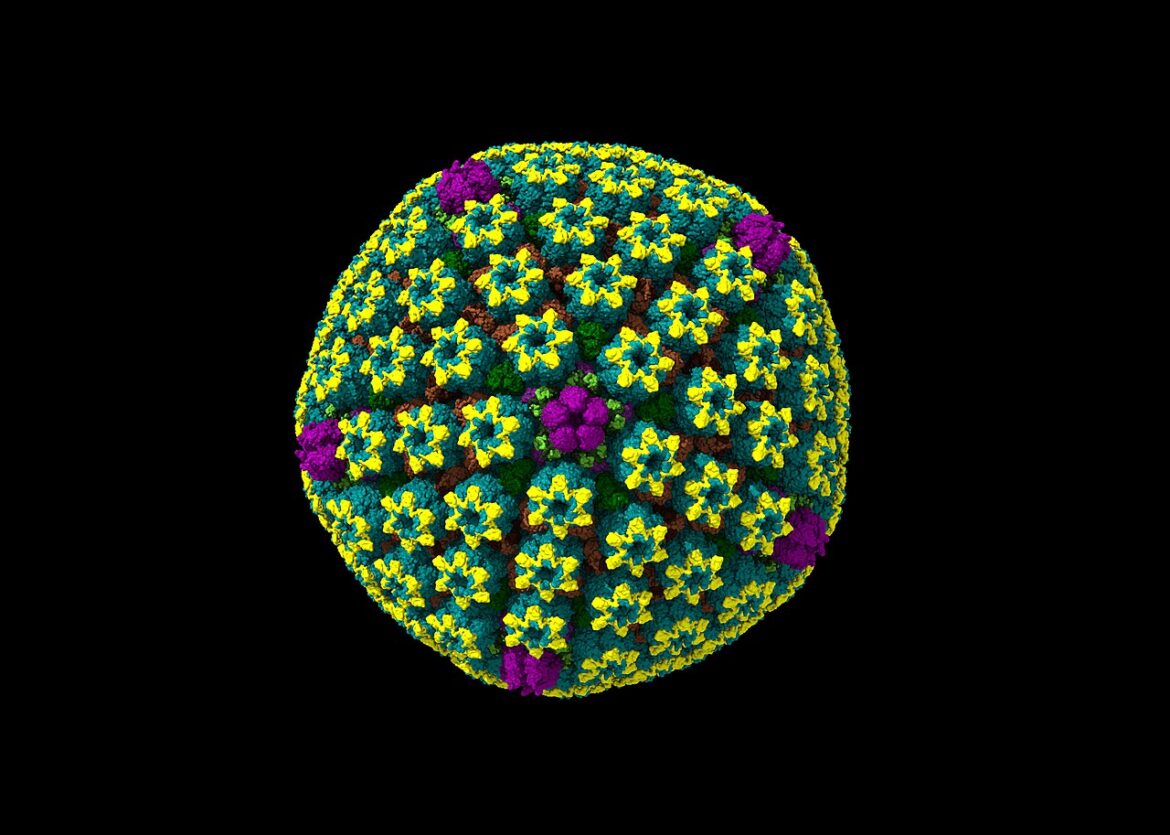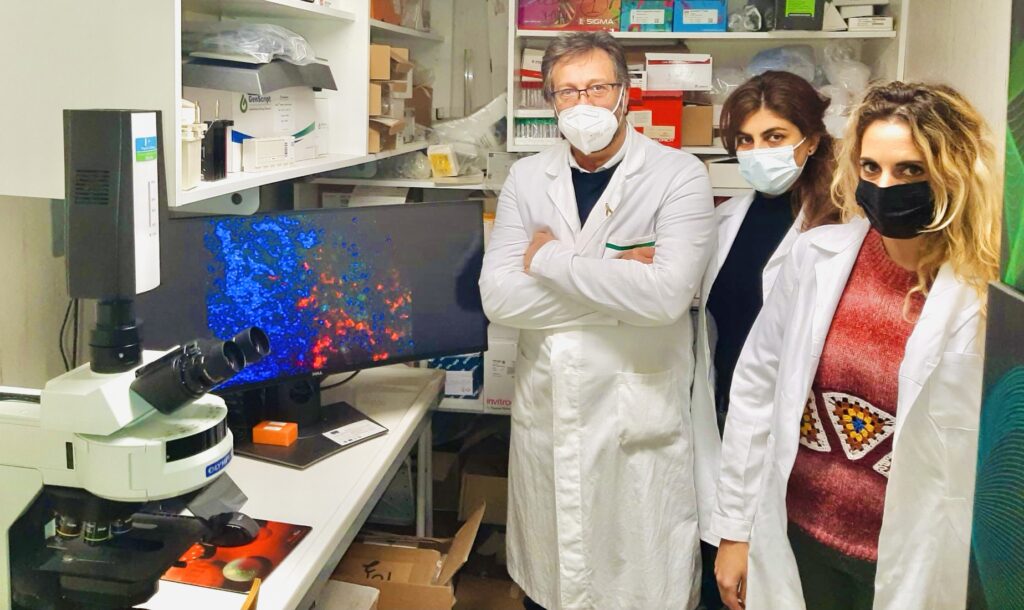Un Asteroide colpirà i tumori del seno e della tiroide
Asteroid è l’acronimo di un nuovo studio frutto della collaborazione tra diversi gruppi di ricerca italiani e valutato dal Mur miglior progetto per il suo settore nell’ambito dei Prin 2020

Studi recenti hanno documentato una frequente associazione tra l’insorgenza e l’aggressività dei tumori ormonosensibili, quali il tumore al seno e il tumore alla tiroide, e i contaminanti ambientali. E questo rappresenta il punto di partenza di Asteroid, nuovo progetto finanziato dal ministero dell’Università e della ricerca (Mur) nell’ambito del bando Prin 2020 e valutato come miglior progetto (primo classificato nel settore ERC LS3).
Lo studio è condotto da un team di ricercatrici e ricercatori di diverse università con competenze complementari ed interdisciplinari.
Il coordinatore è Michele Milella, responsabile della Sezione di Oncologia medica del dipartimento di Medicina dell’ateneo di Verona che metterà a disposizione le sue competenze negli studi clinici e traslazionali nel carcinoma mammario, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli.
L’università di Siena con Maria Grazia Castagna del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze contribuirà allo studio clinico dei carcinomi della tiroide.
L’università di Roma Tor Vergata con Roberto Bei del dipartimento di Scienze cliniche e medicina traslazionale svilupperà e caratterizzerà modelli preclinici dei due tumori per l’analisi degli effetti dei contaminanti ambientali e dei loro target molecolari per definire nuove strategie terapeutiche.
Silvia Migliaccio del dipartimento di Scienze motorie umane e della salute dell’università Roma Foro Italico si occuperà dell’impatto dell’ambiente e degli stili di vita, con particolare riguardo agli aspetti nutrizionali e dell’attività fisica.
La Sapienza Università di Roma con Elisabetta Ferretti del dipartimento di Medicina sperimentale – dipartimento che ha ricevuto altri 6 finanziamenti nell’ambito dello stesso bando – coordinerà l’analisi di nuovi biomarcatori circolanti e la caratterizzazione molecolare e cellulare mediante tecnologie “omiche”, sia dei modelli preclinici che dei campioni clinici.
Lo studio intitolato “Gene/environment interactions in breast and thyroid cancers: defining the biological role of and actioning endocrine disruptors and lifestyle to develop rational therapeutic/preventive interventions (Asteroid)” si occuperà di analizzare la complessa interazione tra geni e ambiente in questi due tumori. In particolare, saranno valutati il ruolo degli inquinanti ambientali e dello stile di vita sia nell’insorgenza sia nella modulazione dell’aggressività dei tumori. La ricerca partirà con un’analisi retrospettiva e prospettica in pazienti affette da tali tumori nelle quali saranno messe in evidenza le correlazioni tra gli aspetti genetici di ciascun tumore e lo stile di vita delle pazienti. Inoltre, saranno definiti i meccanismi molecolari di azione degli inquinanti ambientali in modelli preclinici dei diversi tipi di tumore. Sulla base dei risultati ottenuti saranno testati i cambiamenti biologici indotti da un intervento strutturato sullo stile di vita incentrato sulla consulenza nutrizionale e sull’esercizio fisico adattato per le pazienti affette da questi tumori.
Il progetto avrà delle importanti ricadute in quanto fornirà diverse innovazioni, collegando l’esposizione a sostanze inquinanti ambientali a biomarcatori, nuovi bersagli molecolari, stili di vita in due patologie ad elevata incidenza (tumore del seno e della tiroide). I risultati dello studio potranno essere utilizzati in diagnostica, applicazioni terapeutiche, preventive ed economico-sanitarie con ricadute sul Servizio sanitario nazionale.
“Il progetto è di estremo interesse sia scientifico che clinico/applicativo e consentirà di definire nuove strategie di intervento oncologico “di precisione” nei tumori della mammella e della tiroide – spiega il professor Milella – La proposta progettuale è frutto di una collaborazione già esistente tra ricercatrici e ricercatori di diversi atenei e trae vantaggio dalla costituzione nell’ateneo veronese di un team di ricerca multidisciplinare afferente ai dipartimenti di Medicina e di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento (Team Force: Focus on research and care) dedicato a studiare l’impatto di nutrizione, benessere psicologico ed esercizio fisico nelle patologie oncologiche. Il finanziamento ricevuto dal Mur sosterrà questa importante ricerca, condotta in collaborazione con la Breast Unit e la Usd di Chirurgia endocrina dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui) di Verona, contribuendo a fornire una solida base razionale per azioni di cura e di prevenzione in questi tumori”.
“Oggi – aggiunge la professoressa Ferretti – nell’era della medicina di precisione, siamo chiamati a sviluppare trattamenti personalizzati nelle patologie oncologiche che vedono al loro interno gruppi eterogenei di pazienti.
In questo contesto il mio laboratorio ha studiato l’uso di Rna non codificanti circolanti, in particolare microRna, come biomarcatori non invasivi in diversi tipi di tumori.
L’implicazione traslazionale del completamento con successo del progetto risiede nell’identificazione di nuovi bersagli patogenetici, diagnostici, terapeutici ed anche di nuovi biomarcatori, quali ad esempio i microRna, derivati da biopsia liquida che rappresentano uno strumento fondamentale per la stratificazione di pazienti costituendo così la base per un approccio terapeutico personalizzato”.
Riferimenti:
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2292-del-01-10-2021
Testo e foto dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma e dall’Area Comunicazione – Ufficio Stampa dell’Università di Verona.