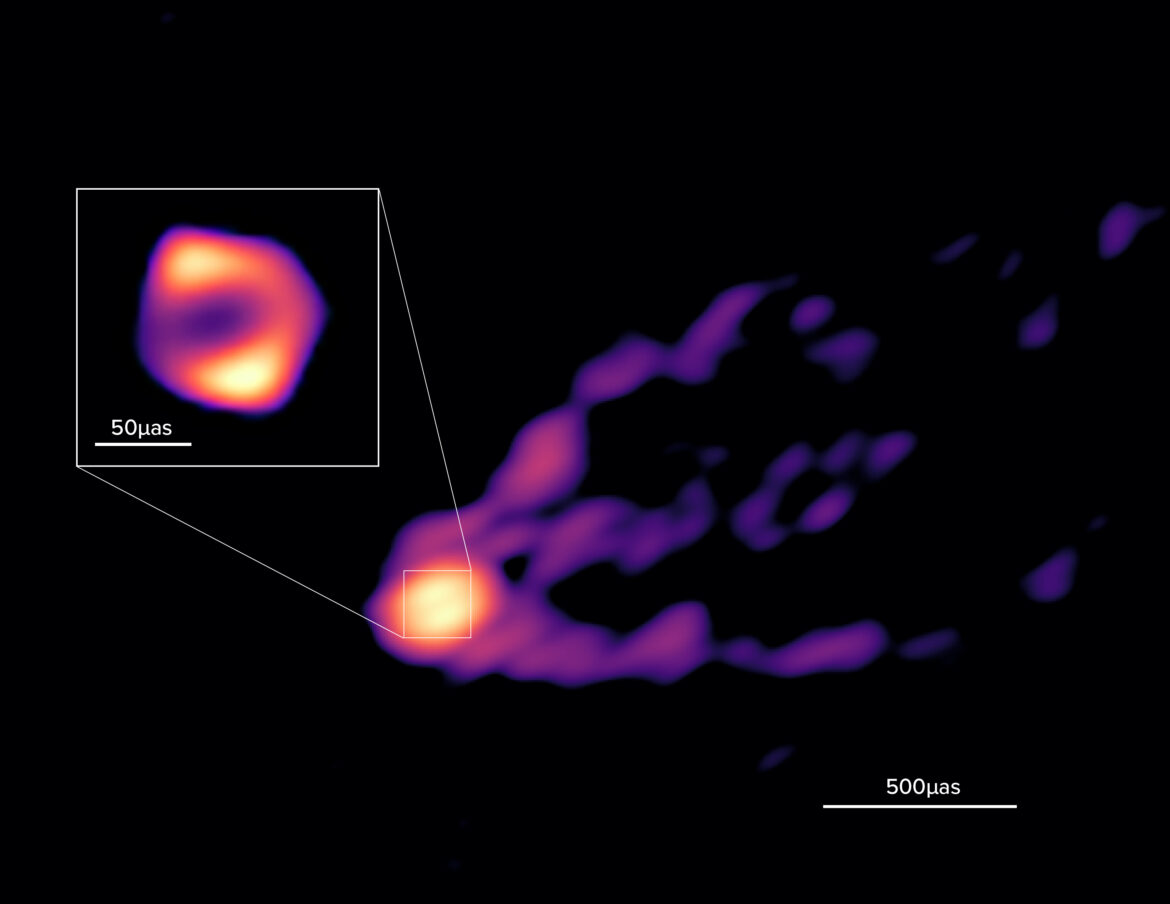Evoluzione della Terra: come sono cambiati nel tempo i livelli di ossigeno e la temperatura interna del nostro pianeta
Un nuovo studio del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza di Roma e dell’Istituto di Oceanologia dell’Accademia Cinese delle Scienze fornisce una nuova prospettiva per comprendere come è cambiata nel tempo la composizione atmosferica terrestre. I risultati dello studio sono pubblicati su Nature Communications.
I livelli di ossigeno del mantello terrestre controllano la formazione e il movimento degli elementi leggeri al suo interno (idrogeno, carbonio e zolfo), influenzando fenomeni geologici come l’attività vulcanica, la tettonica delle placche e la composizione dell’atmosfera.
La ricerca sulla capacità dell’ossigeno di guidare tali reazioni chimiche, ovvero la fugacità dell’ossigeno (fO2), si concentra principalmente sullo studio della composizione chimica delle lave più antiche (komatiti e picriti) formatesi in aree profonde della Terra sino a circa 250 km.
Per confrontare direttamente le caratteristiche dell’ fO2 dei magmi formatisi in tempi e profondità diverse, Vincenzo Stagno della Sapienza Università di Roma in collaborazione con il Dr. Zhang e colleghi dell’Istituto di Oceanologia dell’Accademia Cinese delle Scienze (IOCAS) hanno proposto un nuovo parametro, definito “fugacità potenziale dell’ossigeno” che, insieme a delle stime precise di profondità e temperatura di un ampio dataset di rocce vulcaniche risalenti da più di 3 miliardi di anni fa ad oggi permettono di comprendere come la composizione atmosferica terrestre si sia evoluta nel tempo geologico.
Diversamente da quanto dimostrato da studi precedenti secondo cui l’aumento della fO2 del mantello sin dall’Archeano fosse avvenuto gradualmente in risposta a processi di subduzione della crosta terrestre o di segregazione del nucleo metallico, questo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, rivela che l’aumento di fO2 dei magmi derivati dal mantello terrestre è stato causato da un lento raffreddamento dell’interno della Terra, con conseguente diminuzione della profondità alla quale si sono formati i magmi negli ultimi 4 miliardi di anni. L’aumento dei livelli di ossigeno dell’interno del pianeta ha modificato la chimica dei gas vulcanici e, quindi, la composizione dell’atmosfera.
“Le variazioni nella fO2 dei magmi derivati dal mantello sin dall’ Adeano sono principalmente dovute a cambiamenti nella profondità e temperatura alla quale i meccanismi di fusione avvenivano”, spiega Vincenzo Stagno del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza. “La composizione chimica dell’atmosfera e’ una diretta conseguenza dei livelli di ossigenazione dell’interno della Terra sin dalla sua origine, e questo può aiutare a capire in quali pianeti possa esserci stata vita”.
Decifrare l’evoluzione dello stato di ossigenazione del mantello terrestre sin dall’Adeano è fondamentale per comprendere importanti questioni scientifiche come il ciclo profondo del carbonio, l’evoluzione della composizione atmosferica e le origini della vita, ma anche le analogie e le diversità tra i pianeti dello stesso sistema solare.

Riferimenti bibliografici:
The constant oxidation state of Earth’s mantle since the Hadean – Fangyi Zhang, Vincenzo Stagno, Lipeng Zhang, Chen Chen, Haiyang Liu, Congying Li, Weidong Sun, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-024-50778-z.
Testo dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma